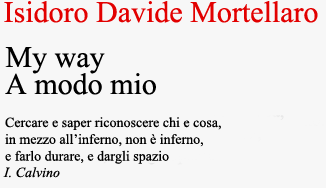Il mondo dell'art. 11, in «Quale Stato», n. 1-2, 2008, pp. 193-211.
 Il mondo dell’art. 11
Il mondo dell’art. 11
Perturbazioni
E’ tempesta. Sui cieli e nelle capitali d’Europa continua ad esser tempesta non appena la parola passa agli elettori, ai cittadini. Adesso il vento flagella dai mari d’Irlanda e nell’occhio del ciclone referendario è finito quel rifacimento del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” già caduto nel 2005 sotto il giudizio dei popoli di Francia e Olanda. A Lisbona avevano provato a renderlo meno epocale e più appetibile, provando però a salvarne la sostanza. Il piatto – due Trattati, per un totale di 418 articoli, 65 dichiarazioni, 13 allegati – è però apparso indigesto alla maggioranza degli irlandesi, adusi da tempo ad esprimere il proprio parere vincolante sulle modifiche costituzionali prodotte da nuovi obblighi internazionali.
Ad imporre il cambio di passo aveva provveduto la Corte suprema irlandese, con una sentenza del 1987, contraria alla ratifica dell’Atto Unico Europeo in assenza di una specifica consultazione popolare. Si era così dovuto ricorrere ad un referendum popolare, sugellato da una forte affermazione dei favorevoli alla ratifica. Iter e risultati quasi identici anche nel caso della ratifica dei Trattati cosiddetti di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1998). Altri tempi. Allora la «Tigre irlandese» si ergeva rampante, forte dei processi globali di delocalizzazione che la selezionavano come terminale privilegiato degli investimenti esteri di tante multinazionali in informatica, farmaceutica, elettronica di consumo, high-tech. E a far sì che non fossero solo il costo del lavoro, l’anglofonia e la generosissima politica governativa di detassazione e liberalizzazione a far da specchietto, provvedeva l’Europa, allora benigna nutrice: dal 1973 in poi oltre 40 miliardi di euro hanno finanziato l’ammodernamento del paese, delle sue infrastrutture così come del suo sistema scolastico e scientifico. Il paese cessava di esportare braccia e cervelli negli USA o di servire da deposito delle tre B (Butter, Beer e Beef) per la vicina Inghilterra. Il «Made in Eire» correva ora per il mondo e soprattutto per l’Europa continentale, divenuta piattaforma per success-story come Ryanair o mercato per il 70% delle esportazioni isolane: dal Viagra al Botox ai chip Intel. L’effetto più eclatante quello segnato dal reddito pro-capite: nel 1973 al momento dell’ingresso nella CEE era il più basso. Ora resiste secondo nell’Unione a 27 dietro quello dei Lussemburghesi.
E’ al passaggio di millennio che si colloca un sensibile mutamento dello spirito nazionale nei confronti dell’UE. Un primo segnale si era avuto rispetto al trattato di Nizza, comprensivo della Carta dei diritti. Nel corso del 2002 c’era voluto un secondo referendum perché il tutto fosse approvato. Avevano già cominciato a pesare, oltre che il rallentamento dei tassi di crescita, interrogativi straordinari su una contaminazione col mondo sempre più governata dall’Unione europea. Abituati ad andare per il globo gli Irlandesi ora vedevano l’isola divenire calamita per una formidabile immigrazione dall’Est Europa. Contemporaneamente il dibattito nazionale si infittiva di interrogativi e prove referendarie su temi straordinariamente scottanti per la sensibilità nazionale - divorzio, aborto, unioni di fatto – o per la posizione di neutralità tradizionalmente rivendicata sulla scena internazionale.
Il tutto era destinato a far massa quando il referendum sul trattato di Lisbona ha sospeso i suoi interrogativi ad un tornante particolarmente turbolento della storia nazionale: il paese si appresta, proprio in forza dei suoi ritmi di crescita, a divenire contributore netto di una Unione in cui un domani - per effetto delle modifiche istituzionali relative alla Politica estera e alla composizione della Commissione europea - si farebbe problematico prender voce e partecipare a decisioni comuni progressivamente slargate a campi sempre più vasti. Ed è sulla perdita di controllo che ha battuto il chiodo una propaganda euroscettica rafforzata dalla discesa in campo di Murdoch con la sua editoria gridata, a forte presa popolare. A sinistra le preoccupazioni dei sindacati per le sorti dei servizi pubblici e della contrattazione sono state come centuplicate dal tempismo di direttive quali quelle sull’orario di lavoro, assunte dalla Commissione europea proprio mentre la campagna referendaria entrava nel vivo. A quadrare il cerchio ci si è messo stolidamente tutto il sistema politico, particolarmente disposto in ogni sua componente – tranne la pattuglia del Sinn Fein – a chiudersi a riccio in difesa del Trattato e dell’Europa con la postura delle tre scimmiette decise a non vedere, sentire, parlare.
Gl Irlandesi, ammettendo in genere di non comprendere appieno la posta in gioco, hanno così optato per un sano, seppur variegato, “No preventivo” che, non a caso, ha registrato i suoi picchi più alti in tutte le circoscrizioni popolari. Una affluenza alle urne molto più alta di quelle registrate nelle altre tornate referendarie – il 53,1% degli elettori odierni paragonati al 35% del 2001 – fa infine giustizia di ogni interpretazione fondata sull’interessata valorizzazione di disinteresse e astensionismo.
Al cuore d’Europa s’approfondisce una frattura tra popoli ed élites che smentisce ogni fede nel credo funzionalista posto storicamente alla base della integrazione comunitaria. La crescente condivisione di interessi non basta. Non spinge automaticamente ad un approfondimento comunitario, a mutarlo in fratellanza. Al massimo ci si può sentir coinvolti in una comunità di destino tenuta assieme da legacci, non da legami. Si finisce così magari per individuare nell’euro – pietra angolare dell’Unione - la fonte non del benessere ma della disintegrazione. La ripulsa finisce per avere la meglio. In Irlanda ancora una volta ha fallito l’«Europa ad una dimensione», schiacciata attorno al suo regolo monetarista.
Un caso italiano
In olimpico distacco da queste turbolenze e mentre già le gazzette d’ogni dove si infittivano di succosi sondaggi sugli orientamenti improvvisamente allarmanti del popolo irlandese, in Italia il 30 maggio il Consiglio dei Ministri approvava – su proposta del ministro degli Esteri - il disegno di legge per la ratifica del Trattato di Lisbona. A pochi giorni dalla sua quarta reincarnazione, il governo Berlusconi provava evidentemente a vantare stimmate di netto europeismo.
A velare però tanta serena determinazione hanno immediatamente provveduto le notizie sulle riserve avanzate, nel summit governativo, dalla delegazione leghista. Troppe e troppo profonde le rinunce di sovranità contemplate da questa Costituzione europea mascherata. Non si può varcare l’ennesimo Rubicone di soppiatto. Che si chiami il popolo sovrano ad approfondire riflessione e discussione. A decidere, magari attraverso un referendum. E poiché fa ostacolo l’art. 75 della Costituzione, con la proibizione di pronunciamenti referendari su fisco e ratifiche di trattati, allora sarà la Lega stessa a farsi promotrice di una apposita legge costituzionale volta a permettere la consultazione referendaria.
Nulla di nuovo sotto il sole. Già nella XIV legislatura, ai primi del 2002, vari deputati leghisti avevano depositato alla Camera – primo firmatario l’on. Alessandro Ce’ – una proposta di modifica costituzionale dell’art. 11 indirizzata in tal senso e vagamente ispirata al lavoro condotto in materia, durante la XIII legislatura, in sede di Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. A dimostrare inoltre quanto sentito sia il tema stanno altre proposte di legge costituzionale. Anch’esse sono volte a modificare nella stessa direzione l’art. 11 e sono state depositate nei primi giorni della legislatura dall’ex presidente della Repubblica, sen. Cossiga, o da vari deputati, valdostani e sud-tirolesi, preoccupati per un possibile allargamento dell’UE alla Turchia.
Più in generale, l’Unione europea si è da subito rivelata un doganiere occhiuto e soprattutto scomodo del governo Berlusconi. Non c’è stato provvedimento della nuova coalizione di centrodestra – dall’emergenza Alitalia a quella dei rifiuti campani, alle iniziative in tema di sicurezza pubblica, immigrazione, fiscale ecc. – che non abbia subito impattato, in nome di uno stato di eccezione variamente presunto o vantato, con le normative o con ammonimenti e censure delle istituzioni comunitarie. Il che, da un lato, conferma il grado di cogenza e invasività del diritto comunitario; dall’altro, rivela la caratura profondamente anti-europeistica del governo Berlusconi. Del resto, a evidenziarla a tutto tondo aveva già provveduto, durante la campagna elettorale, quel vero e proprio manifesto politico-programmatico presentato sotto forma di pamphlet da Giulio Tremonti, a nome di una Europa cristiana, romantica e schiettamente sanfedista: irsuta verso il mondo e l’’altro’, ma pronta a rinverdire e approfondire il tradizionale atlantismo[1].
A rendere ancora più mosso il panorama si sono aggiunti gli annunci da Francoforte della BCE circa la necessità di una ulteriore stretta sui tassi di interesse nel tentativo di governare il riaccendersi delle spinte inflattive. A dispetto del quasi unanime giudizio che fa ascendere i nuovi picchi dei prezzi alle tensioni esercitate sulle materie prime dalla corsa dei nuovi giganti asiatici e dalla morsa della nuova speculazione finanziaria, l’Europa dichiara il suo assoluto rispetto della legge suprema che la incatena alla stabilità dei prezzi.
Tempi così procellosi e incerti dovevano forse lasciar segni ben più visibili. In realtà si rimane stupiti quando finalmente si riesce a leggere la relazione di presentazione del progetto di ratifica dei Trattati di Lisbona, così come risulta sul sito del Senato a partire dall’11 giugno, giorno della sua presentazione (atto del Senato n. 759). In fondo al testo spicca un’avvertenza: «Il presente disegno di legge costituisce la ripresentazione dell’analogo provvedimento presentato dal Governo nel corso della XV legislatura (Atto S.1956) che non ha potuto terminare l’iter parlamentare a causa dell’anticipato scioglimento delle Camere». Mentre l’Europa in tutte le sue sfaccettature ed invadenze emerge come terreno principe della contesa tra governo ed opposizione, il governo Berlusconi dichiara di vivere l’ingresso nella nuova Europa disegnata a Lisbona con le stesse intonazioni e parole, con gli stessi gesti già usati dal Governo Prodi nel disegno di legge presentato al Senato il 17 gennaio 2008. Vagando nel testo della presentazione, si può così scegliere a caso. Colpisce in particolare un rilievo: «E’ da notare che, sebbene su richiesta francese, rispetto al Trattato costituzionale tra gli obiettivi dell’Unione non figuri più il riferimento alla “concorrenza libera e non falsata” in relazione al mercato interno, la concorrenza continua a figurare tra le competenze dell’Unione, rimanendo invariate le disposizioni ad essa dedicate nell’ambito del Trattato sul funzionamento dell’Unione». Insomma nulla di nuovo: per il centro-destra come per il centro-sinistra italiani il tutto si riduce a mutamenti cosmetici imposti da un sarkozismo attento solo all’allure. Ma come si concilia tanto unanimismo con l’epocale ‘je accuse’ volto dal ministro Tremonti alla sinistra e al suo utopismo, accusati nel fatale libello sull’Europa di aver addirittura dato i natali al tanto vituperato «mercatismo»?
Meglio in questa sede affidare al tempo risposta a questi stravaganti interrogativi. Meglio non farsi angosciare dagli interrogativi su storiche trasformistiche propensioni. Per ora basta rilevare come ancora una volta, a dispetto di una materia vieppiù incandescente, si sia scelta la strada più cheta e discreta, nel solco del più classico ammonimento manzoniano: «sopire, troncare … troncare, sopire». E così in omaggio a una consolidata lettura dell’art. 11 – volta a incensare le volontarie limitazioni di sovranità a favore di istituzioni sovranazionali indirizzate alla pace e alla giustizia internazionali e rette da forme di partecipazione paritaria – ancora una volta una decisione capitale, relativa al rapporto tra l’Italia e il mondo e alla stessa conformazione del paese, alla sua costituzione materiale, rischia di essere assunta in un clima di perverso unanimismo, al riparo da ogni serio confronto tra le forze politiche, sociali e culturali del paese, nella speranza che le ceneri nascondano e soffochino bene le braci. Così perlomeno è stato nell’ultimo ventennio, quando il traffico e il lavorio governati dall’art. 11 si sono fatti sempre più frequenti ed intensi, ma anche sommamente discreti, il più delle volte amministrati in dibattiti parlamentari di fatto unanimistici, salvo la distinzione di qualche ala estrema su questo o quel lato dell’emiciclo parlamentare. Nulla di paragonabile alle discussioni e distinzioni e divisioni che accompagnarono in un’altra età le scelte della Allenza Atlantica o del Mercato Comune Europeo o ancora, più di recente, del Sistema Monetario Europeo.
In realtà l’unica – e ultima – volta in cui gli italiani sono stati chiamati a decidere direttamente su una questione di ordine sovranazionale è stato in occasione del referendum di indirizzo sul «conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989». Il referendum, autorizzato allora da specifica legge costituzionale su varie proposte all’epoca avanzate da parlamentari del PCI, del Gruppo federalista europeo e dai Consigli regionali di Toscana, Lazio e Basilicata, si svolse congiuntamente alle elezioni europee del 18 giugno 1989 e registrò la partecipazione dell’81% del corpo elettorale, con una vittoria del «sì» pari all’88,1% dei voti validi[2].
Le date contano: di lì a poco la caduta del Muro di Berlino avrebbe liberato il mondo dalla camicia di forza del bipolarismo, dalla sua terrificante ma solida segnaletica. L’Europa si sarebbe avventurata per l’edificazione dell’Unione europea, sulle fondamenta della preesistente Comunità Economica Europea. L’impresa finirà martoriata da referendum – da quelli plurimi della Francia a quelli danesi, irlandesi, svedesi, olandesi – conclusi a volte negativamente ma sempre rivelatori di opinioni contrastanti e divisioni molto nette.
Per l’Italia l’andamento sarà diverso. Avrà inizio allora una transizione assai travagliata ancora non conclusa, ma saldamente ancorata – proprio in virtù del largo e sapiente ricorso all’art. 11 della Costituzione – alla rete di relazioni sovranazionali di cui il paese è nodo volenteroso. A dispetto dei terremoti che squasseranno la nazione e i suoi assetti – si pensi alla repentina dissoluzione della cosiddetta Prima Repubblica e dei suoi partiti – l’art. 11, la sua vocazione sovranazionale si affermeranno come stella polare di naviganti incerti e malfermi.
L’immaginazione costituente
In realtà, scavando nella vicenda della ‘transizione permanente’ in cui il paese è immerso ormai da quasi un ventennio, si può notare come l’art. 11 abbia vissuto e sia stato utilizzato in una forma assai originale e particolare: di fatto esso si è costituito in fonte di ispirazione per una singolarissima «immaginazione costituente» dedita a modificare l’assetto del paese, la sua costituzione materiale, attraverso l’intervento sulle interrelazioni intrattenute dall’Italia con il mondo. Nel rispetto formale della Costituzione – spesso saggiata con proposte di revisione più o meno radicale, fortunatamente fallite o sventate – è stato messo in opera un meccanismo particolarissimo di lettura e interpretazione dell’art. 11, per piegarlo ad un uso partigiano e farne lo strumento di una continua ed inesausta «rivoluzione passiva». Ingegnosa ma semplice, quasi elementare la dinamica messa in moto in epoche diverse e su terreni assai disparati: dalle varie ratifiche di trattati comunitari ed europei – Maastricht, Amsterdam, Nizza, e da ultimo la cosiddetta Costituzione europea – all’ingresso nella WTO o al recepimento dei suoi dettati, o ancora alla trasfigurazione dell’Alleanza atlantica, mutata da patto difensivo in organismo esecutivo dell’interventismo umanitario, o bozzolo della futura Alleanza delle democrazie preconizzata da Clinton e ora rilanciata dal dibattito in corso nelle primarie americane. In ogni occasione, è stato adoperato un marchingegno efficacissimo, proprio perché di elementare semplicità: si è di fatto spezzato l’art. 11. Della prima parte «l’Italia ripudia la guerra …» si è fatto un uso disinvolto, provando a storicizzare quel rifiuto a reperto di un’altra età, antecedente la globalizzazione di fine secolo: ora i conflitti sono altro dalle guerre interstatuali e mondiali su cui il mondo e il primo Novecento sono andati in frantumi. Per domarli o per aver ragione dei rogue-states riottosi al nuovo ordine internazionale vi è bisogno, piuttosto, di azioni efficaci di polizia internazionale, da concepire e condurre con l’apporto più largo di forze e all’ombra delle istituzioni internazionali. Questa lettura, inaugurata in occasione della prima spedizione nel Golfo e celebrata al massimo grado in occasione dell’impresa Nato contro la Serbia, ha resistito anche alla cesura epocale dell’11 settembre, alimentando la differenziazione di intervento tra Afghanistan e Iraq praticata dall’intervento italiano a fianco degli USA o spedizioni assistite da un grado di legittimazione internazionale ben più solido, quali quelle in Libano.
Ma è sulla seconda parte dell’articolo - «consente … alle limitazioni di sovranità … promuove e favorisce le organizzazioni internazionali …» - che la fantasia, l’immaginazione costituente hanno avuto modo di dispiegare appieno la propria carica innovatrice, grazie anche alla convergenza – questa sì bipartisan – di gran parte del mondo politico e culturale, unito nella scelta di una via discreta, silenziosa alla sovranazionalità, amministrata perciò con gli strumenti parlamentari della ratifica, magari nel corso di sedute rapide e senza fronzoli. In qualche caso si è preferito addirittura far finta di nulla: ad esempio, nel corso della trionfale ristrutturazione della vecchia Nato conquistata con l’interventismo alato sui Balcani. Allora, assieme agli alleati e all’amico americano, si è archiviata la vecchia Alleanza atlantica della guerra fredda, strategicamente e programmaticamente posta a difesa del proprio territorio, per trasformarla con nuove prospezioni strategiche e strumenti anti-statutari – le «operazioni non art. 5» - nel braccio armato dell’Occidente, strumento flessibile adatto ai conflitti o alle guerre preventive di Terzo Millennio. Grazie al nuovo Concetto strategico della Nato, reinventato a Washington nell’aprile 1999, la sottoscrizione di nuovi trattati è stata così contrabbandata come semplice aggiornamento dei vecchi obblighi internazionali, riadattati ai nuovi orizzonti post-bipolari.
Il più delle volte, invece, si è fatto in modo da impugnare la formulazione letterale dell’articolo 11, nella sua seconda parte, come una sorta di scalpello per adagiare il dettato costituzionale entro un sarcofago o una cornice sovranazionale – in genere di stampo schiettamente neoliberale – che lo stravolge, quando non lo contraddice apertamente: si pensi alle prescrizioni contenute nei vari trattati europei, da Maastricht fino alla carte di Lisbona, in materia di stabilità dei prezzi, contro l’intervento pubblico in economia, e al modo con cui esse mettono in mora il dettato costituzionale circa il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine econonomico e sociale che…impediscono il pieno sviluppo della persona umana…»[3]. Per comprendere appieno la portata dell’operazione condotta attorno al corpo vivo della Costituzione del ’48, basta leggere le parti dedicate nei trattati alla materia economica e monetaria, di fatto ereditata intonsa da Maastricht (né poteva essere diversamente, dal momento che fin dalla nascita l’Unione Europea, caso unico al mondo, ha vincolato i suoi futuri Padri Costituenti a considerare intoccabile la parte dedicata alla UEM e alla Banca Centrale Europea, da interpellare obbligatoriamente nel caso di modifiche anche parziali: disposizione conservata ancor oggi all’art. 48 del Trattato sull’Unione europea sottoposto a ratifica). Quale sistema si disegna orientando la politica economica sulla stella fissa del «principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza», dotata di una «moneta unica» e di «politica monetaria e del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi» (art. 119)? Si è veramente liberi di scegliere i mix di politica economica quando all’art. 123 o 124 si fa divieto di ogni forma di «facilitazione creditizia» a istituzioni pubbliche o comunitarie o si detta una assoluta parificazione tra settore privato e settore pubblico? E che scelta si fa quando si detta l’assoluta autonomia della Banca centrale europea o del Sistema europeo di banche centrali nei confronti di ogni organo pubblico, nazionale o comunitario? Chissà come avrebbero reagito o come reagirebbero il congresso o il presidente USA di fronte al tentativo di disegnare simili autonomie per la Federal Reserve, per Greenspan o Bernanke.
Per meglio comprendere la portata dell’operazione anestetica condotta in questo modo sul corpo e sulla lettera della Costituzione, vale la pena di soffermarsi su uno dei cantori più lucidi dell’immaginazione costituente, della via italiana alla sovranazionalità. Si tratta di Guido Carli, reggitore e stratega per lungo tempo di Bankitalia, presidente di Confindustria e, come ministro del Tesoro, protagonista della trattativa che doveva presiedere nella cittadina olandese alla nascita dell’Unione europea e dei suoi comandamenti in materia di Unione economica e monetaria. E’ rimasta memorabile l’invettiva contenuta nelle sue memorie contro una classe politica provinciale, impreparata e svagata, finita impiccata non all’albero di Mani Pulite, ma al cappio annodato a Maastricht, ad una morsa che ha avuto ragione tanto dei vizi di una Repubblica e di politici moribondi, quanto dei comandamenti costituzionali che volevano la Repubblica fondata sul lavoro e sull’obbligo costituzionale a trasformare le classi lavoratrici in forze dirigenti del paese[4]. Scorrendo quelle pagine non si può non rimanere sorpresi da quel vero e proprio inno al «colpo di stato» che Carli eleva, quando descrive il comportamento della delegazione italiana a Maastricht e l’intervento compiuto a danno del Parlamento e del popolo italiani: «ancora una volta, si è dovuto aggirare il Parlamento sovrano della Repubblica, costruendo altrove ciò che non si riusciva a costruire in patria … ancora una volta dobbiamo ammettere che un cambiamento strutturale avviene attraverso l’imposizione di un “vincolo esterno”». E di che proporzioni sia stato il mutamento imposto al paese, l’ex governatore di Bankitalia lo precisa senza indugi e con grande vigore: il trattato di Maastricht «comporta un cambiamento di natura costituzionale» ovvero «l’idea di uno “Stato minimo”, un conflitto sociale che si snoda nel rispetto della stabilità dei prezzi, esaltando la nuda creatività del lavoro, la capacità di innovare, la flessibilità del lavoro».
A Maastricht, ma poi in tutte le recezioni delle innovazioni successive – si pensi ad Amsterdam e alla imposizione del cosiddetto «patto di stabilità» o, in altro ambito, alle forche caudine della normativa WTO a protezione degli investimenti esteri o del copyright – l’europeismo elitario di fine secolo e l’imposizione del vincolo esterno intervengono pesantemente sul tessuto costituzionale originario, anestetizzandolo o silenziandolo all’interno di meccanismi di governance multilivello diretti a rimuovere non più gli ostacoli alla libertà e all’eguaglianza di uomini e donne, così come prescritto nella Costituzione italiana e nelle disposizioni di altre Carte fondamentali[5]. Adesso ci si obbliga a rimuovere la ruggine, l’eurosclerosi – ovvero un modello di civiltà e socialità proprio non tanto di un’area ma di un’età – che frena e attarda la competizione, che azzoppa la libera espressione e la fluidità dei mercati. E’ il mercato, con il suo universalismo, con le sue regole e i suoi soggetti, a costituirsi in platea privilegiata del nuovo costituzionalismo mercatista. La particolare immaginazione costituente attivata dall’europeismo e dal liberismo di fine secolo finiscono con il costruire un universo normativo alternativo a quello consegnato esemplarmente nella prima parte della Carta costituzionale, soffocata ormai e azzittita nelle nuove cornici sovranazionali e comunitarie. La stessa casa comune europea subisce una rilevantissima deviazione di percorso, su binari altri da quelli che, come CEE, Comunità Economica Europea, avevano indirizzato i suoi primi passi nello stesso involucro atlantico.
In realtà ad animare la ricostruzione assai partigiana di Carli sta una precisa ideologia, una lettura particolare della Carta costituzionale italiana: la si vuole figlia della fatale convergenza – unica nel panorama mondiale, sì da dar vita ad un «caso italiano» - di cattolici e comunisti, entrambi accomunati da un formidabile «disconoscimento del mercato in quanto istituzione capace di orientare l’attività produttiva verso il conseguimento degli interessi generali». Come tale si vuole inchiodarla a un’epoca precisa, ormai lontana nel tempo: il tutto costretto entro una ricostruzione storica piena di buchi e travisamenti, costretta a tacere o addirittura a mentire su passaggi fondamentali. Da quale tronco gemmavano i tratti interventistici e attivistici della Carta, i compiti della nostra Repubblica? Dalla Costituzione sovietica o dalla dottrina sociale della Chiesa? O non forse anche – magari soprattutto – da una Carta delle Nazioni Unite che portava scolpito nel suo preambolo la decisione di «promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà» e che avrebbe portato a scrivere nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo l’art. 28, circa il diritto d’ogni abitante della terra «ad un ordine sociale ed internazionale» tale da permettere la realizzazione di tutte le libertà e i diritti fondamentali? Non spirava forse in quei tratti programmatici anche l’intento riformatore di Franklin D. Roosevelt? La sua volontà di disegnare un’America ed un mondo proiettati oltre le tradizionali libertà «di parola e di pensiero», liberi «dal bisogno e dalla paura», e perciò non più liberalmente sospettosi della politica e del potere, ma ansiosi di farseli amici e compagni di strada, di mutarli in leve per una trasformazione della società e del mondo?
Al fondo delle letture postmoderne della Costituzione, asciugate d’ogni contesto e soggettività storica, sta un concretissimo disegno volto ad annacquare e snaturare quei patti, quei giuramenti sul futuro. A farne le spese è soprattutto l’art. 11, ridotto il più delle volte a vocazione pacifistica disincarnata o empito universalistico. Se c’è un punto, invece, della Costituzione italiana in cui non è possibile ridurre il tutto all’Italietta di sempre, al matrimonio interessato d’ideologie figlie d’altri secoli, questo è proprio nel grado eccezionale di apertura al mondo del nostro paese e della nostre istituzioni. Questa è la sostanza dell’art. 11.
Una vocazione antica
Quando si sosta a leggere il dibattito alla Costituente o nella Prima sottocommissione, incaricata di metter mano all’ordinamento giuridico dello Stato e ai suoi rapporti con gli altri ordinamenti, e si segue il dibattito su quello che sarebbe divenuto, dopo l’iniziale formulazione di Dossetti, l’attuale art. 11, si rimane subito molto colpiti dall’ansia di legittimazione internazionale: in realtà allora l’Italia era ancora esclusa dalla partecipazione alle Nazioni Unite cui sarà ammessa solo nel 1955. Impressiona però ben presto la discussione appassionata, vivacissima sulla seconda parte dell’articolo. Si affaccia la possibilità di un riferimento all’Europa, a una futura Unione europea. Vi si rinuncerà, rendendolo sottinteso. Adesso urge valorizzare al massimo la novità storica di dar vita, partecipare a organizzazioni internazionali più larghe, disposte ad accogliere e valorizzare il nuovo protagonismo americano, desideroso questa volta di non ripetere l’errore storico del primo dopoguerra, quando il senato USA aveva bocciato la proposta wilsoniana e negato la ratifica del trattato istitutivo della Società delle Nazioni. Ora si discute del consenso alle limitazioni alla propria sovranità, ma soprattutto della partecipazione alle organizzazioni internazionali future. Si soppesano e scelgono accuratamente le parole, fino alla scelta definitiva di un’Italia che «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Alcuni costituenti vorrebbero evitare incursioni sulla scena internazionale troppo impegnative e considerate estranee ai tradizionali perimetri costituzionali. Altri insistono per una caratterizzazione più aperta e protagonistica e tra questi Zagari e Togliatti che, in particolare, invita a cogliere tutta la novità della partecipazione ad una «organizzazione internazionale nella quale si cominci a vedere affiorare forme di sovranità differenti da quelle vigenti».
Con quella formulazione dell’art. 11 l’accento in realtà si sposta visibilmente dal momento della rinuncia alla sottolineatura di un ruolo attivo, della partecipazione, della conquista. Allora si volle fare dell’Italia un costruttore di un mondo pacificato, di una nuova scena internazionale. Si costruì perciò una Costituzione incardinata su un’altra visione della sovranità, non più limitata al tradizionale perimetro nazionale, ristretta alle vecchie forme dello Stato nazione. Fin dall’inizio della storia repubblicana – a dispetto delle visioni ideologiche alla Carli – si rifiutò la prospettiva dell’Italietta. Ci si volle invece muovere oltre i confini abituali, in un mondo che si concepiva aperto al dialogo e alla cooperazione. L’intento è di intervenire, riformare, portare pace e giustizia oltre la portata del proprio braccio, in collaborazione con altri popoli e nazioni. La rinuncia a forme o parti della sovranità abituale è funzionale alla conquista e all’esercizio di nuova sovranità.
In realtà nella sua formulazione finale l’art. 11 fa intravedere una Costituzione originalmente fondata sin dalle origini su forme di sovranità multilivello, sulla prefigurazione di una sovranazionalità intesa a rispondere al bisogno storico di guadagnare sovranità e non di perderla, di estendere il proprio raggio di influenza ed azione e non di ripiegare sotto l’urto dei nuovi attori e delle nuove potenze attivate dalla trasformazione progressiva del mondo.
Rivolgimenti
Intenti e disegni hanno poi dovuto fare i conti con le repliche della storia. Si pensi, ad esempio, per un istante a come già i principi di parità tra gli Stati dichiarati nell’art. 11 come condizione per consentire alle limitazioni di sovranità fossero stati drasticamente rivisti il 6 agosto 1945 dalla decisione di sganciare l’atomica su Hiroshima. Da allora e per sempre il globo era stato trasformato da una decisione che faceva assurgere uno o pochi altri Stati a decisori finali sulle sorti dell’umanità. Una forma di radicale diseguaglianza aveva già fatto irruzione nel mondo sì da far passare in un sol giorno le Nazioni Unite e i loro principi di eguaglianza tra popoli e nazioni «dall’infanzia alla vecchiaia»[6].
Altri e più radicali sommovimenti hanno investito le reti della sovranazionalità fin dai primi anni Settanta, quando lo scasso delle regole di Bretton Woods ha scatenato il protagonismo della finanza e di esecutivi e tecnocrazie vogliosi di conquistare spazio e poteri a scapito delle assemblee elettive. Per la costruzione europea, ad esempio, vi è un momento preciso in cui la scena muta drasticamente. Il là è dato da sentenze epocali della Corte di Giustizia, quale quella sul «Cassis di Digione»: si sdogana il principio in forza del quale un prodotto giudicato legale in un paese della Comunità acquista una patente di pronta corsa valida per tutti i paesi della CEE. Ai principi di armonizzazione delle legislazioni si sostituiscono quelli del riconoscimento reciproco e della equivalenza. La concorrenza si sposta dai prodotti alle legislazioni. La via è aperta per il trionfo della regolamentazione più leggera, dello Stato minimo[7]. L’Atto Unico del 1985 incorona la deregulation a principio cardine della nuova comunità. Al «mercato comune», frutto dei mercanteggiamenti di Stati sovrani e tecnocrazie comunitarie, si sostituisce il «mercato unico» incardinato attorno alla centralità dell’impresa, assistita e sospinta ora da una legislazione pronta a rimuovere gli ostacoli frapposti al suo protagonismo continentale. Su quel solco seguirà Maastricht, con la consacrazione della moneta unica a dominus della nuova Unione europea, o ancora la Carta dei diritti, con la sua particolare concezione dei «diritti sociali»: figli di un Dio minore, sono riconosciuti solo se non danno vita a ulteriori obblighi o poteri comunitari e in un ambito rigorosamente nazionale, ovvero evirati a variabili dipendenti di bilanci nazionali e spesa pubblica meccanicamente compressi da patti di stabilità e divieti.
Questa Europa resa sbilenca dal prepotere del comando monetario e neoliberale non cessa di navigare nella tormenta. Nonostante tutti i tentativi messi in opera dalla tecnocrazia comunitaria e dagli esecutivi nazionali per addolcire e smorzare l’impatto con i poteri veicolati dai nuovi trattati, viene avvertita come una minaccia da parte grande dei popoli europei, come un attentato al modello europeo di civiltà consegnato nelle varie configurazioni nazionali e regionali di Stato sociale. Parafrasando le metafore geo-militari rese note da Donald Rumsfeld qualche anno fa, vi si intravede una sorta di New Europe volta contronatura a contrastare l’Old Europe, tesa a dissolvere proprio i tratti originali in forza dei quali è possibile parlare di “popolo europeo”, rintracciare cioè una peculiare qualità sociale divenuta storicamente timbro e voce unitari di popoli e comunità.
Nei marosi di questa storia, nel quindicennio che ci è alle spalle, sono già affondate tutte le classi dirigenti che a Maastricht avevano osato pensare i termini di una nuova autonomia del Vecchio Continente. Nessuno di quei firmatari è sopravvissuto, anche quelli più smaliziati, accortissimi nell’utilizzo del cosiddetto «vincolo esterno». Né alcuno dei loro successori è rinsavito di fronte all’inequivoco tornado accumulato sui cieli d’Europa e al fallimento infine in cui è incappato il progetto di Costituzione varato dalla Convenzione presieduta da Valéry Giscard d’Estaing.
Poco male se sotto le macerie potessero rimanere solo gli apprendisti stregoni dell’eurocrazia e il peggio delle loro elucubrazioni: lo strapotere di mercato e moneta assurti a stelle fisse e motori immobili dell’empireo costituzionale europeo. In realtà, rischiano di farne le spese anche quei principi e valori e fattori – di solidarietà, integrazione e comunanza – sui quali puntare e spingere per promuovere un’Europa attrice di un’altra globalizzazione: solidale, partecipata, rappacificata tra i popoli e con la Terra. E che il barometro possa inclinare al peggio, lo indicano con nettezza i processi di dissoluzione delle identità politiche, oggi giunti a sinistra a livelli parossistici. All’indomani dell’89 il movimento operaio continentale ha di fatto visto nell’Europa un nuovo “sole dell’avvenire”: o allineandosi silente, nei suoi reparti maggioritari, all’europeismo liberista celebrato a Maastricht, o avviandosi incerto e inquieto, nelle sue propaggini più critiche e alternative, alla ricerca di un’”altra Europa”. Questi lacerti ora rischiano strappi ulteriori e ancor più dirompenti di quelli passati, a fronte di un panorama drammaticamente incupito dalla guerra e dall’incrudelirsi del dumping planetario attivato dalla discesa in campo dell’Asia. Lo dimostra bene proprio la vicenda del no al progetto di Costituzione europea. Anche la sinistra più schiettamente antiliberista non è riuscita a costruire molto sulla vittoria del no: non lo si è saputo vivere come processo di costruzione di unità e identità più larghe, non tanto politiche ma financo culturali. Hanno avuto la meglio piuttosto divisioni e frammentazioni ulteriori tra i sostenitori della sovranità nazionale e coloro che si sforzano ad intravedere nella crescita di un’altra Europa la tappa necessaria di un nuovo internazionalismo.
Sorte non dissimile è toccata a quel «movimento dei movimenti» salutato da Patrick Tyler sul «New York Times» del 13 febbraio 2003 come la seconda superpotenza del pianeta. Particolarmente largo e influente proprio in Italia, grazie anche all’uso sapiente e alla strenua difesa dell’art. 11 della Costituzione, da tempo vede declinare influenza e capacità di mobilitazione. In senso inverso alla frequentazione dell’art. 11 praticata dalle classi dirigenti, il pacifismo si è attestato soprattutto nella rivendicazione del mondo evocato con le parole della prima parte: pace, ripudio della guerra. Ha mancato l’appuntamento con le istituzioni. Non ha saputo divenir soggetto né – a dispetto dei tanti Forum – invadere, conquistare o trasformare istituzioni.
Ora viviamo il paradosso di una politica di fatto tutta disposta sul piano interconnesso e sfalsato di istituzioni multilivello. Si pensi all’assurdo dei Trattati di Lisbona che – come già avveniva con la Costituzione europea – rinviano per la Politica estera e di sicurezza al rispetto della cornice atlantica e agli obblighi lì statuiti: un trattato para-costituzionale che ricava buona parte dei suoi concreti obiettivi strategici e militari da un non-trattato mai ratificato da alcun parlamento. Dall’alto il protagonismo degli organismi europei invade ormai la nostra vita quotidiana: un’indagine del Consiglio costituzionale francese ha calcolato che l’80% della legislazione nazionale – per l’Italia valgono proporzioni analoghe – origina da normative comunitarie. Rispetto a questa trasmigrazione della politica, attivata proprio dal modo in cui i diversi soggetti hanno saputo praticare i grandi spazi aperti esemplarmente per il nostro paese dall’art. 11, è forse venuto il momento di riguadagnare terreno e iniziativa.
Una scelta quale quella presentata in passato dalla Lega – referendum automatici ad ogni rinuncia di sovranità – è folle e foriera solo di ulteriore delegittimazione generale e dello stesso strumento referendario. Si finirebbe subissati da quesiti attivati indiscriminatamente sulle materie più varie. Altro è il discorso per le grandi questioni della pace e della guerra, della ristrutturazione e ridislocazione dei poteri fondamentali. E’ assurdo pensare e permettere con le opportune modifiche costituzionali che su di esse attori nazionali o sovranazionali (forze politiche o istituzioni o aggregazioni civili , magari con soglie o quorum più qualificati di quelli usuali) possano sollevare quesiti di natura referendaria, caricandosi degli oneri come degli onori della prova?
In realtà è assurdo pensare che vi possano essere attori della società italiana o europea disposti o capaci di recidere i legami dell’Italia con il resto del mondo. Ma è anche insopportabile ormai che oggi la politica sovranazionale si costituisca in territorio di caccia privilegiato di tecnocrazie ed élites sovranazionali saldamente vietato alla frequentazione o alle incursioni di cittadini ed elettori. Ripensare lo strumento referendario, con grande accuratezza e piena responsabilizzazione dei proponenti, può rivelarsi una via utile all’ulteriore, virtuosa interrogazione del cosmopolitismo italiano.
15 giugno 2008
[1] La paura e la speranza. Europa: la crisi globale che si avvicina e la via per superarla, Milano, Mondadori, 2008.
[2] Su 46.323.415 elettori i votanti furono 37.509.386 (81%). I sì furono 29.189.777 (88,1%) a fronte di 3.954.998 (11,9%) no. Si registrarono 4.364.611 voti non validi, di cui 2.765.197 schede bianche.
[3] Obblighi di fatto simili a quelli che caratterizzano buona parte delle Costituzioni varate o riscritte all’indomani della II guerra mondiale in un calco nettamente antifascista che improntò un’intera stagione politica e costituzionale.
[4] Cfr. G. Carli, Cinquant’anni di vita italiana, in collaborazione con P. Peluffo, Roma-Bari, Laterza, 1993, in particolare alle pp. 7-9.
Significativa però anche la raccolta postuma di scritti e interventi di Carli, Le due anime di Faust. Scritti di economia e politica, a cura di P. Peluffo, Roma-Bari, Laterza, 1995. Come sottolinea accuratamente il curatore, il rinvio al Faust di Goethe rappresenta «la chiave di lettura di Carli sulla società italiana», permanentemente strattonata tra «una pulsione verso l’apertura internazionale, la concorrenza, il mercato, il confronto con le armi dell’intelligenza e della competenza, e una pulsione indirizzata alla protezione, all’arbitrio interno, alla chiusura», ivi, p. IX.
[5] Per una acuta e larga ricostruzione delle reti multilevel che stringono sempre più da presso e intimamente distorcono la Costituzione italiana, cfr. ora G. Bucci, La sovranita’ popolare nella trappola delle reti multilevel, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2008.
[6] L’espressione di grande efficacia è di Freda Kirchwey, direttrice di «The Nation», in un editoriale del 18 agosto 1945: One World or None.
[7] Per una efficace descrizione del processo e delle sue tappe, cfr. M. Albert – J. Boissonat, Crise, Krach, Boom, Paris, Seuil, 1988, tr. it.: Crisi, disastro, miracolo. L’Europa nel gioco a rischio dell’economia mondiale, Bologna, Il Mulino, 1989.