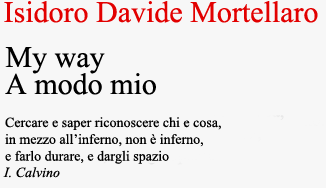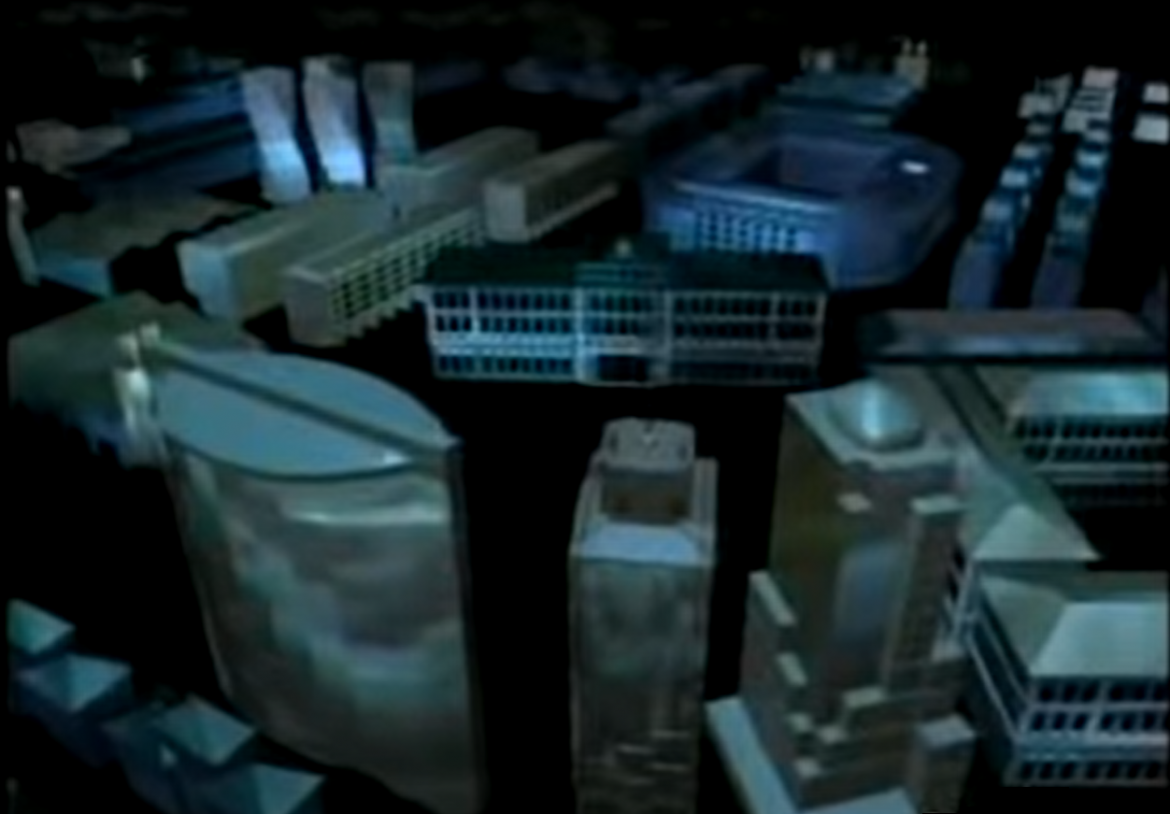VERSO UNA DEMOCRAZIA SEMPRE PIU’ PILOTATA
(Pubblicato il 12 luglio 2022 su «fuoricollana.it»)
SOMMARIETTO All'ultima tornata amministrativa l'astensione ha sfiorato il 58%. La Francia, qualche giorno prima, alle legislative, si era avvicinata a soglie simili d'allarme sistemico: 54%. Un Grande Fratello diffuso orienta e governa gran parte del voto, specie nel Mezzogiorno, spesso in combutta con la «società incivile».
Sporgendosi sul vuoto
All'ultima tornata amministrativa il termometro dell'astensione ha toccato in Italia quasi il 58% di elettori renitenti all'esercizio del voto. La Francia qualche giorno prima, alle legislative per l'elezione dell'Assemblea nazionale, si era avvicinata a soglie simili d'allarme sistemico: 54%.
Tempo fa, Peter Mair, contemplando l’avanzare di questa piana desertica, pronosticava lo «svuotamento della democrazia occidentale» e avvertiva sulla necessità ormai di attrezzarsi a «governare il vuoto». Altri, come Carlo Galli, avevano più radicalmente visto la democrazia ormai negata nel suo attributo fondamentale: «senza popolo». Ormai non v’è giorno in cui non si accumuli sulla democrazia una qualche previsione infausta: dal «tramonto» di Anne Applebaum al più radicale «suicidio» pronosticato da Federico Rampini. E che non si tratti ormai solo di astratte elucubrazioni politologiche ma di processi esplosivi di portata gigantesca sta a dimostrarlo la quotidiana cronaca negli Stati Uniti, squassata per decenni da quelle che gli Americani chiamano «cultural wars», guerre culturali. Al centro dello scontro diritti e poteri fondamentali, il ruolo degli States nel mondo.
Nell’antichità classica per la polis era altro il termine in uso: stasis, «guerra civile», quella che secondo Tucidide mutava «il significato stesso delle parole». Aristotele intravedeva al fondo della contesa fratricida diseguaglianze profondissime: ciò che ancor oggi si configura come conflitto sistemico tra ultimi e oligarchie. Adesso clima, aborto e armi sigillano - addirittura col marchio della Corte suprema - lo scontro, l'assedio che i perdenti di uno scontro elettorale hanno provato a dirigere contro il Campidoglio nel nome di Trump: estremo tentativo di manomettere il voto e portare indietro le lancette della storia. Né in Europa le istituzioni democratiche vivono momenti migliori. Pandemia e guerra le stanno devastando. Ad iniziare fu l'Inghilterra con la Brexit, ben presto – alla luce di esperienza e contraddizioni - rimessa da più parti in discussione fino ad arrivare a defenestrarne gli autori. Oggi la Francia si scopre anch'essa tarlata da una sfiducia radicale nei confronti delle istituzioni repubblicane e in preda all'ingovernabilità: proprio quando è chiamata a giudicare lo sforzo immane prodotto da Macron nel provare a riconquistare la grandeur gaullista. Né gode di buona salute la Germania riconquistata dalla SPD: si scopre oggi orfana della Merkel e incerta nel ruolo di prima linea affidatole nella UE dall'emergenza bellica in Ucraina.
Una crisi sistemica
Presto - troppo presto - è stata accantonata la discussione sul voto e sulle urne del 12 giugno. L’eclatante fallimento dell’assalto referendario, certificato dal bassissimo tasso di partecipazione, ha contribuito ad archiviare in fretta la pratica. Sui due lati del fronte opposte le sensazioni di sollievo o angoscia. Nell’ombra, nonostante alcuni sprazzi assai illuminanti, è rimasta la riflessione sul voto amministrativo: complice, tra l’altro, l’ardua comparazione di situazioni assai diversificate, soprattutto tra Nord e Sud.
In realtà ha primeggiato la discussione sulla crisi complessiva del sistema politico. Di fatto - sia pure con le uniche eccezioni di un qualche rilievo di “Fratelli d’Italia” e del “Partito democratico”, smorti poli di un ipotetico futuro bipolarismo - siamo all’archiviazione dell’ennesima mutazione (2 o 3 “punto zero”?) della Repubblica e dei suoi principi ispiratori. Da tempo silente e buttato in un angolo ci contempla impotente quel cardine sistemico tracciato dall’art. 49 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
Piazze e corsi di città e paeselli non sono punteggiati più da insegne di partiti e movimenti. Locali sfitti da tempo o abbandonati si animano solo in occasione di appuntamenti elettorali, soprattutto municipali. È allora che plance e muri compongono caleidoscopi di sigle improbabili, confondendo passanti e cittadini con gallerie interminabili di volti e facce sempre sorridenti. La socialità di un tempo - fatta di luoghi collettivi di lavoro e studio, sedi di partito e sindacato - è sempre più surrogata da improvvisazioni che durano lo spazio di una campagna elettorale o non vanno oltre un quartiere, nel migliore dei casi un comune. Senza più legami solidi col mondo, ma solo di fatto col surrogato dei social.
A sorridere non è più da tempo l’elettrice o l’elettore. In cerchie sempre più ampie rifiutano di recarsi alle urne. In alcuni casi siamo ormai a uno su due. La tendenza usuale, ma in forme diverse, in altri paesi occidentali, è iniziata per l’Italia nel fatale 1979 e si è fatta inarrestabile. Allora l’assassinio di Aldo Moro annunciò con un decennio di anticipo per il nostro paese, rispetto alla cesura dell’89, la fine di un’epoca e la crisi del sistema politico nato con la Repubblica. L’asticella dell’astensione fece un salto nel 1979, passando dal 6,6 al 9,4 degli elettori per la Camera dei Deputati. Naturalmente con una accentuazione nelle Regioni meridionali e grazie anche alla moltiplicazione nelle mani e nel cervello degli elettori di schede e appuntamenti elettorali: si celebravano allora anche le prime elezioni europee. E da un decennio ormai l’abituale appuntamento elettorale amministrativo vedeva l’aggiunta alle schede per le comunali e le provinciali di quella per la scelta del Consiglio regionale. Cresceva allora lo spaesamento tra i vari livelli di potere che intervengono a condizionare e determinare la vita dei singoli. Col tempo l’elettorato comincia a soffrire in maniera sempre più marcata la perdita di controllo sulle potenze abilitate al controllo e alla conduzione del mondo.
Crisi della democrazia
Erano «anni di piombo» per l’Italia: un periodo assai buio e di grandi sconvolgimenti su cui il trascorrere del tempo non ha portato molta luce e chiarezza. Sono anni di grandi svolte. L'intero mondo è a soqquadro sotto l'urto delle 'crisi' più varie: dollaro, petrolio, Bretton Woods, Vietnam. Henry Kissinger, alla ricerca di nuovi equilibri, asseconda l’arrovesciamento del globo dall’Atlantico al Pacifico. Il Club di Roma s’avventura per radicali visioni del pianeta: sotto l’urto di una mutazione prometeica gli appare destinato col passaggio di secolo alla «fine della crescita». Ma è dagli States che giunge una prognosi assai inquietante, ma fascinosa. Col tempo diverrà anche assai coinvolgente. A proporla un’associazione molto particolare, finanziata da David Rockfeller su ispirazione di Zbigniew Brzezinski: la Trilateral Commission, un’organizzazione che prova a promuovere il confronto tra le élites del mondo sviluppato sui malanni del tempo. La diagnosi è quella della «crisi di governabilità»: democrazie assediate da un mondo in subbuglio, con radicali sommovimenti tra il Nord e il Sud di un pianeta sottoposto ad una epocale mutazione politica e culturale, per la moltiplicazione di movimenti e soggetti; crescita abnorme del settore pubblico nel tentativo di assecondare un’agenda straordinariamente dilatata; crisi di «sovraccarico» con tensioni alla lunga intollerabili in gangli vitali. A rimedio, nell’impossibilità di procedere a straordinarie innovazioni costituzionali, bisognose di un consenso assai improbabile, è preferibile una paziente opera di armonizzazione e semplificazione ad opera degli esecutivi d’ogni paese: una primazia nel comando ma soprattutto nella promozione e nel coordinamento dell'azione politica, nel tentativo di armonizzare le agende di lavoro di élites e tecnocrazie.
Scritta in limpido inchiostro elitario la ricetta trova pronto ascolto nelle classi dirigenti proprio del Trilatero: USA, Europa occidentale e Giappone. I più pronti a cogliere l'imbeccata saranno i nuovi leader appena emersi in Europa: Valery Giscard d'Estaing e Helmut Schmidt. Tentando di far da sponda anche alla richiesta di «nuovo ordine mondiale» che viene dal Sud del mondo, provano a mettere a frutto la crisi dell'«amico americano» caduto per i gradini ripidissimi del Vietnam e finito 'impicciato' nel Watergate. E così, dopo alcuni meeting informali tra ministri delle Finanze, propongono all'appena insediato Gerald Ford l'istituzione di un forum informale 'trilaterale'. La prima riunione al castello di Rambouillet s'allargherà anche all'Italia per poi passare all'assetto definitivo a sette l'anno seguente con l'inclusione del Canada. Da allora, anno dopo anno, sotto gli occhi elettronici del mondo da quella cattedra sono state dispensate analisi e raccomandazioni, spesso in esplicita concorrenza con sedi e istituzioni provviste di ben altra caratura costituzionale.
Ben presto l’illusione europea di instaurare una guida condominiale del mondo liberaldemocratico si rivela illusoria. Dalle viscere operose della società americana, da una miriade di laboratori e fondazioni - in discorde dialogo con le culture della contestazione e al riparo dalle convulsioni del sistema politico - iniziano una cavalcata planetaria alcune innovazioni destinate a terremotare il vissuto dell’umanità. Tra il 1970 e il 1975 vengono concepiti e lanciati: codice a barre, microprocessore, floppy disc, la CAT o tomografia assiale computerizzata, e-mail, marmitta catalitica, calcolatore tascabile, Altair, home computer ecc. Una ondata di innovazione tecnologica inizia a sommergere il globo, dando l’avvio ad una rivoluzione planetaria nelle forme della comunicazione e della socialità. Un nuovo individualismo fa il suo esordio: adesso non si limita più solo ad ascoltare o scrutare sullo schermo la voce dell'umanità. Inizia a portare il mondo in borsa, quando non in tasca.
Ritorni di fiamma
Il fallimento maggiore però è quello che si verifica proprio sul terreno scelto elettivamente dal G7 a campo prioritario di azione: la risposta alla rottura dell’ordine di Bretton Woods, alla nascita, dietro il dollaro senza più regole e cambi fissi, di una finanza sregolata, vero e proprio dominus del mondo futuro. Non solo mancherà una qualche forma di regolazione pubblica, ma buona parte dei meetings dei 7 si risolveranno in peana alla nuova potenza sprigionata dalla dissoluzione dei Trente Glorieuses. Gli USA grazie all’avvento di nuove forme di regolazione romperanno l’assedio: il nuovo dollaro, provvisto degli ampi margini di fluttuazione concordati nella nuova sede di compensazione oligarchica, si offrirà come approdo sicuro soprattutto per i petrodollari che copiosi inizieranno a percorrere il mondo e approdare negli States.
A rafforzare, su un altro versante, la primazia USA nel trilatero del G7 contribuisce paradossalmente una particolarissima accentuazione sul tema dei «diritti umani» nel mondo: vera e propria colonna portante delle formule diplomatiche che nel 1975 portano alla firma ad Helsinki dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.
Strano destino quello dei «diritti umani», della riscoperta di temi e parole d'ordine scolpite nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Nel dopoguerra, anche in polemica con l'Occidente, hanno alimentato la presa di coscienza del Terzo Mondo e la lotta per la liberazione dal neocolonialismo. A caratterizzare quella stagione l'insistenza sul tema della piena sovranità politica e della promozione di eguaglianza e benessere come fine fondamentale della politica. Anche con questa valenza alimentano la critica delle atrocità belliche in Vietnam e il fuoco delle battaglie negli States per i diritti civili. Alimenteranno così le bandiere sventolate da George McGovern nella sfortunata battaglia per la presidenza ma finiranno distorti nei primi anni Settanta nelle mani della destra americana come vessillo del più puro anticomunismo. Nelle carte di Helsinki se ne darà una lettura particolare: in primo piano la libertà di scelta del singolo. Non v'è più menzione per la promozione di eguaglianza e benessere. Il clima è ormai completamente mutato: è finita la stagione dello Stato, della leva pubblica come volani essenziali per conquistare eguaglianza, per dar sostanza a nuovi diritti, soprattutto sociali e civili. Ovunque l'intervento pubblico inizia ad esser chiamato sul banco degli accusati: finanza fuori controllo, elefantiasi, crisi fiscale. Impugnare ora il tema dei diritti umani significa innanzitutto provare a mondare il mondo del peso intollerabile della politica di potenza, della morsa totalitaria. Con quel vessillo - fatto proprio ora dal nuovo presidente americano Jimmy Carter, ma dall'altro lato anche dal «dissenso» oltre Cortina di Vaclav Havel - gli USA adesso provano a riproporsi nel mondo come reincarnazione della City on the Hill, la città risplendente sulla collina, in lotta contro totalitarismi e fondamentalismi. Qui la radice di una rivendicazione degli Stati Uniti come alfieri dei «diritti umani» destinata ad un lungo cammino, a reincarnarsi negli storici ossimori della «guerra umanitaria» o nella santificazione della «democrazia da esportazione».
Il «colpo di reni»
A sommuovere la scena globale provvede quello che Ernst Nolte ha chiamato «colpo di reni» della conservazione. Sotto la lente dello storico l'accavallarsi nel biennio 1978-1979 di una serie di sommovimenti che terremotano la scena mondiale. S'inizia nel Vietnam. Con avvio nel 1976 e l'esplosione nel 1979 - quando Francia e Italia inviano dall'altra parte del globo vascelli militari per il soccorso in mare - centinaia di migliaia di vietnamiti provano in imbarcazioni di fortuna a sfuggire alla morsa del regime imposto dal Vietnam del Nord con nazionalizzazione delle imprese e collettivizzazione delle terre. La minuscola nazione assurta per anni a peccato capitale del gigante USA si rivolta agli occhi del mondo in faccia ributtante di un comunismo dispotico.
Con la cacciata dello scià e l'avvento-rivelazione di Khomeini in Iran inizia quella che Gilles Kepel chiamerà la «rivincita di Dio»: «La Revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde». La religione torna ad essere per moltitudini faro nel mondo e speranza per il futuro: da Israele con l'avvento della destra ortodossa in appoggio di Begin al Wojtyla stella polare per i gruppi integristi, come per Solidarnosc, per finire al Jimmy Carter dichiaratamente battista che apre la strada ai gruppi cristiani più integralisti in appoggio a Ronald Reagan. Potrà così capitare persino ad un laicissimo Michel Foucault di commentare - in una serie di editoriali per il «Corriere della Sera» poi raccolti in volume - la rivoluzione khomeinista salutata come il ritorno di una «nuova spiritualità politica», speranza per i diseredati di quel paese e del mondo intero. L'applicazione della sharia, assieme ai primi tagli di mano comminati ai ladri e alle prime esecuzioni capitali, lo azzittiranno. Non parlerà mai più dell'Iran.
È poi la volta dell'URSS: ha iniziato da poco a schierare ai confini missili SS-20 dotati di testata nucleare. L'allarme cresce finche Helmut Schmidt rompe il dibattito invitando gli USA ad assicurare copertura all'Europa occidentale con missili Cruise e Pershing. A seguirlo nell'appello all'«amico americano», Francesco Cossiga, all'epoca presidente del Consiglio, con la dichiarazione su un'Italia pronta ad accogliere i nuovi euromissili. Ne nasce una crisi e una mutazione dei blocchi militari contrapposti durate quasi un decennio. All'apice della crisi e in risposta agli USA che accolgono la richiesta europea, l'URSS invade l'Afghanistan. Ne vengono sconvolte le Olimpiadi ma soprattutto l'intero universo islamico. Per quel pezzo di mondo in subbuglio la ricetta americana sarà la Dottrina Carter, con la proclamazione dell'intero Medioriente a zona vitale di primario interesse americano - con annesse minacce di guerra - accompagnata dalle speranze di Zbignew Brzezinski, consigliere per la sicurezza del presidente, di vedere l'Afghanistan trasformarsi nel «Vietnam dell'URSS». Il tutto accompagnato dalla scelta di foraggiare l'islamismo radicale in appoggio alla rivolta afghana, impersonificato da Osama bin Laden per l'Arabia Saudita: ne nascerà «Al Qaeda».
All'altro angolo del mondo, Deng Xiaoping proclama, dopo le «quattro modernizzazioni», la «riforma economica cinese». Apre le aree metropolitane costiere, come «zone economiche speciali», agli investimenti del capitalismo globale: la Cina diviene World Factory. Il mondo arrovescia i suoi cardini sul Pacifico.
Nel cuore d'Europa matura una rivoluzione di ben altra natura. Non è il prodotto di idee o masse in movimento. È frutto di saperi antichi, ispirati in genere a prudente e sapiente consultazione di codici. È la Corte di Giustizia della Comunità Europea a produrre lo strappo. A proposito del rinomato Cassis di Digione, con una sentenza statuisce che una merce prodotta secondo le regole di uno Stato aderente alla CEE può circolare liberamente in tutti gli Stati della comunità senza bisogno di alcun permesso o regolazione aggiuntiva, a meno che non tocchi esigenze imperative d'altra natura: ad esempio, quelle di salvaguardia della salute pubblica. È il trionfo dello «Stato minimo», della regolazione politica ridotta ai minimi termini. È l'affermazione di un principio che assurgerà anni dopo ad architrave dell'Atto unico europeo del 1985 e del successivo cammino intrapreso da Jacques Delors per fissare e conquistare al 1992 il completamento del mercato unico europeo.
Diffusa è la percezione che attraverso vie e forme molteplici lo scettro sia ormai strappato alle mani del popolo sovrano. Ovunque partiti e parlamenti sono in ritirata, azzittiti sempre più spesso dal protagonismo dei leader. Sottilmente e paradossalmente lo scalpello del diritto e dei diritti dei singoli ha cominciato a sgretolare la corazza delle istituzioni statali. E a dare un colpo decisivo ha provveduto da qualche tempo direttamente l'OCSE, la maggiore e più influente organizzazione internazionale degli stati più avanzati in campo economico. A giugno del 1977 viene pubblicato il McCracken Report: Towards Full Employment and Price Stability, una imponente ricerca durata quasi due anni in cui Paul McCracken, coadiuvato da uno stuolo di economisti, individua nell'inflazione il nemico principale per la politica economica pubblica. A dispetto del titolo del rapporto, sono proprio le scelte a favore della piena occupazione nel fuoco del mirino. Lentamente, ma con decisione, la morsa ha preso a stringersi sulla spesa pubblica dando avvio ad una dipendenza sempre più marcata delle centrali di spesa nazionali rispetto ai flussi della grande finanza internazionale.
Figlio di questo mutamento, sotto la presidenza di Jimmy Carter, l'avvento di Paul Volcker alla direzione della FED, la Federal Reserve americana, con la rivoluzione nella politica economica tutta rivolta contro l'inflazione. A rispecchiamento in Europa si dà vita allo SME, il Sistema Monetario Europeo: varato nel 1979 tra i paesi dell'Europa occidentale, con le sue bande strette di oscillazione monetaria (e la transitoria eccezione italiana di bande più larghe), guida la rivoluzione nel Vecchio Continente della politica economica d'ogni paese. Per effetto di questo ennesimo rivolgimento, concomitante rispetto alla decisione di schieramento degli euromissili, vanno in soffitta i sogni del duo Schmidt-Giscard: la barra per politica economica e difesa è tornata decisamente a colorarsi a «stelle e strisce».
«Crisi di fiducia»
A dar degna cornice a questi rivolgimenti sta la prolusione del presidente Carter del 15 luglio 1979 passata alla storia come discorso sulla «Crisis of Confidence»: la «crisi di fiducia». Egli vede nel tempo presente ergersi uno spartiacque, «una minaccia fondamentale per la democrazia americana ... una crisi di fiducia». L'occasione è data dalle difficoltà a conquistare nel Congresso una qualche forma di regolazione dei consumi energetici. Ma Carter per l'occasione affonda il bisturi in maniera più profonda: «Abbiamo sempre creduto in qualcosa chiamato progresso. Abbiamo sempre avuto fiducia che i giorni dei nostri figli sarebbero stati migliori dei nostri». E invece ora è subentrato un mutamento epocale, adesso è in discussione «la fiducia, non solo nel governo in quanto tale, ma nella propria capacità in quanto cittadini di essere coloro i quali in ultima analisi guidano e danno forma alla nostra democrazia». Ecco il punto dolente: la sostanza stessa della politica nel tempo moderno, la fede nel riconoscersi come motore primo della democrazia e dei suoi istituti.
Continuando ad esplorare i contorni della crisi Carter allunga lo sguardo sulla capitale, sul centro del potere: «Cercando una strada per uscire da questa crisi, il nostro popolo si è rivolto al governo federale e l’ha trovato isolato dalla corrente principale della vita della nostra nazione. Washington D.C è diventata un’isola ... Quello che si vede troppo spesso a Washington e in giro per tutto il paese è un sistema di governo che sembra incapace di agire. Un Congresso tirato e strattonato da centinaia di interessi particolari ben finanziati e potenti ... Si vedono spesso paralisi, stagnazione. Si va alla deriva»
Ritorna e imperversa il mantra della Trilateral: «la crisi di governabilità». Ma questa volta scompare l'attore della crisi: il «sovraccarico di domanda», il surplus di partecipazione. Al suo posto gruppi di interesse e lobby, ma soprattutto apatia, distacco, vuoto. A far da orizzonte generale una mutazione - financo antropologica - epocale su cui Carter punta il dito: «troppi di noi ora tendono al culto dell’egoismo e del consumo. L’identità delle persone non è più definita da quello che fanno, ma da ciò che posseggono. Eppure ci siamo resi conto che possedere cose o consumarne non soddisfa il nostro desiderio di significato. Abbiamo imparato che accumulando beni materiali non si può riempire il vuoto in vite che non hanno più fiducia o scopo. I sintomi di questa crisi dello spirito americano sono tutti intorno a noi: per la prima volta nella storia della nostra nazione la maggioranza della nostra gente crede che i prossimi cinque anni saranno peggiori dei cinque anni appena passati. Due terzi del nostro popolo non hanno nemmeno votato. Persino la produttività dei lavoratori americani è crollata ... c’è una crescente mancanza di rispetto nei confronti del governo, delle chiese e delle scuole, dei mezzi di informazione e delle altre istituzioni ... Questo non è un messaggio di felicità o di rassicurazione, ma è la verità ed è un segnale d’allarme».
Quel discorso - sulle labbra del presidente degli Stati Uniti d'America - sigilla un'epoca. Per un osservatore acutissimo come Tony Judt è «la fine di ogni certezza». In Italia Francesco Alberoni inizia su scala continentale a datare da allora «l'epoca dell'Occidente assediato». Jean Fourastié aveva coniato per il trentennio dell'Embedded Liberalism, del «liberalismo regolato», il marchio dei Trente Glorieuses. Nicolas Baverez vede arrivare Les Trente Piteuses.
Leaderismo, trionfo dell'effimero, pacifismo
Il sipario è ormai strappato. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl, Battino Craxi arriveranno uno dietro l'altro ad occupare quasi interamente il proscenio. François Mitterrand per un breve periodo movimenterà le scene di luce diversa. Poi anch'egli tra gennaio e marzo 1983 si adeguerà al «vincolo esterno»: euromissili e SME.
L'astensione dalle urne continua a crescere e con essa l'irrilevanza dei vecchi partiti. Non a caso in Italia gli ultimi grandi singulti dei partiti di massa sono quelli del PCI in occasione dei funerali di Berlinguer e del referendum perduto sui punti di scala mobile.
La scena sociale sta mutando drammaticamente nel mondo. La Rust Belt, la «cintura della ruggine», s'allarga non solo nel cuore industriale degli Stati Uniti. Ovunque nel mondo - tranne che in Cina e pochi altri distretti della delocalizzazione globale - il lavoro manifatturiero è in calo esponenziale. Assieme al dilagare di informatica e telematica il prefisso 'post' inizia a marchiare tutto ciò che gli analisti sociali intravedono come mutazione continua, senza comprenderla appieno: post-industriale, post-moderno, post-fordismo ecc. L'escamotage del low-cost alimenta la crescita di consumi e la mutazione delle periferie urbane, punteggiate ora da mall, superfetazioni post-moderne del supermercato e di un terziario incatalogabili nelle loro configurazioni tradizionali. L'effimero ha trovato i suoi templi. In tanti vi vedono «rinascita» e «neomiracolo». Nello scantinato e retrobottega di quel low-cost la Cina inizia a scalare classifiche e a nutrire immense, nuove «classi medie»: straordinaria la distrazione su questo subitaneo ribaltamento del mondo.
La nuova «guerra fredda» iniziata in Afghanistan evolve ora in forme adeguate ai tempi. Reagan brandisce contro l'URSS in mortale decadenza vecchi anatemi e mirabolanti «Guerre Stellari»: dietro le maschere dei nemici giurati cadenti Darth Vader impelagati in una sarabanda suicida.
A segnare il nuovo milioni di persone per le strade del mondo e soprattutto d'Europa animano il nuovo pacifismo di stampo realista. A differenza dei «Partigiani della Pace» degli anni Cinquanta non parteggiano. Nel mirino ora c'è la morsa che avviluppa il mondo con una stretta mortale. Salda la coscienza che dall'atomica non c'è scampo, che la pace à l'unica risposta al suicidio possibile dell'umanità. Manca qualsiasi altra realistica risposta. A far difetto - come per tutti i movimenti di nuovo conio che iniziano a caratterizzare vie e forme della politica contemporanea - l'incontro mancato con le istituzioni e qualsiasi ipotesi di riforma. Rimarrà purtroppo come segno distintivo e buco nero: il pacifismo contemporaneo sarà unica reale opposizione a tutte le guerre che punteggeranno e tormenteranno il globo, ma non riuscirà a incontrare o farsi movimento di riforma dell'esistente. Innanzitutto di quelle Nazioni Unite, nel cui cuore - il Consiglio di Sicurezza - albergano contraddittoriamente la ricerca della pace e la celebrazione, con il cosiddetto «veto», del bottone dell'olocausto finale. Non a caso tutto è fermo, a dispetto di un mondo profondamente mutato, agli equilibri e ai baratri, allora segnati.
Non a caso è su questi temi che il bipolarismo di tanta parte del Novecento celebrerà un'ultima epocale contrapposizione, segnando il passaggio ad un'altra era.
Collassi
Sarà Gorbacev a dare il là. È l'uomo nuovo, il leader cui la nomenklatura sovietica ha affidato la speranza di salvare contraddittoriamente l'URSS moribonda e la continuità del proprio potere: un compito non a caso impossibile sfociato in epocale implosione. Sta girando e stupendo il pianeta, con una grande apertura sulle teorizzazioni e le parole d'ordine da tempo avanzate dal «Gruppo dei 77», dal Sud del mondo. Dalla tribuna dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, il 7 dicembre 1988 chiede un «nuovo ordine mondiale», la «costruzione di un mondo denuclearizzato», il passaggio «dal principio del super-armamento al principio della ragionevole sufficienza difensiva». Annuncia intanto un consistente, unilaterale taglio delle forze armate sovietiche. Assume una netta prospettazione di futuro di fronte ad una tribuna chiara – l’ONU, la comunità degli Stati – e un’audience precisa: il pacifismo nelle sue varie vesti e espressioni con la sua netta rivendicazione di disarmo. Auspica la cooperazione tra i sistemi fin allora contrapposti. Intravede la «creazione comune» di un nuovo ordine, parla di «co-sviluppo», in modo da escludere sia che «i processi interni di trasformazione» procedano «lungo ‘corsi paralleli’ rispetto agli altri, senza utilizzare le conquiste del mondo circostante», sia che vi siano «ingerenze nei processi interni» tese a «modificarli sulla base di modelli ad essi estranei».
Ma sarà George H. W. Bush, il 41° presidente degli USA, a rispondergli l'11 settembre 1990. La tribuna è sempre quella delle Nazioni Unite il 1° ottobre 1990, all'indomani della ennesima risoluzione di condanna da parte del Consiglio di Sicurezza, con il concorso sovietico, dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq di Saddam Hussein. Anch'egli scorge ed auspica «un nuovo ordine mondiale: una nuova era, libera dalla minaccia del terrore, più forte nel perseguimento della giustizia, più sicura nella ricerca della pace». Bush saluta l'inizio di «una nuova era di cooperazione tra le nazioni» per un mondo in cui vi sia la «possibilità di usare le Nazioni Unite per gli scopi per cui furono concepite: come centro per la sicurezza collettiva internazionale». Di lì a poco il Consiglio di Sicurezza benedirà una guerra segnata dalla preponderanza politica, militare, economica degli USA.
Si affermerà un nuovo ordine ma con le stigmate volute da Bush. Altro che il «disarmo» perorato da Gorbacev. Il «nuovo ordine mondiale» si muove all'unisono con la nuova "Invincibile Armata", a senso unico. Intanto muove dalla caduta del Muro di Berlino e dal collasso di un intero sistema. Siamo oltre il contenimento e la deterrenza. Netta la direzione di marcia indicata dal presidente americano: la «rivoluzione dell’89 ha spazzato il mondo» e «ha trasformato il clima politico dall’Europa centrale all’America centrale e toccato ogni angolo del globo». Andiamo verso «un mondo in cui la democrazia continua a conquistare nuovi amici e a convertire vecchi nemici e in cui le Americhe – del Nord, del Centro e del Sud – come primo emisfero completamente libero del mondo possono funzionare da modello per il futuro dell’intera umanità … un mondo che si costruisce sul nuovo modello di Unione europea, un mondo intero unito e libero».
La via auspicata e tracciata da Gorbacev è stravolta completamente. Limpido il capovolgimento di orizzonti. Ci si appropria del traguardo indicato dal leader sovietico per mutare percorso e punto di arrivo. Si dà vita così ad una delle più limpide «rivoluzioni passive» viste nella storia: in luogo dell’incontro fecondo di universi il «nuovo ordine mondiale origina una epocale asimmetria, segnata dall’unilateralismo a stelle e strisce e dalla dipendenza di Sud ed Est del mondo dall’Occidente. Il tutto all’insegna di una nuova guerra globale, malamente mascherata da operazione di «polizia internazionale», e con celebrazione finale naturalmente nell’abituale vertice G7.
La scena è a Londra, luglio 1991. Per l’occasione il vertice ha aperto le sue porte a Gorbacev. È lì per chiedere appoggio e aiuti. Andreotti e Mitterrand ascoltano con attenzione. Sono turbati dalla delicatezza del momento: l’URSS e la leadership sono ad uno snodo decisivo. Gli altri Grandi sono attestati più indietro: chiedono rassicurazioni preventive. Vogliono scelte concrete su liberalizzazioni e privatizzazioni. Insomma, un mutamento di sistema. E perciò alla fine si decide di tener stretti i cordoni di borsa e della solidarietà. Gorbacev esce dal vertice con un'area di delegittimazione. Di fatto è il via libera ai golpisti, alla dissoluzione dell'URSS, a Eltsin, alla rivolta della nomenklatura che nelle varie realtà sceglierà la propria sopravvivenza, la via oligarchica, la privatizzazione generalizzata. Altro il destino preparato in Cina con oculatezza da Deng. È il partito che apre le porte della nazione: nelle mani dei vertici rimangono saldamente le chiavi. Sono loro a decidere e amministrare l'apertura al mondo.
La «fine di una storia»
Il 900 si chiude in anticipo annunciando il Terzo Millennio con lo scasso del bipolarismo e una guerra globale. Il tutto all’insegna dell’hegeliana «fine della storia» annunciata ora da Francis Fukuyama.
È il trionfo della democrazia neoliberale. Ma anche di diseguaglianze epocali. A fine secolo la globalizzazione assume un altro passo, soprattutto con il suo nuovo motore, quella fabbrica globale che, dissolta per l’orbe terracqueo e i cieli, da tempo – come hanno mostrato una serie di studi, da Naomi Klein a Robert Gilpin - pulsa in catastrofica ed antagonistica simbiosi col pianeta, a sue spese. A monitorarne costantemente il funzionamento, con l’osservazione del tumultuoso universo rappresentato dalle imprese transnazionali, ha provveduto per anni l’UNCTAD, la United Nations Conference on Trade and Development, nata nel 1964 su iniziativa dei paesi del Sud del mondo raccolti attorno alla richiesta di un «nuovo modello di sviluppo». Con i suoi rapporti annuali si è concentrata particolarmente nell’analisi delle imprese multinazionali, nella loro metamorfosi come trasnational corporations, TNC, imprese disposte a rete in barba a confini e continenti, per sfruttare al massimo le potenzialità offerte da finanza, trasporti e tecnologie informatiche nello sfruttamento d’ogni risorsa e d’ogni mercato su scala globale.
Robert Heilbronner le ha definite «travi gigantesche nella struttura del capitalismo mondiale». Nodi e reticoli si sono moltiplicati a velocità straordinaria nell’ultimo trentennio del 900: erano poco più di 7.000 le TNC, all’inizio degli anni ’70, e quasi tutte radicate nel mondo sviluppato, a Nord. Col tempo hanno preso a nascere e svilupparsi anche nel Sud del pianeta, con una dinamica che premia nettamente la ramificazione delle imprese affiliate. Con l’ingresso negli anni 90 del Novecento, la riproduzione e il lavorio delle TNC conseguono il risultato che, assieme alla fantasmagorica autonomia conquistata dalla finanza internazionale, marchia originalmente, rispetto ad altre epoche dell’economia moderna, l’attuale stagione globalizzatrice: la produzione internazionale supera e stacca stabilmente il commercio internazionale come forma-principe per provvedere di merci e servizi i mercati esteri. Nel 2002 le vendite delle affiliate estere, escludendo il commercio interno alla stessa catena delle TNC, hanno superato i 18 mila miliardi di dollari, ben più del doppio degli 8 mila miliardi di dollari in cui si è sostanziato il contributo del commercio internazionale di beni e servizi: un mutamento epocale rispetto al 1990 quando le due grandezze di fatto si equivalevano.
Tra produttore e consumatore si realizza un circuito che non ha più bisogno del mercante, o spesso abolisce questa figura: tra nazioni e mercati diversi si stabiliscono, comunque, flussi che non transitano più alle frontiere nelle usuali etichette di import ed export. Nel mezzo si bruciano gradi di libertà e radici di società e borghesie indigene. Si ibridano per vie inedite culture e civiltà. Si fondono regolazioni. Non v’è nulla di meccanico, infatti, in queste evoluzioni della produzione internazionale. Esse non obbediscono ad una presunta naturalezza degli scambi o ad una pretesa onnipotenza della tecnica e dell’innovazione scientifica. A dimostrarlo sta l’incessante e inesausto lavorio di legislatori e interpreti.
A fine 1980 – sottolinea l’UNCTAD nei suoi 2003 e 2005 World Investment Report – erano in vigore solo 181 trattati bilaterali in materia di FDI. A fine 2004 si è passati ai 2.392 accordi vigenti. E così per gli accordi tesi ad eliminare la possibilità di doppia tassazione, passati da 719 a fine 1980 a 2.559 nel 2004. Né il passo è stato rallentato dal trauma dell’11 settembre. Altre misure liberalizzatrici in materia di investimenti sono state varate. E così il regime di liberalizzazione dei FDI si irrobustisce: è la sua opera di neutralizzazione dei ‘particolarismi’ statali, l’accelerata promozione della abdicazione statuale, della deregulation, che costruisce il nuovo mercato globale. È nella rarefazione dello spazio planetario che, più limpidamente che altrove, il mercato si staglia - per riprendere un’efficace formulazione di Natalino Irti – come «locus artificialis», ordine disegnato da regole, decisioni e accordi, figlio di una «assoluta ed integrale politicità». La deregulation neoliberista è figlia di società e mercati altamente evoluti, di Stati e rapporti interstatuali, burocrazie transnazionalizzate e comitati sovranazionali, asciugati d’ogni partecipazione e controllo democratici, ma capaci di assicurare, col minimo di costrizione politica, il massimo di garanzia al diritto di proprietà e allo scambio mercantile. Nel mercato figliato da questa rete di interconnessioni, la sede e il momento della decisione evaporano, diventano indistinguibili: «poco importa - come ha ben evidenziato Jean-Marie Guéhenno – che una norma sia imposta da un’impresa privata o da un comitato di funzionari. Non è più l’espressione di una sovranità, ma semplicemente un riduttore di incertezze, un modo di ridurre il costo delle transazioni, aumentandone la trasparenza». In questi spazi torna a esplicare un grande potere innovativo una nuova lex mercatoria: il diritto cosmopolita inventato, contrattato e affermato giornalmente sui mercati. Il suo dominio però spesso s’arresta là dove poteri forti o un humus consolidato le permettono di attecchire e far norma. Stenta invece a farsi sovrana o trainante nelle società ancora alle prese con transizioni e modernizzazioni. Lì volentieri si dissolve o perverte in commistioni mafiose o alchimie medioevali o tribali.
La decisione dei governanti ‘sgombra’ dal controllo della politica uno spazio tendenzialmente globale. Lo ‘libera’ e ‘adatta’ all’espansione del mercato. Lì si realizza – per dirla con Bourdieu - «la politica dell’antipolitica, la politica di spoliticizzazione». Adesso lì può fluire liberamente il prodotto della catena disegnata dal made in the world. Al passaggio di secolo la produzione lorda delle sole affiliate estere pesava per un decimo sul prodotto globale complessivo del pianeta: a fine 1982 ne costituiva un ventesimo. È in questo network la fucinadel mondo nuovo, qui si sono concentrate le innovazioni tecniche che hanno fatto da bussola per il mondo intero, qui la rivoluzione digitale e della comunicazione ha organizzato e stretto in maglie sempre più strette e veloci una rete produttiva sempre più larga, con un ricambio rapidissimo di tecnologie e specializzazioni
Una comunicazione afona
È proprio negli USA che però possiamo rintracciare la sottolineatura di un ulteriore tratto distintivo del passaggio d'epoca. Ad operarla un protagonista per eccellenza della nuova stagione in cui si è avventurato il capitalismo contemporaneo, ovvero Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana. In un discorso del 1998 egli ha modo di sottolineare una netta e comunque paradossale insistenza sulla minorità, sulla soggezione del lavoro come cardine centrale della nuova era segnata proprio dal trionfo del capitale intellettuale, di quello che Thomas A. Stewart ha chiamato «brainpower», la «potenza del cervello». Da sempre cauto rispetto alle letture più estreme, Greenspan con molta decisione individua a tratto tipizzante del lungo periodo di crescita degli anni 90 l’avvento di una new economy. A caratterizzarla il «mutamento strutturale» prodotto dall’information techonology, dall’irruzione massiva ed incrementale in ogni campo della produzione e della vita associata delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione. Non ne sono sgorgati solo nuovi prodotti o mercati, o inedite soglie di produttività, quanto una straordinaria rivisitazione dei poteri di rivoluzionamento o «distruzione creativa» che già Marx e Schumpeter avevano attribuito al capitalismo. Il mutamento nel modo di produrre e consumare attivato dalla nuova ondata innovativa ha così sciolto in flussi comunicativi gerarchie e apparati, esploso la fabbrica in aggregati reticolari, nebulizzato i bacini di socialità della democrazia moderna nei pulviscoli di un nuovo individualismo consumistico.
Ad attirare l’attenzione di Greenspan non è stata però solo l’indistinta percezione dei nuovi rapporti di forza disegnati da un ciclo di innovazioni che permette di ridurre drasticamente il costo del lavoro per unità di prodotto. Egli si è soffermato piuttosto sui tratti onnivori dell’information technology, sulla sua inedita capacità di appropriarsi del lavoro sociale, ben oltre le specifiche competenze messe a valore, e di metabolizzarlo in linee di software, in flussi di comunicazione, in nuova potenza ordinatrice e di controllo. Il suo discorso s’accentra così sulla rapidità con cui il processo di innovazione metabolizza e brucia il lavoro, esibendone sistematicamente l’«obsolescenza» di competenze e capacità e causandone la mancanza di reattività. È lì la fonte dell’angoscia ed insicurezza che pervade il mondo del lavoro e che lo riduce per tutta un’epoca in uno stato di evidente minorità. Già Paul Samuelson, Nobel per l’Economia e decano degli economisti USA, aveva insistito su questa specificità del nuovo capitalismo, sottolineando il duplice avvento di una Ruthless Economy, un’economia senza pietà, e di una Cowed Labor Force, una forza-lavoro intimidita, snerbata di capacità contrattuali nelle nuove condizioni di concorrenza e di lavoro e incapace di contrastare il restringimento del Welfare. Da un diverso angolo visuale, Robert Reich aveva intravisto nell’avanzata di questi processi la causa di una mutazione più generale: la trasformazione del mondo del lavoro in «anxious classes», classi ansiose, non più sicure del futuro e del loro spazio nel «sogno americano», preda ormai di sommovimenti epocali nel panorama politico degli States.
Ma anche questa è già storia. Nuovi capitoli e rischi si aprono ora, nel momento in cui l’invadenza dell’informazione e delle sue leggi di movimento finisce col determinare anche la discesa nell’infinitamente piccolo, orienta e fa da guida all’assalto al mistero della vita, alla sua creazione in vitro. Con la mappatura e decifrazione del genoma si è compiuto un altro salto nella storia umana, grazie alla centralità acquisita nello sviluppo della biologia novecentesca dal gene come codice informatico, capace ad un tempo di veicolare informazione e di eseguire un programma, di trasmettere leggi di sviluppo e di attuarle. Oggi, nel momento in cui la clonazione dell’embrione umano o di cellule umane marca il nuovo passo della scienza, il sequenziamento del genoma appare solo il primo capitolo, non l’ultimo, di una rivoluzione ancora tutta da compiere. Un passo che, comunque, permette di conoscer meglio la «zavorra storica» accumulata dalla genetica, la miriade di condizionamenti, materiali e ideologici, che ha condotto a trascurare la complessità delle interazioni tra i geni e l’ambiente e ad incamminarsi per le scorciatoie di semplificazioni meccaniche.
Oltre un secolo e mezzo fa, Friedrich Engels e Karl Marx provavano a delineare compiti e percorsi del comunismo sull’inno più entusiastico e convinto alle funzioni rivoluzionarie della borghesia, alla capacità del capitalismo di trasformare e unificare il mondo. A distanza di quasi un secolo, mentre il mondo precipitava nel carnaio della II guerra mondiale, Joseph Alois Schumpeter, in simpatetico colloquio con il Marx più maturo, poneva ad essenza del capitalismo una capacità evolutiva fondata sul «processo della distruzione creatrice», in grado di sciogliere ogni «strato protettivo» della società capitalistica, di abbatterne tutti i «muri» e le «istituzioni». Al tramonto del Novecento quelle analisi e diagnosi si sono rivelate ancor oggi un punto di partenza insostituibile per l’anatomia dei processi di globalizzazione. Non solo per misurarne estensione e profondità. Ma soprattutto per decifrarne, rispetto all’ultimo trentennio, il timbro schiettamente neoliberista, per comprendere come il loro passo sia stato misurato e orientato sull’algoritmo assoluto del mercato.
Strategie costituenti
In quel 1991 Londra però non ospita solo il fatale vertice del G7 - allargato per la prima e l'ultima volta all'URSS di Gorbacev. A novembre, nei giorni 7 e 8, sarà il turno della Nato con il Meeting dei capi di Stato e di Governo chiamati ad elaborare e firmare il Nuovo Concetto Strategico dell'Alleanza. È la prima volta che l'Alleanza fa un passo simile. Qualche mese prima - il 1° luglio - si è sciolto il Patto di Varsavia. L'Alleanza Atlantica però non accenna nemmeno qualcosa del genere. Si rinnova e riscrive le linee fondamentali che ne reggono l'esistenza e guidano il funzionamento. Non lo fa, però, ritoccando i trattati istitutivi. Ricorre all'escamotage di ritoccare il cosiddetto «Concetto Strategico»: un documento di analisi e guida all'azione nel contesto internazionale, che però fino al 1991 si muoveva nella cornice certa offerta dal trattato istitutivo. Nel 1991 scompaiono URSS e Patto di Varsavia. Ci sarebbe bisogno di rinnovare i trattati ovvero lo scopo e il raggio di azione dell'Alleanza. Evidentemente un passo avvertito come un azzardo. Troppo pericoloso: nuovi trattati richiedono ratifiche dei parlamenti nazionali. E se vengono sollevati dubbi? Discussioni? Meglio ritoccare le strategie, anche se queste ridisegnano scopi e confini dell'Allenza. A Londra, si decide infatti che l'Allenza può e deve intervenire non più solo in caso di attacco al territorio di uno degli Stati aderenti all'Allenza. Adesso il raggio di azione si espande ai «rischi molteplici e multi-direzionali» della nuova scena internazionale. Fondamentale diviene ora la proiezione e la capacità di proiettarsi oltre i propri confini ad esempio per parare o anche prevenire pericoli nei rifornimenti o nell'accesso a fonti energetiche o emergenze simili. Magari con forze di reazione rapida o strumenti similari.
Qualche anno dopo, la dissoluzione jugoslava e l'intervento in Kosovo, deciso unilateralmente dalla Nato nell'impossibilità di un intervento ONU, determina una rielaborazione del Concetto Strategico, concepita e varata in occasione del 50° anniversario dell'Alleanza. Sarà quella l'occasione per varare l'incredibile invenzione delle operazioni «non art.-5», ovvero la possibilità di muover guerra fuori dai confini degli Stati aderenti. Insomma, proprio quanto appena fatto in Kosovo, in rottura del diritto internazionale e in nome del cosiddetto «intervento umanitario». In rottura dell'art. 5 dell'Alleanza che, in obbedienza agli ordinamenti internazionali, prevede solo la guerra difensiva. Da quel conflitto e da quei mutamenti strategici e ordinamentali nasce l'inesausto allargamento della Nato ad Est. In alcuni momenti - come ad esempio con il Concetto Strategico del 2010, varato a Lisbona, e l'istituzione del Consiglio Nato-Russia - coinvolgendo persino l'antagonista storico nel processo decisionale dell'Alleanza, sia pure senza concessione di un potere di veto sulle decisioni finali.
L'invasione della Crimea e l'attuale guerra in Ucraina hanno drammaticamente interrotto quel cammino, imprimendo altro segno e ben altra valenza all'espansione della Nato. Ne è sortita l'ultima versione degli orientamenti e comandamenti strategici, varata a Madrid lo scorso mese di giugno. In essa il potenziale raggio di azione s'allarga all'Asia con una novella, inquietante individuazione delle minacce fondamentali: adesso accanto alla bellicosa Russia di Putin si staglia la potenziale minaccia cinese.
Il tutto interpretato, riscritto, varato dal protagonismo congiunto degli esecutivi, al riparo dai parlamenti, dalla sovranità popolare. La decisione fondamentale sulla pace e sulla guerra, sulle strategie per parare il conflitto e garantire concordia e fratellanza universali, assicurare sicurezza è da tempo sequestrata nelle democrazie occidentali da tecnocrazie e governi, da cerchie ristrettissime di persone.
Percorsi non dissimili le democrazie europee da circa un trentennio hanno intrapreso nella lenta, faticosa, costruzione della nuova Unione Europea. Lì ben quattro distinti Trattati, con relative ratifiche parlamentari, fortunatamente segnano con pietre miliari il cammino percorso da Maastricht al giorno d'oggi. Nell'esame, però, delle vie volta a volta intraprese, dei timbri impressi alle nuove regolazioni comunitarie conquistate, si fatica molto ad intravedere il lavorio di popoli e parlamenti come di partiti e movimenti. Anche qui emerge l'applicazione costante, la cura di cerchie ristrette di esperti e governanti. Esemplare, l'affresco fornito da osservatori indubitabili quali Guido Carli e Mario Monti a proposito del peso esercitato dal cosiddetto «vincolo esterno» nella formulazione concreta dei Trattati istitutivi della UE. In realtà, come si è già avuto modo di sottolineare in passato, in quelle regolazioni vi è la prova più evidente che da tempo, lentamente ma decisamente, al «costituzionalismo dei governati» si è venuto frapponendo, con formule astruse ma universalmente accettate, un «costituzionalismo dei governanti». Giorno dopo giorno è questo a fagocitare e assorbire il concreto esercizio della sovranità popolare, sottratta a nazioni esauste e parlamenti disincarnati dalle soggettività tradizionali.
Cupi orizzonti
Pandemia e guerra stanno accentuando queste tendenze. Antonio Cantaro ha di recente evidenziato fin dove si sia spinta ormai «la pretesa di governare senza prendersi cura dei governati, di sorvegliare burocraticamente la vita di uomini e donne senza ascoltarne le domande, le ragioni, le sofferenze». In altre analisi, si solleva un interrogativo simile, ma ancor più radicale: «può sopravvivere alla guerra il costituzionalismo democratico moderno». In un quadro dominato da un altissimo - e a tratti esclusivo - grado di formalismo giuridico, alcuni interventi attirano meritoriamente l'attenzione su un punto decisivo della guerra intrapresa dalla Russia di Putin all'Ucraina: la minaccia dell'atomica, del suo possibile uso.
Siamo ad un tornante decisivo. Quelle dichiarazioni - assieme al concreto esercizio del cosiddetto «diritto di veto» nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU - sigillano la guerra ai voleri e all'iniziativa del nuovo Zar e determinano buona parte delle mosse del campo avverso, senza lasciar margini o spazio per mosse alternative. Pena la minaccia suprema. Si misura su questo terreno esplosivo oggi lo iato degli anni passati: grandi marce per la pace, imponenti potenze nate nelle strade del mondo, ma senza saper o poter attingere ad un reale, concreto movimento di riforma, quale ad esempio quello intrapreso, ma lasciato in sospeso dei trattati per il disarmo atomico generalizzato.
Così come oggi misuriamo anche su altri terreni essenziali - magari, ad un primo sguardo, apparentemente minimali - il grado di decadenza della democrazia e della partecipazione popolare.
Siamo partiti in queste note dalla constatazione di una astensione dal voto divenuta in Italia nel tempo il partito più gettonato: una scelta spesso assai meditata e dichiarata, con un elettorato fedelissimo e in continua ascesa. A spadroneggiare – specialmente nelle tornate amministrative - v’è però altro: una frammentazione continua di coalizioni elettorali e liste. Non sempre frutto di creatività locale e a vita limitata: non più di qualche mese. Ad applicarsi e con costanza – nell’esplorazione continua di un «cubo di Rubik» con combinazioni e colori infiniti - spesso ci sono consorterie assai composite, quasi sempre annidate nei gangli delle istituzioni regionali e negli intrecci, straordinariamente contorti, della ‘governance’ ai più vari livelli: magari nelle infinite combinazioni di privato e pubblico, economia e politica, che con varie stratificazioni orienta, guida e condiziona la vita civile della nazione. Nel Mezzogiorno con una intensità mai toccata. Spesso in combutta con la «società incivile».
La combinazione perversa di astensione e frammentazione produce effetti perversi mai toccati prima. Dalle urne emerge una sorta di «democrazia pilotata» in cui quasi sempre non v’è più garanzia alcuna per la segretezza del voto. E non si tratta solo di fenomeni da paesello. L’analisi del voto anche in città di rilevante grandezza rivela che, con livelli di astensione oltre il 40% e nel confronto tra coalizioni composte da oltre 7-8 liste, il più delle volte il voto alle varie formazioni rivela preferenze addensate attorno ad un massimo di 2-3 ‘capibastone’. Grazie anche ad una oculata distribuzione del voto di genere e alla gestione di gruppi privati nelle reti social – WhatsApp imperante – il voto segreto di fatto non esiste più. Illuminante la rilettura del voto di lista scomposto e riletto nella distribuzione tra i vari seggi elettorali e puntualmente annotato dai vari rappresentanti di lista. Il che spesso muove interessi innominabili.
Può accadere così che diventi assai indigesto proprio il voto amministrativo, quello in cui la distanza tra governanti e governati è più stretta. Proprio allora, il più delle volte, ci accorgiamo che ci sfugge di mano, conteso da oligarchie ristrette, aduse al peggiore trasformismo. Non è fantascienza, purtroppo. Un Grande Fratello diffuso orienta e governa grazie a frammentazione e astensione gran parte del voto. Specie nel Mezzogiorno.
Non si annunciano grandi futuri, grandi speranze.
Bibliografia
A. Applebaum, Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism, 2020, tr. it. Il tramonto della democrazia. Il fallimento della politica e il fascino dell'autoritarismo, Mondadori, 2021.
Azzariti et al., Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?, Editoriale Scientifica 2022.
N. Baverez, Les Trente Piteuses, Flammarion 1998.
P. Bourdieu, Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, tr. it. Controfuochi 2. Per un nuovo movimento europeo, Roma, manifestolibri.
A. Cantaro, Postpandemia: pensieri (meta)giuridici, Giappicchelli 2021.
M. Crozier, S. P. Huntington, J. Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, tr, it. La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale, Franco Angeli 1977.
J. Fourastié, Les Trente Glorieuses: Ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Fayard 1979.
C. Galli, Democrazia senza popolo. cronache dal Parlamento sulla crisi della politica italiana, Feltrinelli 2017.
R. Gilpin, The Challenge of Global Capitalism. The World Economy in the 21th Century, Princeton University Press, 2000, tr. it. Le insidie del capitalistmo globale, Egea-Università Bocconi Milano, 2001.
J.-M. Guéhenno, La fin de la démocratie, Flammarion, 1993, tr. it. La fine della democrazia, Garzanti, 1994.
R. L. Heilbronner, Twenty-first Century Capitalism, Anansi, 1992 tr. it. Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori, 2006.
G. Kepel, La Revanche de Dieu : Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde,, Seuil, 2003, tr. it. La rivincita di Dio, Rizzoli, 1991
N. Klein, No Logo. Taking Aim at the Brand Bullies, Flamingo, 2000, tr. it. No Logo. Economia globale e nuova contestazione, Baldini & Castoldi, 2001.
P. Mair, Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy, Verso 2013, tr. it. Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti, Rubbettino 2016.
P. W. McCracken et al., Towards Full Employment and Price Stability, OECD 1977.
D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, The Limits to Growth. A Report for THE Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind.
I. D. Mortellaro, Dopo Maastricht. Cronache dall'Europa di fine millennio, La Meridiana, 1998.
I. D. Mortellaro, I signori della guerra. La Nato verso il XXI secolo, manifestolibri 1999.
E. Nolte, Gli anni della violenza. Un secolo di guerra civile ideologica europea e mondiale, Rizzoli 1995.
F. Rampini, Suicidio occidentale. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori, Mondadori 2022.
P. A. Samuelson, Wherein Do the European and American Models Differ?, in «Temi di discussione», n. 320, Banca d’Italia, novembre 1997.