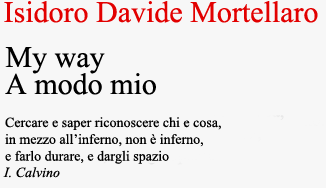Atlantismo e Costituzione europea
Atlantismo e Costituzione europea
Per iniziare, vale forse la pena di sviluppare qualche breve annotazione sul clima politico generale che aleggia attorno a questo nostro incontro, pur così attento alle tante sfaccettature della crisi che oggi sfilaccia ed attarda l’Europa. In realtà, stiamo celebrando elezioni senza Europa. La mente non va solo alle forme desolanti in cui, quasi ovunque sul continente, si va svolgendo la campagna elettorale, alla sua cifra invero modesta o – per quanto riguarda il nostro paese – alle polemiche singolarissime e mortificanti che hanno punteggiato e accompagnato, ad esempio, la scelta delle candidature e la formazione delle liste. A tratti rimane solo l’indecisione, l’incertezza di fronte a ciò che non si sa come etichettare: farsa o tragedia.
Parlando di elezioni senza Europa, il pensiero va ad altro, ad una questione squisitamente istituzionale. Quale sarà l’orizzonte costituzionale entro il quale si troverà ad operare il Parlamento che ci accingiamo ad eleggere? Di quali poteri sarà dotata la rappresentanza che stiamo selezionando? Quale segno potrà imprimere il Parlamento europeo alla sua dialettica con le altre istituzioni comunitarie?
Come è largamente noto la ratifica dei cosiddetti Trattati di Lisbona non ha ancora compiuto il suo corso. Finora 25 Stati hanno espresso il loro sì alle Carte d’Europa tracciate a Lisbona, sia pure con Polonia e Repubblica ceca ancora alle prese con gli adempimenti finali della firma presidenziale. La ratifica d’Irlanda è legata invece alla celebrazione costituzionale di un secondo referendum. Non è difficile prevedere che esso si svolgerà in un clima ben diverso da quello che aveva caratterizzato la prima, negativa consultazione popolare. Nel giudizio e nella mobilitazione degli irlandesi
peserà, innanzitutto, la crisi globale che ci avvolge: proprio in Irlanda ha colpito più duro, mostrando quanto le sorti dell’isola siano profondamente influenzate dalle decisioni comunitarie, dai flussi con cui la finanza europea aveva saputo attivare il balzo della tigre irlandese. In secondo luogo, conteranno le esenzioni ed eccezioni, gli opting out, che puntualmente già s’annunciano copiosi e particolarmente allettanti, mirati soprattutto a mitigare ed addolcire l’euroscetticismo isolano.
Meno nota è la vicenda tedesca. Qui, qualche mese fa, il presidente della Repubblica Horst Köhler aveva reso noto che non avrebbe firmato la ratifica dei Trattati varata da Bundestag e Bundesrat fino a quando la Corte costituzionale di Karlsruhe non avesse eventualmente sciolto le riserve sulla loro conformità alla Legge fondamentale, la Costituzione tedesca del 1949, Grundgesetz. Pendono infatti di fronte al Bundesverfassungsgericht vari ricorsi molto puntuti, tutti esemplarmente volti, in sostanza, a sollevare la questione della cosiddetta Competenza delle Competenze: ovvero il potere di una istituzione di modificare autonomamente la panoplia delle proprie attribuzioni sovrane. Tra i vari quesiti spiccano in particolare due ricorsi: da un lato, quello presentato da Die Linke, la formazione nata dalla fusione tra la PDS e la sinistra socialdemocratica di Lafontaine, con rilievi particolarmente accentuati rispetto alla possibile perdita di sovranità in materia di Stato sociale e di impegni militari all’estero; dall’altro, quello presentato da un deputato della CSU, Peter Gauweiler, il partito cristiano bavarese. In quest’ultimo caso, il ricorrente – capitalizzando abilmente i paletti già posti nel 1993 dal Tribunale federale in un famoso pronunciamento sui Trattati di Maastricht – paventa una possibile perdita di controllo da parte delle istituzioni parlamentari tedesche sugli ulteriori sviluppi di un processo di integrazione sovranazionale attivabili, in alcuni casi e materie, con decisioni autonome delle istituzioni europee.
Non è difficile ipotizzare – a fronte anche di una orgogliosa e miope autosufficienza già manifestata negli ultimi tempi dalle élites tedesche, ad esempio a fronte della crisi finanziaria ed economica – che il Bundesverfassungsgericht possa, sulle orme degli
ammonimenti del 1993, stringere ulteriormente lo spazio di manovra delle istituzioni comunitarie in nome delle prerogative sovrane nazionalii.
Ecco il punto: stiamo eleggendo un Parlamento europeo, senza poter dire in quale Europa esso dovrà destreggiarsi, a quale Europa dovrà pure dare un’anima, entro quale cornice normativa ed istituzionale i suoi parlamentari dovranno muoversi. Sarà quella costruita in forme incerte e complicatissime a Lisbona? O per effetto di qualche botto nelle terre tedesche o irlandesi dovremo continuare a muoverci con i ferri vecchi del Trattato di Nizza: pensati già inservibili nell’Europa a 15 e divenuti ingombro, ostacolo nell’UE a 27. Incapaci persino di indicare gli elementi generali dell’Europa futura, si finisce sospesi nel limbo di una politica, di elezioni senza Europa, fuori contesto. Perché meravigliarsi che non si sia entusiamo o partecipazione o che campaggi solo muffa, se non putridume?
Venendo al dibattito odierno, devo confessare di essere rimasto molto affascinato dall’introduzione di Antonio Cantaro. Ne ho ricevuto grandi stimoli, così come mi hanno straordinariamente interessato alcune riflessioni che si sono venute accumulando nella nostra discussione. Cantaro perspicuamente distingue globalizzazione europea da globalizzazione americana, mentre alcuni degli intervenuti vi aggiungono ulteriori notazioni, introducendo la categoria di impero o ricordando lo scavo straordinario già fatto da Marx o le formidabili anticipazioni consegnate nella storia delle Repubbliche marinare. Insomma, stentiamo a prendere le misure del mondo intero che sempre più da presso ci afferra alla gola quando non ci crolla addosso. In realtà, le nostre difficoltà a definire il quando e il dove hanno piuttosto a che fare con il cosa: è l’oggetto stesso d’analisi che spesso ci sfugge, perché il più delle volte non ci accordiamo su ampiezza e qualità dei fenomeni da sottoporre alla nostra lente di osservazione.
Fondamentale, per raggiungere un buon punto di partenza comune, è togliersi dal cono d’ombra proiettato dall’egemonia neoliberista, finora egemone – anche rispetto ai più fieri avversari – nel proporre un’idea di globalizzazione prettamente economica, come rivoluzione di mercati liberatisi dalle corazze imposte da decenni di
regolazione statualista. Finalmente liberi, essi sarebbero ora capaci di autoregolarsi al passo della naturale interazione dei soggetti imposta dall’ottimale ed egualitaria regolazione dello scambio. Indipendentemente dalla crisi che ha colpito il fondamentalismo liberista più esagitato e pensando ai processi che in maniera travolgente ci hanno trascinato sulla soglia del XXI secolo, io propendo per un uso della categoria di globalizzazione più ampio. Penso a qualcosa che afferri e plasticamente sappia fotografare le forme sempre più strette e cogenti in cui alla fine del XX secolo il mondo e l’umanità, soprattutto, si sono venuti costituendo in comunità di destino.
Certo adesso, dopo lo tsunami che ha sconvolto l’infrastruttura bancaria e finanziaria del mondo, assistiamo anche a rinculi, a forme di delocalizzazione così come a conati protezionistici. In realtà tutti sanno bene che al di là e dietro le primazie che si prova a conquistare sul campo, s’approfondiscono livelli e forme dell’interdipendenza generale, globale. Obama sa bene che non potrà salvare il dollaro senza i cinesi e in realtà ha annunciato che seguirà questa strada. Sarkozy potrà anche provare ad irrobustire l’industria automobilistica francese, ma per meglio competere su un mercato ancor più di ieri globale e alle cui nuove regole egli stesso oggi sta portando un ulteriore tassello. Il clima, l’ambiente stanno esercitando su di noi costrizioni tali da indurre a mutare le forme della produzione, del consumo: nel nuovo vincolo che così matura tra noi e la natura avanza, sia pure lentamente e tra contraddizioni, una inedita condivisione, in nuove forme di eguaglianza, di beni comuni.
Ecco, di fronte a questi mutamenti che – pur in presenza di una crisi di straordinaria profondità, paragonabile solo a quella non a caso definita «Grande» - stringono nuovi lacci globali sulle nostre vite, credo vi sia una immagine di Marshall McLuhan che oggi, ancor più di ieri, ci permette di contornare al meglio natura e dimensioni dello sconvolgimento immane del mondo chiamato globalizzazione: «nell’era elettrica abbiamo come pelle l’intera umanità»ii. Ancora oggi, con i piedi ormai ben saldi nel XXI secolo, mi sembra che questa definizione colga plasticamente natura e profondità dei mutamenti epocali che – per inedite cogenze di scienza e merce e
dopo i crolli di Muri e Torri - sono venuti costituendo il mondo come nostro habitat primario. Contrariamente all’altra immagine, molto più abusata, dello stesso McLuhan sul «villaggio globale», questa raffigurazione non ha nulla di bucolico o egualitario. L’anima, la muove piuttosto una straordinaria, drammatica asimmetria. V’è modo e modo di indossare l’umanità come seconda pelle: un cittadino occidentale lo fa con una dovizia di mezzi inaccessibili ad un «senza-terra» brasiliano o ad un nativo australiano, così come diversa è la capacità di interpretare e tradurre stimoli depositata nelle metropoli del mondo ricco, secondo che si abiti in un attico del centro o negli scantinati di periferia. Tra questi estremi possono essere depositate - e comunque decifrate - tutte le gerarchie sociali, educative, politiche che armano il nostro mondo. Nel più recente passato ne abbiamo avuto plastica ed anche emozionante esperienza, come cittadini di un mondo aduso da tempo ormai a «pensare globalmente ed agire localmente» e perciò partecipi o tifosi – nel nostro piccolo e sia pure a livelli estremamente differenziati – dello scontro elettorale tra Obama e McCain. Quanta differenza, comunque, rispetto all’asimmetrica e inversa rivisitazione di quella massima praticata negli USA: lì un cittadino americano, pensando localmente alla sua assistenza sanitaria o a suo figlio in guerra, ha scelto tra democratici e repubblicani. Ha finito però con il lanciare il mondo tutto in una inedita avventura, fortunatamente sospesa alle speranze incarnate da Barack Hussein Obama.
In rapporto allora alla categoria di globalizzazione così definita, credo che ora risulti più chiaro il nostro bisogno di figli del XXI secolo – noi, ma ancor più i giovani qui raccolti e che affollano le nostre aule - di fare compiutamente i conti con il Novecento tutto, per ripensarlo e comprendere appieno. Senza illuderci, sulla base di impotenti titanismi, di oltrepassarlo o buttarlo nel dimenticatoio, magari perché gravato di troppe sventure. Si potrà così accogliere con maggiore consapevolezza la distinzione tracciata da Cantaro tra «globalizzazione europea» e «globalizzazione americana» e provare a scavarvi, andare più a fondo.
Potremo forse scoprire allora che, nel secolo breve, tra le due sponde dell’Atlantico non vi sono state solo opposizioni epocali tra ‘ismi’, ma anche una lunga e
complicata osmosi che di fatto ha tenuto a battesimo, promosso e sospinto le varie tappe della globalizzazione che ora abitiamo: parlo dell’atlantismo. E’ alla sua ombra che siamo cresciuti ed è alla sua ombra che è maturato il passaggio epocale tra pax britannica e pax americana. Soprattutto è alle sue fonti che l’Occidente ha saputo alimentarsi, per dare battaglia e forma infine al mondo schizzato fuori dal XX secolo.
Cosa dobbiamo intendere con questa categoria? Non certo o non solo il portato delle teorie, politiche o strategie con cui all’indomani della II Guerra Mondiale gli USA si sono insediati come protettori dell’Europa occidentale, al centro di un nuovo sistema istituzionale e di alleanze politico-militari. L’atlantismo, nella sua sostanza, è altro: nasce come orgogliosa rivendicazione della comune partecipazione alle tre rivoluzioni – inglese, americana e francese – che sulle due sponde continentali hanno costituito l’Occidente e il suo primato, spirando fino nelle vele di rivolgimenti e rivoluzioni divenuti poi Oriente altro ed alternativo. Di quell’atlantismo sono figlie la Lega delle Nazioni prima e l’ONU dopo, al di là delle indecisioni e della ritirata decisa dagli USA nel primo dopoguerra. L’oceano era comunque stato varcato e l’interscambio culturale e politico tra le due sponde era già allora divenuto fittissimo e irreversibile: precocemente lo si battezzò americanismo o americanizzazione. All’atlantismo, soprattutto nella sua declinazione antifascista, dobbiamo quella comune, straordinaria dilatazione dei confini della libertà dei moderni – titolata a Roosevelt come a Beveridge – come «libertà dal bisogno e dalla paura», trasfusa poi nei trattati costituenti del mondo che abitiamo: dalla Carta delle Nazioni Unite alla Proclamazione dei diritti fondamentali dell’uomo alle Costituzioni di tanti paesi europei, tra cui quella italiana. E’ in questo lascito vivente che inforchiamo gli occhiali con cui leggiamo le sfide del mondo: con quel diritto, quell’idea di politica, quella cultura. Certo ci sono state anche rotture e discontinuità: per nominarne una, basterà pensare a Bush e alle forme in cui ha rovinosamente rilanciato l’eccezionalismo a stelle e strisce, nutrito magari anche di una compiuta e definitiva scelta per il Pacifico ereditata da Nixon.
All’atlantismo – inteso anche latamente come sistema di valori costruito sulla centralità della ragione e sulla primazia della scienza – dobbiamo però anche, soprattutto nella valenza antifascista consegnata nell’elaborazione del concetto di deterrenza, quell’innovazione capitale che ha straordinariamente contribuito a forgiare il mondo e l’umanità in comunità di destino, deflagrando il 6 agosto del 1945 a Hiroshima. La nascita di quell’ordigno - rivoluzionaria rispetto ai confini fino allora conosciuti tra politica e guerra, pace e guerra - fu presieduta da una straordinaria comunità di cervelli e volontà, fusa assieme dall’orrore per la persecuzione razziale e dalla volontà di riconsegnare, contro la barbarie, una chance alla storia e al futuro. E’ all’ombra di quel fungo, però, che le speranze di un mondo migliore e la stessa vita delle Nazioni unite finirono ibernate in quella strana forma di guerra condannata, dalla sua stessa ultimativa logica, a rimaner fredda, pena il suicidio dell’umanità. Eccezionale rimane ancor oggi la capacità profetica allora rivelata da Freda Kirchwey, cervello e animatrice di «The Nation», la rivista più antica della sinistra americana, ancor oggi giornale di riferimento della sinistra democratica americana. Pochi giorni dopo la dissoluzione di Hiroshima e Nagasaki, con le Carte delle Nazioni Unite già scritte ma non ancora firmate e ratificate, in un editoriale del 18 agosto, significativamente titolato con l’ammonimento One World or None, la Kerchwey concludeva lapidariamente sul destino ormai segnato dell’ONU: «Le Nazioni Unite sono passate in un solo giorno dall’infanzia alla vecchiaia». Ogni affidamento o illusione sulla possibilità che i quattro poliziotti immaginati da Roosevelt come cardine del Consiglio di sicurezza – e divenuti poi cinque con la promozione della Francia di De Gaulle – potessero garantire la pace nel mondo si infrangeva sul lancio autorizzato da Truman dell’atomica, sull’irreversibile e unilaterale rottura dell’equilibro strategico disegnato dal suo predecessore.
Perché ricordare quella storia? Non solo e non tanto per rammentare la costituzione più intima del mondo moderno: mai revocata, semmai approfondita dall’evoluzione del globo sia con due drammatici e spettacolari crolli, sia con i mirabolanti sviluppi di comunicazione e scienza costitutivi della vita stessa dell’uomo contemporaneo e
della sua formidabile dilatazione. Piuttosto per sottolineare che proprio la filosofia funzionalistico-comunitaria, giustamente ricordata da Cantaro come matrice del concreto processo storico di integrazione europea, è la figlia più conseguente dell’atlantismo: tanto dei suoi equilibri strategici (la concentrazione sull’economico dell’Europa possibile, permessa nel confronto bipolare dalla cornice di sicurezza atlantica assicurata dall’«amico americano»), quanto delle sue politiche economiche (ispirate dall’impulso venuto d’oltre oceano con il piano Marshall e lungo i cicli governati da quell’altra atlantica innovazione disegnata a Bretton Woods: centralità del dollaro e americanizzazione della vita quotidiana promossa dai consumi di massa). Anche qui una citazione forse può valere più di mille ragionamenti. Viene dalle Memorie di Jean Monnet circa la filosofia del suo piano per modernizzazione la Francia. Vi si narra dei suoi colloqui con De Gaulle negli USA di fronte alla spettacolare dimostrazione di forza emanata dall’american way of life: «Parlate di grandeur, ma i Francesi sono piccoli oggi … è necessario che si modernizzino … c’è bisogno di produrre, di produttività … bisogna trasformare il paese dal punto di vista materiale»iii. Non a caso nelle più meditate rivisitazioni dei Trente Glorieuses, del trentennio di crescita fordista del secondo dopoguerra, in Francia non si omette mai di dissociare lo sviluppo dello Stato sociale dalla generale azione di rattrapage, rincorsa del modello americano, riallineamento e convergenza nello sviluppo complessivo dei consumi di massaiv.
Se è andata in questo modo, se queste notazioni possono avere un minimo di consistenza, allora forse si può provare a rispondere con maggiore plausibilità alla domanda sospesa sulla crisi d’Europa, sulla sua capacità – venuti meno all’indomani del 1989 il vincolo e la risorsa del bipolarismo – di proiettarsi come Unione Europea al di là degli orizzonti e dei propri limiti storici, verso nuove mete. Eccoci così alla storia più recente d’Europa, inevitabilmente frammista alla cronaca, e alla questione del costituzionalismo europeo e della sua natura. Nel merito devo evidenziare una profonda differenziazione rispetto al modo in cui il tema è stato posto nella relazione di Antonio Cantaro e rispetto anche ad alcuni passaggi del dibattito.
Io credo che il cosiddetto costituzionalismo delle radici – quello che Cantaro ha definito come una sorta di«costituzionalismo identitario» - sia compiutamente già figlio di una crisi. Non c’è e non può esservi costituzionalismo che non sia patto per il futuro. È l’incapacità dell’Europa a guardare al futuro che ha fatto ripiegare i nuovi padri costituenti continentali sul passato e sulle radici, inchiodandoli nella rissosa rivendicazione e contrapposizione tra radici cristiane e natali illuministi. Quella crisi nasce dall’incapacità a nominare l’Europa del domani. Quando i nostri padri costituenti scrissero la Costituzione italiana non si interrogarono sul passato se non per proclamarsi antifascisti e perciò in rottura radicale con il passato regime. Guardarono avanti e si dichiararono per un’Italia del lavoro. La nostra Europa è orba di questo sguardo, non sa proiettarsi in avanti, e perciò ripiega identitariamente sull’Europa sul passato e sulle sue radici. Io mi rifiuto di credere che possa persino esistere un costituzionalismo delle radici. Alla ricerca di ciò che eravamo, noi Europei non possiamo scoprirci altro che figli di guerre civili. Nel passato l’Europa non può trovar nulla, se non la conferma definitiva che è dall’altro lato che bisogna orientare lo sguardo.