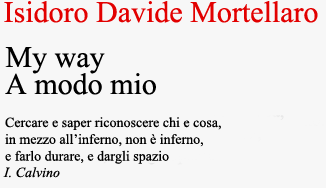Monti, l'Italia e l'Europa, in «Democrazia e Diritto», nn.3-4, 2012, pp. 54-66
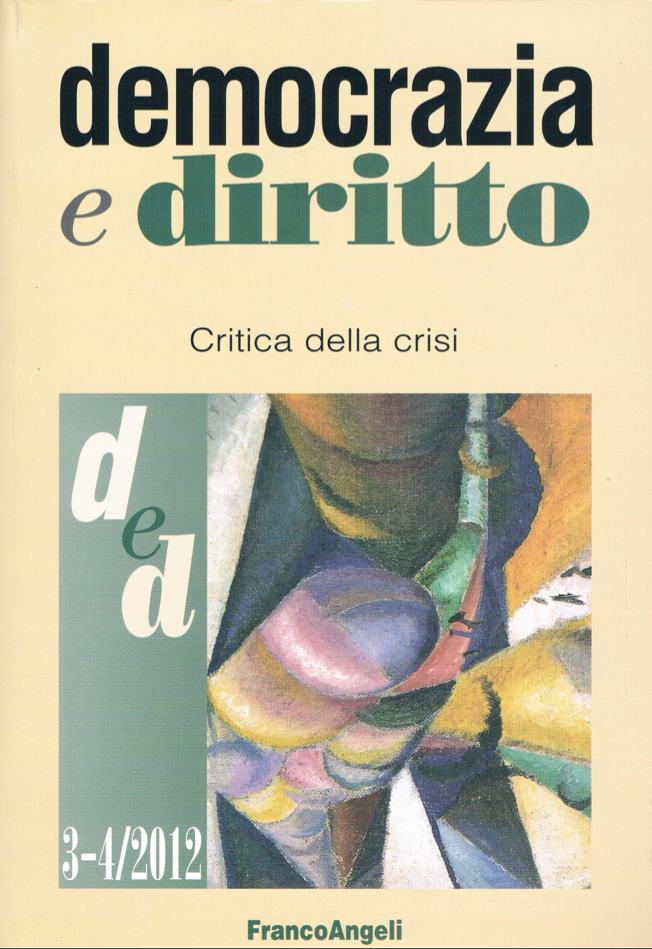
Monti l'Italia e l'Europa[i]
Prologo
Come un guanto
«Il Trattato equivale per l'economia italiana a una radicale riforma costituzionale. Esso rivolta come un guanto il modello di governo dell'economia».
Siamo al 22 e al 24 dicembre 1991 e dalle colonne del «Corriere della Sera» il professor Mario Monti, con due distinti editoriali[ii], introduce i lettori al mistero non della Natività ormai prossima, ma della neonata «Unione europea», UE. Con sobria e professorale cadenza egli provvede a disvelare il vaso di Pandora confezionato pochi giorni prima a Maastricht, in Olanda, dai leader europei raccolti il 9 e 10 dicembre nelle Conferenze intergovernative di revisione dei Trattati di Roma.
All'osservatore che oggi si dovesse avventurare per le cronache e i commenti sparsi, in quell'ormai lontano dicembre 1991, a proposito della nuova avventura europea, non è dato trovare giudizi più circostanziati sul lungo e straordinario rivolgimento che l'Italia si appresta a vivere. Non v'è nulla all'epoca che possa rivaleggiare col secco avvertimento allora espresso da Mario Monti e oggi quasi ammantato dal velo di lungimirante vaticinio. Semmai, v'è da restare stupefatti per l'inevitabile, doverosa constatazione che è tutto ancora drammaticamente in corso: che «gli esami - per dirla con Eduardo De Filippo - non finiscono mai». E non solo per l'Italia. Rivoltati come guanti sono finiti ordinamenti e gruppi dirigenti dell'Europa tutta. In subbuglio, e da tempo, sono tutti i paesi aderenti all'UE o legati dall'euro. Ne è plastica rappresentazione quella regola del pareggio nei bilanci statali o règle d'or con cui, a partire dalla Germania, ci si inchina agli imperativi di risanamento imposti dalle normative comunitarie. Ovunque, in suo nome, si riscrivono costituzioni e ordinamenti[iii]. E così, nel tentativo di arginare un sommovimento che mette a rischio casa e moneta, Unione ed euro, si finisce magari con l'amplificare le onde d'urto economiche e sociali in scossoni o terremoti costituzionali.
Vale la pena, allora, per meglio comprendere natura e portata del salto allora presagito e tuttora in atto, sostare su quelle note per il «Corriere», rileggerle con attenzione. I toni sono quelli usuali del loro autore. Improntati a moderata severità. Ma, al momento, davvero adeguati all'amaro del farmaco prescritto dalle Carte che governeranno il passaggio dalla vecchia Comunità economia europa, CEE, alla nuova UE. Per l'Italia soprattutto - secondo Monti - la partecipazione al processo di costruzione del nuovo soggetto sovranazionale comporta obblighi particolarmente stringenti e straordinari. In particolare, per il nostro paese la decisione di dotarsi di una moneta comune, «l'Unione economica e monetaria (UEM) rende più pressante la necessità del risanamento, cioè dell'eliminazione delle "divergenze" che caratterizzano l'economia italiana, soprattutto in materia di finanza pubblica e di inflazione».
Di fatto, il docente della Bocconi individua al cuore delle nuove Carte europee il nucleo di una regolazione, di un ordinamento economico, affatto nuovi - «la "costituzione economica" di Maastricht» - e dal carattere eccezionalmente precettivo. «Nel fissare il tragitto verso l'UEM - egli sottolinea - il Trattato di Maastricht stabilisce anche i principi sui quali deve fondarsi il governo dell'economia e della moneta da parte dei Paesi membri e della Comunità e detta una serie di prescrizioni in proposito». Evidenziato questo cardine costitutivo, Monti procede ad enumerare, articolo per articolo, gli imperativi entro cui si sostanzia, in uno e per prescrizioni comuni, il processo di convergenza delle varie economie nazionali nell'unione economica e la prefigurazione - sub specie aeternitatis - dei principi di politica economica e monetaria cui le future istituzioni dovranno ispirarsi. Innanzitutto, come filosofia generale di sviluppo, le istituzioni comunitarie e i vari paesi si impegnano ad adottare «una politica economica di mercato aperta e con libera concorrenza» e ad «evitare disavanzi pubblici eccessivi. Nel perseguimento di questi obiettivi, ci si propone inoltre di dar vita ad una banca centrale europea, BCE, e al sistema europeo delle banche centrali, SEBC, caratterizzati nei loro ordinamenti da assoluta indipendenza e votati all'«obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi»: un fine talmente assoluto, da costituirsi in missione principale delle nuove istituzioni, così che, solo «fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi», possano essere sostenute le politiche economiche generali dell'UE.
Con determinazione e acribia il cesello di Monti ripercorre i Trattati e sbozza, evidenzia le parti, i dati in cui s'addensano i tratti più nuovi e caratterizzanti del nuovo ordinamento. E' perciò inevitabile che l'attenzione ora s'appunti sui divieti che, inusualmente, punteggiano e sostanziano gli articoli del trattato dedicati alla politica economica e monetaria, dandole un'impronta assolutamente unica al mondo. I lettori del «Corriere» apprendono così che alle nuove autorità monetarie comunitarie è fatto divieto di far ricorso a tutta una serie di misure e strumenti assolutamente abituali e che per decenni hanno sostanziato i tratti dell'economia mista occidentale. Le banche centrali non potranno così più acquistare direttamente titoli di Stato o di altri enti pubblici né concedere loro linee di credito o adottare misure che comportino un accesso privilegiato al credito di qualsiasi istituzione pubblica.
La lingua di Monti batte ossessiva su un punto dolente: una costruzione siffatta si pone agli antipodi della regolazione politico-economica che ha spadroneggiato in Italia durante l'ultimo trentennio. Soprattutto, a spese del mercato e delle sue centralità e libertà. In particolare, alle nostre latitudini a partire dagli anni 60 si sarebbe affermato - in divergenza dagli altri paesi europei - un governo dell'economia improntato alla «disattenzione», ad una «insufficiente disciplina» per il «vincolo di bilancio del settore pubblico». All'ombra di questa regolazione 'anarchica' o 'particolaristica' si sarebbero così costituiti e radicati settori protetti, responsabili in particolare dell'alto livello inflazionistico, un accesso privilegiato del settore pubblico al credito, con relative distorsioni nella allocazione delle risorse, e il conseguente, sistematico dirottamento, infine, del risparmio nei comodi, ma costosi, recessi del debito pubblico.
Ricongiungersi agli altri paesi nella comune costruzione dell'Unione europea e dell'euro appare perciò qualcosa di veramente rivoluzionario per il Bel Paese e la sua classe dirigente. Si tratterebbe infatti - prosegue Monti - di far propri «principi che solo fino a pochi anni fa non erano, e in qualche caso ancora oggi non sono, accolti dal mondo politico, dalla cultura economica prevalente, dalle stesse autorità monetarie». Perciò il Nostro avanza un interrogativo inquietante sulle capacità e volontà stesse della classe politica di voler e poter guadagnare il nuovo approdo: «Se il Parlamento italiano si renderà ben conto del significato profondo di questa "riforma costituzionale" dell'economia scritta nel Trattato di Maastricht, non è detto che lo ratifichi tranquillamente». Per di più a fare ostacolo anche alla più adamantina delle volontà stanno le condizioni di accesso all'UEM. E qui le note sono quanto mai dolenti. L'Italia arranca tra gli ultimi, i meno dotati. Stenta assai a ritrovarsi nei ranghi dei virtuosi. Intanto, per i parametri chiave: quelli sui tassi di interesse e di inflazione. Ma soprattutto quelli relativi alla finanza pubblica: ovvero debito e disavanzo pubblici. Qui le sottolineature si fanno cupe. Monti teme apertamente storiche attitudini delle classi dirigenti italiane. Magari machiavellici tentativi per far fruttare i criteri di elasticità introdotti nei trattati quanto alla valutazione del grado di convergenza: insomma, per evitare di dover fare i conti con le scelte del passato e scansare l'imperativo doloroso di cambiar passo e abitudini. Conseguentemente - per quanto scettico sulla possibilità di misure estreme nel poco tempo a disposizione - invoca misure draconiane nell'adozione di un «bilancio eurocompatibile». Diversamente egli profetizza per l'Italia un fosco futuro: «forse supererà ugualmente, grazie ai criteri "non meccanicistici" introdotti dal Trattato, la verifica per la partecipazione alla terza fase dell'UEM. Ma nel frattempo la competitività strutturale dell'industria e della finanza italiana si sarà tanto ridotta, da rendere magra la soddisfazione: nell'UEM entrerebbe non l'economia italiana, ma il suo scheletro».
Ad alimentare prospezioni così pessimistiche v'è un giudizio pesante sulle classi dirigenti italiane: per tanti versi, una condanna senza appello. Quale quella, ad esempio, pronunciata qualche mese prima: «In Italia è dubbio che vi sia una classe dirigente ed è certo che non vi è una radicata cultura dell'economia di mercato. Non vi è una classe dirigente. Vi sono singole classi dirigenti ... ma con poca mobilità tra le diverse classi dirigenti, poca omogeneità nella formazione scolastica ed universitaria, poca condivisione di valori fondamentali su quello che il nostro Paese è e potrebbe diventare»[iv].
Sono queste ripetute convinzioni, assieme a continue e radicali prese di distanza dal valore e dalla centralità della democrazia parlamentare, della rappresentanza politica e amministrativa, a fare nel tempo il 'personaggio' Monti e a dotarlo di una spiccata caratura. Probabilmente esse contribuiscono anche ad assolutizzare le sue visioni in bianco e nero, la contrapposizione tra un'Unione europea algida tutrice, frutto di teutoniche e continentali virtù, e un'Italia scolara indisciplinata, sfatta da vizi, stravizi e confusioni[v].
Come si potrà vedere, i referendum danese e francese, e la successiva crisi dello SME, riveleranno di lì a poco che i Trattati di Maastricht sono vissuti come salto nell'ignoto, forche caudine non solo a mediterranee latitudini. Tutta l'Europa, tutte le nazioni e i popoli che si avvieranno per quella strada inizieranno da allora - e per oltre un ventennio - a dannarsi l'anima, per trovare il modo di digerire quel traguardo senza perdersi. L'Unione europea avvia a Maastricht un potente magnete, ma diffonde anche un tarlo nel legno delle nazioni europee: come avanzare nell'integrazione senza smarrire ciò che in potenza - attorno allo Stato sociale, ad una comune forma di civiltà - fa un popolo europeo, gli dà carattere e identità. Paradossalmente, in Italia la meta europea imporrà pegni, ma funzionerà da collante, sia pure contraddittorio e instabile, di brevi e sussultori tentativi riformatori.
Cambio di passo
In quel dicembre 1991 Monti amplifica ed assolutizza oltre misura i termini di un caso italiano. Coglie però il bersaglio, sia pure in forme riduttive, quando sottolinea la drammaticità del cambio di passo imposto alla classe dirigente, alla Costituzione, al metabolismo del paese dal salto scelto a Maastricht: nulla sarebbe stato come prima in Italia rispetto all'Europa. Per ironia della sorte, la cronaca di quell'11 dicembre si incarica, a suo modo, di fornirne una prova evidente. Tra le colonne di piombo fuse per i resoconti finali, sia pure parziali, del defatigante vertice olandese campeggiano anche i 'coccodrilli' dedicati alla subitanea dipartita di Franco Maria Malfatti. Enfant prodige della DC fanfaniana, più volte deputato o ministro, era stato anche nominato - unico italiano fino ad allora - presidente della Commissione europea nel 1970. Pur alle prese con i dossier assai impegnativi dell'allargamento della CEE a Inghilterra, Irlanda e Danimarca, nel febbraio 1972 aveva preferito, complice lo scioglimento anticipato del parlamento italiano, dimettersi da quell'incarico per ritornare a Montecitorio. Una scelta che allora aveva fatto molto discutere, per la disinvoltura con cui lo scranno più alto della Commissione europea era stato snobbato e abbandonato in nome del ritorno ad un più abituale teatro nazionale. In quel dicembre 1991 quella scelta viene ricordata come un fatto eccezionale. Fatto sta che da Maastricht in poi altre gerarchie si sarebbero istituite tra lo spazio europeo e i vari teatri nazionali della politica, tra alto e basso, sovranazionale e statuale: la politica italiana non avrebbe mai più riguadagnato i margini di manovra e scelta sfruttati, a suo modo, da Malfatti.
Monti coglie con prontezza il mutamento di quadro, soprattutto perché nei mesi precedenti, nel corso del 1991, ha seguito con grande impegno il comporsi dell'agenda del vertice, evidenziandone sviluppi, punti di approdo e pericoli. Soprattutto ha pungolato - e in qualche caso criticato - la delegazione italiana: nel mirino ha sempre tenuto la possibilità che gli italiani potessero conquistare nei trattati criteri o margini troppo elastici, laschi, nella valutazione dei parametri di convergenza. Con caparbietà e insistenza ha espresso il timore che si potesse allentare la presa sulla «classe politica italiana», che essa potesse «tirare un respiro di sollievo»[vi] e tornare magari ai vizi abituali. Ora però che la Conferenza intergovernativa si è conclusa e che i Trattati hanno promosso a principi costituzionali dell'Unione i precetti dell'economia di mercato, Monti non si accontenta di segnalare la novità. Di fatto, e con un qualche merito per quanto riguarda l'Italia, rivendica anche a sé e al proprio impegno il risultato.
Di lì a qualche mese farà dell'approdo europeo - «l'adeguamento al modello di governo dell'economia e della moneta delineato nella "costituzione economica" di Maastricht» - e della propria battaglia per conquistarlo il principio ispiratore dell'impegnativo volume entro cui raccoglie le fatiche e la presenza più che ventennali sulla stampa italiane e, soprattutto, sul «Corriere della Sera». Scorrendo pagine e sezioni del Governo dell'economia e della moneta, balza agli occhi la studiata articolazione in blocchi tematici fortemente coesi. Nel loro insieme evidenziano la critica puntuta delle classi dirigenti italiane e i risultati mano mano raggiunti, soprattutto nell'ultimo decennio: dal ridisegno dei rapporti tra Stato e mercato al rinsavimento dalla malsana acquiescenza al disavanzo pubblico; dal divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia alla conquista della liberalizzazione valutaria ecc., fino all'appuntamento finale di Maastricht.
Il travaglio della Repubblica - rivissuto sotto il pungolo assoluto e cogente a rinsavire dal particolarismo, a farsi europei - si illimpidisce nella linearità apprestata dal disegno politico e ideologico neoliberale, in una sorta di esemplare autobiografia. Affidato alla preveggenza e all'azione di élites illuminate appare infine libero dalle scorie, dai buchi e dalle contraddizioni che altre ricostruzioni, altre ricette evidenziano o accumulano. Basta, del resto, scostare appena la sguardo, ritrovare altre ricostruzioni, altri ricordi, per notare come su altri lidi il rendez-vous dell'Italia con la storia di quel dicembre 1991 sia stato vissuto con priorità e toni molto meno assillanti e lineari.
Demoni e picconi
Carlo Ripa di Meana, all'epoca membro della Commissione europea, vede presentarsi all'appuntamento nella città olandese «un'Italia assente e distratta», un «paese completamente introflesso che soffre della sua politica malata»[vii]. La denuncia è molto dettagliata: il paese ha accumulato, in realtà, enormi ritardi nell'adeguare la legislazione nazionale alle norme comunitarie. Ma, quel che è peggio, è l'unica nazione a non aver discusso, nemmeno a livello parlamentare, della Conferenza intergovernativa e della sua agenda. A dispetto di uno spiccato europeismo di facciata, non vi è stato dibattito: il tema è stato disertato da giornali, élites, istituzioni. Di fatto, la delegazione italiana a Maastricht - a fortissima caratura tecnocratica, influenzata fortemente dalla Banca d'Italia - è orfana di un mandato preciso. Non ne soffre, però. Prova piuttosto a mettere a frutto questa "assenza del padre", a mutarla in ricerca di nuove radici. Può accadere così che l'appuntamento storico con la trasfigurazione europea può essere pilotato per la cruna dell'ago apprestata dai 'tecnici' di via Nazionale con la teorizzazione del «vincolo esterno».
Un rapido sguardo ai giornali di quell'inizio di dicembre fa più nette le pennellate del quadro. Mentre si infittiscono le prime indiscrezioni - e preoccupazioni - sul trattato e sui suoi vincoli, il 6 dicembre il PDS guidato da Achille Occhetto si è deciso ad avviare la procedura per la messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Nel mirino è il «piccone» impugnato a piene mani e con voluttà su quel che resta della Repubblica. Si era giunti ad un punto di non ritorno, ormai. Non si poteva più tardare, né limitarsi alla denuncia del nuovo «rumore di sciabole»[viii]. La situazione era divenuta esplosiva. Specie dopo le ennesime rivelazioni su rapporti tra poteri occulti, P2 e politica e all'indomani del comunicato di solidarietà al presidente della Repubblica con cui il 4 dicembre, dall'interno dell'Arma dei Carabinieri, il Cocer aveva minacciosamente promesso di aggiungere al suo il proprio «piccone».
L'addebito nei confronti di Cossiga è di «attentato alla Costituzione». Il presidente «ha compiuto atti diretti a creare un regime fondato su un presidenzialismo personalistico, dotato di potere tutorio nei confronti dei principali organi dello stato, presente sulla scena politica mediante l'uso sregolato dei media, con rapporti privilegiati con corpi militari e servizi di sicurezza».
Osservatori e media registrano però a malapena la svolta. I titoli del 7 dicembre, in realtà, sono tutti rubati dal Censis: in straordinaria sincronia con gli eventi ha licenziato il suo XXV Rapporto sullo stato del Paese. Il titolo è come al solito sapientemente allusivo: La tentazione all'inerte decostruire. La tesi è al contrario molto netta e tranchant. Il paese non crede più a tutti i livelli: nei partiti, nello Stato, nei grandi sistemi ideologici, nella possibilità di sconfiggere il crimine organizzato, nelle riforme istituzionali, nella stessa società civile. E i giornali all'unisono evidenziano la novità: La società infelice. Il paese picconato si disgrega e non crede più in se stesso; Un'Italia a rotoli che non crede più[ix].
Nell'«anno del piccone» l'abituale termometro, che da oltre un ventennio registra gli umori del paese, marca la svolta: «per la prima volta dal 1967 il Censis ha aperto il suo rapporto con un rilievo negativo: "alla forza del credere sembra essersi sostituito il demone della de-costruzione"»[x]. La spugna secolare del Belpaese ha smesso di assorbire, attutire, smorzare. Ora «si è rotto l'attendismo» su cui a lungo ci si era attestati. Si sta passando «ad un attivismo disordinato e decostruttivo». In questo generale cambiamento di aspettative e disegni, di clima complessivo, prende corpo, a sua volta, un rivolgimento di grande momento: mentre per il passato «la forza decostruttiva era propria dei movimenti che "insidiavano" dal basso le istituzioni, per portare all'attenzione nuovi bisogni e nuove attese che emergevano dal corpo sociale. Oggi la de-costruzione scende dall'alto più che salire dal basso, mentre adotta modalità e linguaggi tipici da movimento più che da istituzione»[xi].
Muta la direzione del sommovimento e, assieme ad essa, la titolarità dell'iniziativa. Adesso è dall'alto che suona la diana. A menar le danze non sono più o non solo gli ultimi. Rubano la parola, scendono in campo ora direttamente, in carne ed ossa, le classi dirigenti, le élites, con una azione spesso paradossale nelle sue forme e nelle sue parole d'ordine. Può capitare così di «riconoscere una foga anti-istituzionale dentro le istituzioni che mostra una forza e una fantasia ben più radicali dello stesso movimento del lontano '68». A prima vista si riconosce un tratto antico, costitutivo e ricorrente, del caso italiano, un modo d'essere delle classi dirigenti italiane. Antonio Gramsci lo aveva battezzato «"sovversivismo" dall'alto»[xii]. Adesso però, secondo il Censis, l'azione decostruttiva, l'anti-istituzionalismo sono di straordinaria portata e profondità: «Il risultato è che si vorrebbe smontare tutto: l'assetto costituzionale, i partiti di massa, i grandi sindacati, gli ordinamenti regionali, per ricostruire tutto da zero, al meglio possibile»[xiii].
L'origine del processo è precisa, circostanziata. Ha a che fare con «l'esperienza culturale ed esistenziale nuova (non solo per l'Italia) della "perdita dei poli", la cui compresenza ha dato in passato ordine, significato e gerarchia alle nostre scelte individuali e collettive»[xiv]. I sommovimenti, di lungo corso, iniziati a metà degli anni Settanta acquistano un peso sconvolgente sotto la spinta dei nuovi processi globali attivati nel mondo e in Europa dalla caduta del Muro. Meno netti ed evidenti si fanno i contorni, però, quando dalle radici e dagli impulsi, anche esterni, si inizia a risalire per i rami di questa iniziativa decostruttiva fino ai suoi primi, devastanti risultati. A uscirne stravolto non è solo il legame sociale. In discussione - nel fuoco di una critica al consociativismo che non conosce confini, che fa d'ogni erba un fascio - finiscono i fondamenti della convivenza e della stessa identità. Il «demone decostruttivo» ritratto dal Censis affonda in profondità il piccone, scava senza remora alcuna «in quel corpo combinato che è oggi il nostro sistema». Finisce col divenire «uccisione congiuta di padre e madre e liberazione dell'autonoma iniziativa dei fratelli "eredi dell'unica identità" (si chiamino essi tante piccole repubbliche ex sovietiche, tante regioni che diventano o vogliono diventare stati, tanti piccoli e medi partiti e sindacati)». Si mettono in moto a quel punto logiche e spinte incontrollabili: «quando una società perde la sua spinta a credere e vince il demone della decostruzione e l'aggressività tra fratelli, allora emerge un rischio ulteriore, poiché prende avvio il processo di appropriazione»[xv]. Si evocano le virtù e la genuinità della società civile, di contro alle lungaggini, agli inghippi e ai raggiri della società politica, di istituzioni asservite a logiche consociative e di partito. Si finisce però con l'attivare appettiti inconfessabili: «scatta la spinta all'espropriazione di beni altrui, individuali o collettivi». E' così che si fanno avanti interessi innominabili che muovono logiche e soggetti refrattari alle regole, adusi all'anomia quando non all'anti-Stato: «aumenta il controllo privato (malavitoso e non) del territorio come delle procedure d'appalto, dei centri finanziari come pure della ricchezza ove questa risulta accumulata. A quel punto sempre più soggetti (non legati ad alcun "credo") considerano ciò di cui si sono appropriati come componente irrinunciabile della propria identità»[xvi]. Il cerchio finisce col chiudersi nella nascita di una società incivile che prospera nei ridotti e nelle casematte costruite dall'antipolitica, nella nuova regolazione attivata dai processi di privatizzazione e mercificazione.
In quel dicembre del 1991 è chiaro a molti che un arco disordinato e composito di attori e movimenti preme - e da più direzioni - per un mutamento radicale del paese. Si vuole rimettere in discussione i nuovi equilibri imposti dalla modernizzazione repubblicana e da lotte e movimenti degli anni Sessanta. E assieme rivoltare, appunto, come un guanto l'ordinamento costituzionale italiano. Molto meno evidente è in che modo alcune di queste aspirazioni abbiano trovato a Maastricht alleati, detonatori o moltiplicatori potenti. E' molto più arduo comprendere come e per quali nodi nella cittadina olandese sia stato confezionato un vincolo destinato a indirizzare a senso unico la vita del paese e d'Europa. A contenere e stravolgere - dall'esterno e dall'alto - lettera e spirito della Costituzione.
Di principati e nuove repubbliche
In realtà in quei giorni è difficile orizzontarsi nelle nebbie e tra i fumi sollevati dal crollo del mondo che fu. I giornali del 3 dicembre riportano i dati del referendum con cui quasi plebiscitariamente l'Ucraina - una delle repubbliche atomiche, ospiti di basi missilistiche - sceglie l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Di lì a qualche giorno, mentre a Maastricht s'apprestano i tavoli che all'indomani accoglieranno i padri fondatori dell'UE, giunge l'annuncio del colpo di piccone vibrato a Brest da Ucraina, Russia e Bielorussia: le tre repubbliche slave archiviano l'URSS e si avviano a fondare una nuova, confusa realtà confederale, la futura CSI. Dubrovnik intanto è stata bersagliata dalle bombe di un esercito che non si rassegna ad essere cancellato assieme alla Repubblica federale jugoslava. Avanza inarrestabile nei Balcani il cancro della guerra civile.
Nello stesso giorno in cui si apre a Maastricht la Conferenza intergovernativa, il PDS convoca la sua direzione. L'evento spicca rispetto ad un cupo ripiegarsi del pentapartito attorno alle proprie viscere e nella preparazione della campagna elettorale. La relazione di Occhetto prova a mettere ordine e a diradare le nebbie[xvii]. Intanto ad assumere un'iniziativa adeguata alla crisi e al passo compiuto con la messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica. Anche il segretario del PDS - come Monti di lì a qualche giorno - crede che mutamenti radicali, profondi hanno investito e stanno investendo la Repubblica italiana, imponendole un cambio di passo, di natura e orizzonti costituzionali. A dominare la scena, però, nella visione del segretario del PDS è il tramonto dei mondi separati e trattenuti dal bipolarismo. Ora la dissoluzione dell'URSS sospende sull'Europa del dopo-Muro incognite straordinarie. A rischio appaiono i processi che avevano fatto sperare nell'affermazione di dinamiche unitarie e pacifiche, nella costruzione della «casa comune» dall'Atlantico agli Urali. Secessioni e dissoluzioni hanno ora la meglio. Si fa avanti, in luogo dell'agognata «Europa dei popoli», una «Europa delle tribù».
In realtà, anche in Occidente - secondo Occhetto - sono in atto processi disgregativi profondissimi: in particolare, avanza «una crisi degli strumenti, dei metodi e dei soggetti (primo fra tutti il partito) della democrazia politica come finora si è configurata». In questo quadro e nell'ambito del generale spostamento a destra che rischia di determinarsi in Europa, spicca la particolare gravità della crisi italiana oggi giunta ad un vero e proprio «salto di qualità». Qui «il deficit pubblico è fuori controllo. L'inefficienza dei servizi riduce sensibilmente la competitività delle aziende industriali. Gli squilibri territoriali minano sempre più la coesione sociale e l'unità stessa della nazione. Tutto ciò ostacola quella accelerazione dei processi di integrazione europea che pur sarebbe necessaria, e che è in discussione oggi al vertice di Maastricht».
Come nel Monti degli editoriali sul «Corriere», Occhetto tratteggia un «caso italiano», individuandone le caratteristiche nella arretratezza del paese, nella difficoltà a stare al passo con gli altri, negli «ostacoli» che il nostro modo d'essere frappone ad una più compiuta - auspicabilmente accelerata - integrazione europea. A complicarne la soluzione stanno inoltre i tratti particolarmente devastanti assunti nel nostro paese dalla fine del mondo bipolare e dalla insostenibilità di un sistema politico colpevolmente costruito sull'architrave anticomunista rappresentato dalla DC. Perciò più che altrove da noi sono «in crisi le vecchie forme della politica»; più profondo che altrove si è fatto «una sorta di vuoto di potere». Ecco perché è divenuta così «aperta la partita per definire i caratteri e gli assetti di quella che molti chiamano la seconda Repubblica». Di fatto, prosegue Occhetto, «il confronto e la lotta riguardano ormai il "come" saranno i nuovi assetti e i nuovi equilibri. Non il "se"». A contendersi la guida di questa transizione ad un'altra forma repubblicana stanno in campo: da un lato, «la seconda repubblica di Cossiga», fondata «sugli apparati e sulle forze che hanno combattuto la prima repubblica o che non si sono riconosciuti in essa», sulle «Leghe», su «un rapporto plebiscitario fra il presidente e il popolo»,; dall'altro, «non una impensabile difesa dell'esistente, dello status quo», ma «un'altra riforma, una Repubblica nuova che si fondi su una maggiore responsabilità e un maggior potere dei cittadini elettori, chiamati a scegliere la maggioranza cui affidare il governo, su istituzioni pienamente autorevoli e responsabili sottratte alla simbiosi dei partiti»; insomma, «una Repubblica in cui sia diffusa e generale la responsabilità dei cittadini, del Parlamento, del governo, della magistratura».
Accomunati nel giudizio sulla divergenza del paese dal resto d'Europa e sulla necessità di adottare una più decisa integrazione europea, la ricetta di Maastricht, per curarla, i due si distanziano su un punto essenziale: per Monti, l'ingresso nell'UE, se perseguito fino in fondo, comporta una secca perdita di sovranità e di autonomia degli stessi attori politici nazionali; per Occhetto, la partita e la posta - per quanto collocati nell'orizzonte europei - stanno tutti ancora sul tavolo nazionale o, meglio, italiano, in mano a giocatori di fatto ancora onnipotenti nelle loro scelte.
Di lì a qualche giorno, a Conferenza intergovernativa conclusa e a commento del nuovo Trattato, Sergio Segre - a lungo responsabile per il PCI degli Esteri e della Sezione Europa - confermerà e approfondirà l'analisi svolta da Occhetto, delineando ulteriormente i tratti della Seconda Repubblica da opporre a quella populistica capeggiata fin lì da Cossiga. Per il PDS, di fatto già lanciato nella campagna elettorale, «rigore e coerenza europeistici sono una grande carta». Lì si delinea il banco di prova più severo e conseguente di un riformismo moderno, all'altezza dei tempi, perché «portare l'Italia a livello dell'Europa più avanzata e farla entrare tutta in Europa è certo oggi, per il nostro paese, il più ambizioso e il più impegnativo dei programmi. Non basta però averle in mano, le carte buone. Bisogna anche saperle e volerle giocare, con tempestività, con efficacia e continuità». Pena, «un distacco incolmabile da questa Europa in cammino»[xviii].
Silenzio sul resto, sulle scelte concrete che la via di Maastricht comporterà, sui farmaci particolarissimi raccomandati in quel prontuario: una afonia ancor più pesante e significativa, nel momento in cui l'orizzonte europeo, con le sue cogenze e strettoie, diviene anima e corpo del nuovo riformismo, stella polare del PDS. A dispetto del mutamento, scatta qui un vecchio condizionamento culturale, un 'vizio' antico, duro a morire: una sorta di provvidenzialismo storicista. Provvede di bussola nei momenti di svolta, quando i marosi si fanno cattivi. Quel che conta è individuare la linea di progresso, là dove passa e si fa la storia. E mettersi a favore di vento, per afferrare poi saldamente il timone, e affrontare, attraversare la tempesta. Salvo scoprire, a distanza di tempo, di essere finiti in una scia poco conosciuta, su una rotta orientata da altri.
[i] Anticipiamo, fidando nel loro interesse, alcune pagine di un volume di prossima pubblicazione che l'autore - docente di Storia delle relazioni internazionali nell'università di Bari - sta completando.
[ii] Titolati rispettivamente L'Italia, l'Europa e il guanto di Maastricht e Europa, una lezione dai tassi. Successivamente fusi assieme con il titolo Il Trattato di Maastricht e l'Italia nel volume Il governo dell'economia e della moneta. Contributi per un'Italia europea 1970-1992, Milano, Longanesi, 1992, pp. 512-8.
[iii] L'Italia l'ha fatto con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Avendo raggiunto, sia al Senato sia alla Camera, il quorum dei due terzi dei componenti nella seconda votazione, non potrà essere sottoposta a referendum popolare.
[iv] Dal discorso a Roma del 16 giugno 1992 all'Assemblea dell'Unione petrolifera, raccolto poi con il titolo Integrazione europea e classe dirigente in Il governo dell'economia cit., p. 506-9.
[v] Esemplare la sottolineatura della «notevole confusione di ruoli tra pubblici poteri, parti sociali, autorità monetarie» che, assieme alla denuncia della divergenza tra modello europeo e caso italiano, fa da leit motiv dei pezzi raccolti in Il governo dell'economia cit.; ivi, p. XI.
[vi] La cura olandese, in «Corriere della Sera», 24 novembre 1991, ora con il titolo La convergenza superficiale in Il governo cit., p. 512.
[vii] Ripa di Meana "Assente e distratta, l'Italia è in ritardo", in «la Repubblica», 8 dicembre 1991.
[viii] Così l'editoriale, Questo rumore di sciabole, a firma di Giuseppe Caldarola, su «l'Unità» del 5 dicembre 1991.
[ix] Questi i titoli degli editoriali di R. Rossanda sul «manifesto» e di L. Tornabuoni sulla «Stampa» del 7 dicembre.
[x] M. Garbesi - D. Mastrogiacomo, All'Italia non serve la voglia di piccone, in «la Repubblica», 7 dicembre 1991.
[xi] Da 1991 - La tentazione all'inerte decostruire, in Censis, Se trent'anni vi sembran pochi. 1976-1996 L'Italia nell'interpretazione del Censis, Milano, Franco Angeli, 1997, p. 382.
[xii] Valga per tutti il riferimento in Quaderni del carcere, vol. I, Torino, Einaudi, 1975, pp. 326-7.
[xiii] La tentazione all'inerte cit., p. 382.
[xiv] Ivi, pp. 382-3.
[xv] Ivi, p. 387.
[xvi] Ibid.
[xvii] Il testo completo della Relazione in «l'Unità», 11 gennaio 1991.
[xviii] S. Segre, La nuova Europa c'è. Ora bisogna portarci l'Italia, in l'Unità», 12 dicembre 1991.