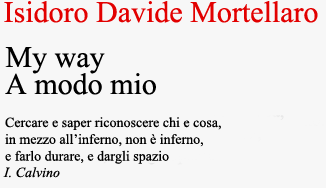Dell’americanizzazione. Note sulla mutazione del sistema politico italiano, in «Critica marxista», n. 4, 2008, pp. 25-31.
Il voto ha dimostrato come, a vent’anni dall’89, gli eredi del Pci continuino a nuotare (sia pure senza più prosperare) in un unico acquaio. Con la designazione dall’alto del parlamento muta e s’arrovescia la costituzione materiale del nostro paese. Anche l’invenzione della Sinistra Arcobaleno ha replicato modi e forme della politica «made in Usa».
Americanizzazione: un termine pesante assai. Proprio come il Novecento, che ne è stato marchiato a fuoco sin nel nome, American Century, affibbiatogli a quasi metà del cammino, nel 1941, da Henry Luce. E pesante è il ruolo che esso ha giocato nelle ultime elezioni italiane – e ora nell’interpretazione del cataclisma - soprattutto a sinistra. Qui, come clava, è stato volenterosamente impugnato, agitato e usato da tutte le parti. Non proprio nel dibattito politico e culturale: esilissimo e certo non votato a imperitura memoria. I colpi si sono concentrati, piuttosto, nella affannosa difesa del proprio spazio o nella astiosa damnatio dell’altrui. E in questa devastante resa dei conti gli antagonisti si sono mossi da opposte sponde in sincronica, culturale concordia: sia che fosse Veltroni a magnificare il proprio distacco dall’eterna guerra civile europea, da un vecchio che non muore, da logore casacche («Gli occhi degli italiani hanno visto troppo odio e divisioni in questi anni… non ci sono due Italie separate da muri invisibili. Né è giusto mettere sulle regioni, sulle città, sulle case e persino sulle teste degli italiani delle bandierine di colori diversi. Gli italiani non “appartengono” a nessuno, se non a se stessi», così a Spello nello storico 10 febbraio); sia che fosse l’intera Sinistra arcobaleno a scendere in campo per provare coralmente a esorcizzare un affondo inconsciamente temuto («il futuro del paese non può essere affidato al “modello americano”, che per definizione e vocazione storica cancella la sinistra dalla rappresentanza istituzionale», così nell’appello dei 424 per la Sinistra arcobaleno).
Curiosa questa singolare – fuori sincrono - fascinazione italiana per gli USA. Solo qui, a XXI secolo ben avviato, si accredita ancora all’american way of life una potenza egemonica che ovunque, fuori e dentro gli USA, si sente minata e scossa, come mai, dalle dissennatezze epocali di Bush II. Vale la pena di indagare su questa postura rétro o, meglio, irrealistica, della sinistra e di gran parte del mondo politico italiano. In essa si può, forse, trovare qualche ragione del maremoto che ha sconvolto l’armatura politica ed istituzionale italiana. Con essa, magari, si può provare ad abbozzare quella discussione sul voto e sulla politica che ancora stenta a compiere persino i primi passi, a trovare il filo plausibile di un gomitolo utile ad orizzontarsi nel futuro. Certo, all’altro capo non si troverà la pietra filosofale decisiva. Per andar lontano e scavare profondo la lente andrà sicuramente portata sul divorzio dal sociale e dalle fratture che l’hanno fatto altro da quello conosciuto. Altre risposte dovranno esser trovare all’incapacità della politica e della democrazia a selezionare e sciogliere gli imperativi nuovi che gli inediti viluppi di scienza e vita sospendono sulla politica e sul futuro dell’uomo e del pianeta, così come all’afasia della sinistra a nominare persino la mutazione che, anche per effetto dell’azione dei subordinati e degli ultimi, ha divelto il mondo dai vecchi cardini e attivato nuove antropologie. Ma questi temi di lunga lena sono posti da tempo in varie agende che hanno alimentato, non di rado e da più parti, un lavoro utile. A far nodo è che non si siano tradotte in politica. Al meglio, hanno alimentato la bolsa retorica di oligarchie interconnesse o una politica strabica, adusa a muoversi, magari con il suo americanismo di seconda mano, in un mondo parallelo e perciò in perenne, drammatico divorzio dalla realtà. Il tutto acuito nel Belpaese da un malessere sociale e politico portato al calor bianco da una transizione ventennale – coi suoi lontani natali nel fatale 1989 – divenuta frenetica e inesausta palestra di nuovismi e rifondazioni, allineati in sequel ininterrotti. Tutti strutturalmente aperti al rilancio permanente. Sempre epocale. Ma tutti rachitici, se non privi del tutto di bilancio delle fasi appena chiuse: magari di botto.
Troppe nubi e troppo vapore si erano accumulati all’orizzonte. Inevitabile che precipitasse tutto in uragano al tocco volenteroso di apprendisti stregoni e grazie al catalizzatore di parole d’ordine avventuristiche. Perché stupirsi perciò per il ‘basta’ veltroniano cinicamente disposto a raccogliere e a suscitare un ‘basta’ collettivo lungamente covato? Soprattutto se amplificato dal pressapochismo collettivo del centro-sinistra, da riforme minacciate ma non compiute: utili a spaventare molti, deludere tanti, senza mai soddisfare alcuno. Perché stupirsi poi se tanto schianto a sinistra è stato infine coronato da così esangue raccolto? E’ il risultato di una politica ridotta – sugli spalti del Partito democratico come nelle fila della meteora Sinistra Arcobaleno – a un gramsciano «sognare ad occhi aperti»: «Del sognare a occhi aperti e del fantasticare. Prova di mancanza di carattere e di passività. Si immagina che un fatto sia avvenuto e che il meccanismo della necessità sia stato capovolto. La propria iniziativa è divenuta libera. Tutto è facile. Si può ciò che si vuole, e si vuole tutta una serie di cose di cui presentemente si è privi. È, in fondo, il presente capovolto che si proietta nel futuro. Tutto ciò che è represso si scatena. Occorre invece violentemente attirare l’attenzione nel presente così come è, se si vuole trasformarlo. Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà» (Quaderni, p. 1131).
A cosa alludeva il “si può fare” veltroniano quando, annunciando un nuovo partito centrato sul «cittadino-elettore» e non più sull’«iscritto-tesserato né il politico professionista remunerato», vedeva librarsi «l'idea che occorra far vivere un nuovo campo del pensiero democratico, delle idee di libertà, di giustizia sociale e di innovazione»? Era realistico dipingere una «Europa andata a destra, in questi anni, perché la sinistra è apparsa imprigionata, salvo eccezioni, in schemi che l'hanno fatta apparire vecchia e conservatrice, ideologica e chiusa»? Era concreta, giusta la prescrizione, la medicina americana: «L'Italia deve essere unita. L'odio e le divisioni di questi anni ci hanno fatto perdere occasioni importanti. Non si è voluto capire ciò che è naturale ad esempio nelle grandi democrazie anglosassoni: che è necessario scrivere insieme le regole del gioco per poter poi competere per il governo nella distinzione di programmi e valori»?
Partigianeria
Quale paese anglo-sassone, quale America gonfiava le vele del Veltroni-pensiero? Sicuramente non quella di elezioni presidenziali giunte all’incandescenza fin dalle primarie, con un Partito democratico dilaniato dallo scontro inaudito di gruppi di pressione agguerritissimi, sindacati e lobbies, politicanti di professione e tanta, tanta passione politica, dilagata poi in interesse e tifo planetari, tali da far parlare di «elezioni globali». In quale America aveva scorto concordia istituzionale, afflato bipartisan? Forse gli era sfuggita la raccomandazione, con annesso consiglio di lettura (sì, un libro: così nell’indiscrezione di Mario Calabresi dalle colonne di «Repubblica» del 14 dicembre 2007), elargita a metà dicembre da Bush II al presidente Giorgio Napolitano, in visita a Washington e in grande imbarazzo per gli affondi del «New York Times» su una litigiosissima Italia. Quisquilie, caro Presidente. Sussurri da educande. C’è ben altro negli States. Si consoli – così George a Giorgio - e soprattutto provi a capir meglio la politica del XXI secolo con questo Ronald Brownstein, titolato addirittura a The Second Civil War. How Extreme Partisanship Has Paralized Washington and Polarized America («La seconda guerra civile. Come la partigianeria radicale ha paralizzato Washington e spaccato l’America»). In quelle pagine vi è un sanguigno ritratto degli USA al passaggio di millennio, con le viscere sconvolte dall’Hyperpartisanship: l’Iperpartigianeria, l’Ipersettarismo. E’ con l’elezione di Nixon, e poi Reagan, e infine con Bush II che l’Hyperpartisanship si è venuta a mano a mano installando al cuore del paese, causando la spaccatura progressiva e sempre più lancinante della nazione. Data da allora l’abbandono di quell’età della contrattazione, Age of Bargaining, che con Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson aveva fatto degli USA il perno egemonico di un complessivo sistema fondato sull’embedded liberalism, il liberalismo regolato: un sistema internazionale, cioè orientato ad una liberalizzazione degli scambi mitigata socialmente, disposta al riconoscimento del conflitto sociale. A Nixon si deve lo scasso iniziale del blocco sociale rooseveltiano, ingrassato dalla crescita dei Trente Glorieuses. Sua la prima incursione nel voto operaio, mentre il paese e il Partito democratico venivano sconvolti e ridefiniti dalla lotta e dai movimenti per i diritti civili, contro la guerra in Vietnam. Ma è la globalizzazione del passaggio di secolo, attivata dall’età reaganiana, che provvede a nutrire la politica americana di acidi e veleni potentissimi: diseguaglianze che riportano indietro di un secolo ma che ora attentano persino alla comune appartenenza al genere umano; una politica drogata dall’irruzione di bit e denaro e dallo scontro asimmetrico tra un Congresso, abitato e debilitato da dinastie e oligarchie, e una Presidenza sempre più «imperiale». Ed è di lì, dal cuore a stelle e strisce del mondo che la tendenza inarrestabile allo scontro, a nuove radicali contrapposizioni, muove per divenire orientamento generale, eccitato dalle teoriche della «guerra al terrore» e surriscaldato dallo stato sempre più febbricitante del pianeta, delle relazioni tra gli umani e con la natura.
Per gli specialisti nulla di nuovo nelle pagine di Brownstein. Di fatto l’ultima, magari brillante analisi in una bibliografia infinita dedicata alla fine dell’Età dell’Oro, ora resa più ansiosa dal ritorno – come già negli anni 80 angosciati dalle performances giapponesi – dell’interrogazione su futuro dell’egemonia americana, colore del XXI secolo e sorti dell’Asia. Non a caso, assieme ad una tendenza alle titolazioni dedicate allusivamente al ‘post’, ci si torna a chinare su momenti e figure chiave quali Nixon e Reagan. Si prova a capire cioè come si seppe curare il primo declino e rilanciare l’egemonia americana e se quella rinascita non fosse già minata dalle spaccature e divisioni straordinarie in cui furono allora precipitati gli USA e il mondo.
In quelle pagine comunque ve n’è a sufficienza per comprendere come l’ingresso nel XXI secolo non comporti un acquietamento delle tensioni. Anzi, proprio dal cuore d’Occidente s’annunciano nuovi, inediti conflitti, attivati dall’invadenza dell’iperpolitica. «Il catalogo è questo: anche da noi, caro Giorgio»: ma di questo sussurro imperial-presidenziale nulla giungeva al Walter nazionale, pronto a rampante rincorsa, rigorosamente anglosassone, in controllato, virtuoso self-restraint. Persino nella pronunzia del nome altrui.
Costituzione materiale
Sulle orme dell’indimenticato Fukuyama, ma per gironi ben più modesti, proclamava anch’egli la sua «fine della storia» e l’ingresso in un’era nuova di zecca. La preparava, però, e vi si accostava con metodi e scelte ben poco anglosassoni. Forte di una straordinaria investitura plebiscitaria, guadagnata in singolari primarie, di lì a poco avrebbe messo paradossalmente a frutto il no di Berlusconi alla riforma elettorale. In un sol colpo, grazie alla designazione autocratica delle liste elettorali, avrebbe provveduto a insediare rappresentanza parlamentare e struttura del nuovo Partito democratico, riarticolato in una rete di caciccati regionali: una via neomedievale alla post-modernità che assestava l’ennesimo colpo alla rappresentanza parlamentare e alla partecipazione democratica e vellicava a sinistra infine – con il pressante invito a «far da soli», a semplificare - le frustrazioni peggiori accumulate nel ventennio della ‘transizione permanente’. Un ossimoro questo accettabile solo come figura retorica. Esiziale però in politica.
A stupire però è che di qua del Partito democratico, nella corsa della nascente Sinistra arcobaleno, si sia insistito a dare di questa deriva una rappresentazione specularmente simmetrica a quella veltroniana, all’insegna appunto di una ‘americanizzazione’ fieramente vituperata. Con evidenza se ne è data una valenza riduttiva, concentrata alla sfera politica e al temuto colpo di accetta vibrato per conquistarne una subitanea e forzosa semplificazione, frutto negli USA piuttosto di un sedimento originario e di una più che secolare vicenda. Val la pena di notare, en passant, come in tal modo inconsciamente si è fatta giustizia di ogni elucubrazione circa l’esistenza di più sinistre, saldamente strutturate in mondi e popoli distinti: il ‘popolo comunista’, il ‘popolo democratico’. Il voto ha dimostrato come, a vent’anni quasi dall’’89, gli eredi del Pci continuino a nuotare ancora – sia pure senza più prosperare – in un unico acquaio: lì vivono e soffrono di dinamiche comuni, senza però che nessuno degli attuali protagonisti abbia mai veramente riconosciuto il masochismo d’ogni politica fondata sul principio del mors tua vita mea.
L’adozione di un’ottica americaneggiante sullo strappo bipartitico ha piuttosto potentemente contribuito al fatto che sfuggissero infine alla presa politica della sinistra proprio i corposissimi tratti autocratici impressi alla rappresentanza e il rapporto affatto nuovo istituito dal circuito istituzionale con il complesso della società italiana. Con la designazione dall’alto del parlamento muta e s’arrovescia la costituzione materiale, la colonna vertebrale del paese: il modo in cui esso prende voce e si rappresenta. Altri divengono i canali, riservati e privati, attraverso cui voice, lealty and exit – lealtà, defezione e protesta - si costituiscono in rappresentanza, si compongono in istituzioni. Il passaggio si compie in forme americane? O, piuttosto, rilanciando la «composizione demografica» antica di un paese tarlato da caste, vassalli e valvassori, e ora vieppiù imbarbarito dalla greppia bassa del pubblico e da una crisi organica epocale. Altro che «nani e ballerine» di craxiana memoria. V’è altro che ora in gran copia rende bizzarri, quando non scandalosi, vari settori degli emicicli camerali.
Non aver saputo impugnare per tempo e sul serio la questione della mutazione complessiva del sistema politico, a partire dal nodo più scoperto della cancellazione e dello scippo della rappresentanza parlamentare, ha comportato per la Sinistra Arcobaleno un rinculo devastante. Non appena è divenuto chiaro che la designazione dall’alto dei possibili parlamentari diveniva, anche a sinistra, non l’oggetto di una critica politica puntuale o di una rivisitazione più o meno virtuosa, più o meno aperta al contributo del proprio universo di riferimento, ma la risorsa, l’espediente concreto che rendeva possibile la fusione a freddo di vari apparati nel nuovo contenitore affrettatamente e malamente predisposto, la delegittimazione ha corso inarrestabile: in forme direttamente proporzionali al vocio con cui si provava ad esecrare l’altrui ‘americanizzazione’. Non a caso gli ultimi più approfonditi scavi nel voto di sinistra (Istituto Cattaneo) dimostrano rispetto a questi ultimi fenomeni – sfiducia generalizzata, esistenza per gli eredi del PCI di un universo comune ancor vivo – che il voto sottratto alle liste della Sinistra Arcobaleno si è diretto soprattutto verso l’astensione e il cosiddetto voto utile: Partito democratico o Italia dei Valori.
Rainbow Coalition
A incrementare il danno si è aggiunta la netta constatazione, via via sempre più evidente, che proprio la Sinistra arcobaleno, lungi dall’essere immune, risultava – magari più di altri – partecipe di una reale americanizzazione del paese e del suo paesaggio politico, ovvero della radicale mutazione di una civiltà. Si guardi alla questione assolutamente prioritaria - gridata dai risultati del voto, ma di lungo periodo, già vivissima in particolare nel PCI meridionale – della «deproletarizzazione della sinistra», del tanto discusso rapporto tra sinistra e popolo: un tema sicuramente epocale, che ha a che fare con il mutamento della composizione di classe, con la cesura del ’68 e con quello che essa ha significato rispetto al rapporto tra scienza, formazione e vita, ma anche nell’accumulo inedito di politica e organizzazione da allora prodotto in settori o mondi quali la scuola e la comunicazione, o rispetto a soggetti quali i giovani o le donne. E’ assolutamente straordinario il modo in cui in forma estremamente concentrata e tutta politica, nel senso proprio di sottolineare l’amplissimo grado di libertà proprio della decisione politica, la scelta di procedere alla costituzione della nuova formazione de “La Sinistra l’Arcobaleno” - con il suo complesso di scelte: dai simboli al nome, alla platea di soggetti e temi privilegiati, alla contaminazione movimentistica, fino all’annuncio della trasformazione della soggettività e dell’alterità comunista in una presenza culturale tra altre – abbia mimato a distanza di anni quel processo ben più ampio e tumultuoso che, tra la Convention di Chicago del 1968 e quella di San Francisco del 1984, presiedette negli States alla trasformazione del Partito democratico. Allora gli USA furono costretti a cambiare sotto l’urto del mondo e di un’eccezionale critica interna contro la guerra vietnamita e per i diritti civili. In un inedito processo di rivoluzione passiva, la destra e i repubblicani avviarono allora la rivincita sul New Deal e la digestione delle domande e dei soggetti emersi negli anni 60. I democratici finirono invece nell’occhio del ciclone. E così mentre Nixon penetrava ampiamente in ampi settori operai e a Sud nelle file dei democratico-conservatori, il Partito democratico allentava il suo legame storico con il sindacato e si rivelava sempre più permeabile all’azione tambureggiante delle nuove soggettività giovanili, femministe, gay, ecologiste, pacifiste. Il processo avrebbe conosciuto il suo momento culminante, e il suo punto di caduta, nell’assalto – fallito – di Jesse Jackson alla Convention del 1984, alla testa di una coalizione di movimenti lanciati in incalzante e radicale critica del reaganismo. Degni di nota marchio e nome del raggruppamento: Rainbow Coalition, «Coalizione Arcobaleno».
Al di là di scontate assonanze lessicali e simboliche, a colpire è il drammatico effetto di déjà-vu che – a distanza di tempo e di spazio – vede in Italia la replica di un processo consumato negli USA come epicentro e anticipazione di una epoca segnata dalla crisi della sinistra e della democrazia: in particolare, di quella democrazia sociale che in Occidente aveva colorato Les Trente Glorieuses del secondo dopoguerra. Anche tra noi una decisa e caparbia azione di innovazione e revisione – giunta a punti di grande e meritorio momento, come sui tornanti della nonviolenza o dell’Europa – non riesce a superare confini minoritari né ad acquisire l’adesione reale del suo universo di riferimento. Alimenterà con inesausta inquietudine il tentativo di conquistare assetto e orizzonti nuovi a quella parte della sinistra italiana convinta che la tradizione del comunismo italiano possa ancora utilmente interrogare il futuro. Lo schianto interverrà quando un corpo sociale e politico stremato e insofferente vedrà il salto in un’epoca nuova affidato a chi, con molto clamore, proverà ad esorcizzare nelle fattezze altrui un lupo, l’americanizzazione, già da tempo - soprattutto dopo la Seattle di fine secolo - accolto, nutrito e vezzeggiato sui propri pascoli.
Tremonti tra mercato e Welfare
Spicca ulteriormente, in questa postura irrealistica della sinistra italiana, una marcata incapacità a prendere concretamente le misure dell’avversario. Nel suo piccolo – sia pure in forme esemplari – sta a testimoniarlo la particolare accoglienza riservata, dopo un iniziale ritardo, al libro-manifesto di Giulio Tremonti, La paura e la speranza. Europa: la crisi globale che si avvicina e la via per superarla, Mondadori. In questo caso è chiamato in causa il complessivo universo culturale, mediatico, giornalistico di sinistra, provato anch’esso, quando non arrochito o azzittito da una ‘congiuntura’ difficile.
Rispetto all’ultima fatica dell’inquieto ministro delle Finanze, l’attenzione generale si è incentrata sulla denuncia della crisi intervenuta nel lungo ciclo liberista: addebitata magari più agli sgambetti asiatici che non alle follie dell’amico americano. La soluzione di continuità era profondissima e come tale andava utilmente segnalata. Magari anche solo per quanto più platealmente rompeva l’unanimismo fin qui corazzato del pensiero unico: la riproposizione, ad esempio, di dazi e barriere, una novità che evidenziava un cambio di visione e passo dell’intera coalizione di centro-destra. Ferma rimanendo qualche recriminazione all’insegna del ‘meglio tardi che mai’, non sono mancati apprezzamenti interessati, intesi soprattutto a sottolineare – rispetto agli orizzonti obbligati della globalizzazione neoliberista e dei suoi imperativi - l’apertura di qualche spazio di manovra per i tradizionali attori politici.
Inesplorati invece sono rimasti, in particolare, due aspetti: l’ambiguità di una denuncia della globalizzazione in cui Tremonti prova a comporre in unità i molteplici registri impiegati nelle varie e contraddittorie stagioni del suo impegno; la sostanza politica di un manifesto che anch’esso non viene d’America – per quanto sia attento a salvaguardare un’opzione atlantista – ma dalle viscere più profonde del Vecchio Continente. Per il primo aspetto basterà vedere come al cuore di una verbosa denuncia del «mercatismo» universale, divenuto soprattutto in Asia «versione degenerata del liberismo», vi sia la proposta di dazi ed eurobond per garantire e sorreggere lo sviluppo: il tutto però sottordinato ad una politica orientata alla «estensione transatlantica dall’Europa agli USA di un trattato di unione commerciale basato su comuni principi doganali, di proprietà intellettuale, di Antitrust, di sussidi agricoli ecc., così da creare un nuovo ‘grande spazio atlantico’». In merito al cosiddetto ritorno della politica in Europa, quest’ultima è destinata, per il Nostro, a non sopravvivere se ferma la sua unificazione all’economico. Qui Tremonti è lapidario: «l’Europa può e deve rinunciare al disegno di una società perfetta e di un mercato perfetto … occorre semplificare e ridurre lo stock della nostra regolamentazione, europea e nazionale … le regole fondamentali sono un investimento, mentre le regole artificiali sono un costo».
A questo punto della ricostruzione le cose sono divenute più chiare. Per Tremonti non si può parlare di ‘ritorno’ della politica, all’indomani della globalizzazione. Essa non ci ha mai abbandonato. La globalizzazione non è orfana ma figlia di una particolare stagione politica. Applicata non più a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’ascesa dei soggetti sociali, magari di quelli più deboli, come nelle tradizioni del miglior costituzionalismo democratico. Ora il mercato e la sua unificazione si costituiscono in imperativi della politica, che così muta il suo campo d’applicazione, cambia spalla e mira al fucile. Ed è qui che il libro assesta il suo coup de théâtre. Lungi dal menzionare persino il gran ritorno sulla scena, nei primi anni 70, del pensiero neo-liberale, Tremonti addebita la paternità del cosiddetto mercatismo alla sinistra: il mercato perfetto come ennesima, fatale trasposizione dell’utopia, precipitato residuo di astratti e originari furori illuministici.
In altre stagioni e altri affondi sui processi di globalizzazione, Tremonti si era in verità contraddistinto per toni più critici - e anche più tradizionalmente liberali – circa le virtù salvifiche del politico e della legge. Un’altra sua veduta del mondo, affidata a Laterza, è titolata addirittura allo «Stato criminogeno». In quelle pagine si dilungava a descrivere una sinistra dalle venature non già «illuministiche», ma «coraniche» e «reazionarie», vista la predilezione per l’artifizio giacobino della legge in luogo della naturalezza del contratto propria del liberalismo. Di fronte a questo guazzabuglio, a questa così vorticosa, eppur fortunata e sempre puntuale, mutevolezza di toni e orientamenti, la memoria corre al Brindisi di Girella, dedicato in un’altra età da Giuseppe Giusti al camaleontico Talleyrand. Aguzzando lo sguardo però ci si accorge ben presto come l’accumulo e la composizione ossimorica degli opposti non rinviino ad un dato biografico, o ad una trovata strumentale, ma ai tratti profondi di un programma politico.
Come altre volte nella storia delle classi dirigenti europee, Tremonti prova a comporre reazione politica e progresso tecnologico o economico. Di fronte ad un mondo che tende a trovare nel Pacifico il suo nuovo asse, propugna un programma idealmente ispirato alla ripresa di quel «modernismo reazionario» (così Jeffrey Herf per il Mulino) che già nella prima parte del Novecento aveva fatalmente provato, con nazismo e fascismo, ad imporre una nuova centralità dell’Europa. E’ all’Europa, alla Repubblica cristiana per eccellenza, che Tremonti, novello Faust, si rivolge per ricavarne un’identità salvifica, una tavola di «valori» - «famiglia autorità ordine» – con cui provare a controllare e dirigere, a dare un’anima alla corsa alata della finanza, della comunicazione, della scienza. E per risacralizzare, ricomporre ciò che il capitalismo continuamente «dissolve nell’aria», resuscita il «romanticismo», la radice primigenia di una identità europea consumata e dissolta dagli acidi del consumismo. Tremonti non vagheggia una «restaurazione» più o meno bucolica. Addita una «via d’uscita dalla crisi» in avanti, «andando in profondità nello spirito che, nel bene e nel male, anima il nostro tempo»: «mercato se possibile, governo se necessario». Soprattutto nel difenderci dall’invasione altrui. Ma qui, quando scende sulla terra, tra gli umani, la sua lingua si scopre partigiana e perciò nuda e scoperta. Con merito e un qualche sadismo ricorda che a fare il Welfare contemporaneo sta non solamente la «coppia giovani-superfluo», ma anche quella «anziani-necessario». Non solo «discoteca e pizzeria», ma anche «gastroscopia e protesi dentarie». Egli però vede crescere e moltiplicarsi solo gli anziani. Non scorge né si cura delle badanti che sempre più numerose li accompagnano e senza delle quali oggi la famiglia – croce e delizia di una identità italiana ormai tutta inventata - non potrebbe pensare di resistere e rigenerarsi. Quando si sporge sugli «altri» in Europa, mette immediatamente le mani avanti: «l’inclusione può proseguire solo «se gli “altri” cessano di essere “altri” e diventano “noi”». Di botto costruisce gerarchie. Immagina e propugna un’altrui disponibilità al nostro comando illusoria e pericolosa.
Ricette e figure simili, purtroppo, hanno corso e fortuna non solo nel nostro paese. La destra che più di recente si è fatta avanti vittoriosa in Europa rivela cromosomi e propositi non dissimili. Persino negli USA si sono accorti del vento nuovo che ha spazzato assieme a tanta parte d’Europa, Canada e Australia. Dalle colonne del «New York Times» (9 maggio) è stato David Brooks, un opinionista conservatore molto attento alla scena europea, a segnalare la novità del Conservative Revival - una politica più attenta alla società e ai suoi legami, alla tenuta della comunità - e a raccomandarlo ai repubblicani di casa propria.
In Italia abbiamo cominciato a farci i conti, sospesi tra i vapori dei sogni sfumati e lo schianto della sconfitta. Non aiuterà a riprender coscienza e voce né la corsa ad occupare un presunto spazio bipartisan né la conta dissennata dei pochi, saldi e vocianti sulle macerie comuni.