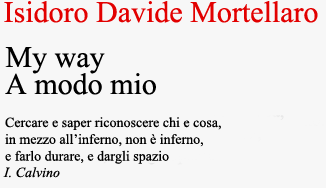Cambio di stagione. Europa e Mediterraneo alla prova del XXI secolo, in «Democrazia e diritto», n. 3, 2005, pp. 66-81.
La tempesta
Di Francia e d’Olanda una salutare tempesta è venuta ad abbattersi sul tentativo di eternare il regolo inventato a Maastricht a cardine di una nuova e più larga Carta costituzionale. L’«Europa ad una dimensione» ha fallito la prova di una più compiuta e sentita legittimazione. Accurati e più recenti scavi demoscopici hanno rivelato in particolare come, in Francia, proprio tra i più giovani - quelli con meno di 25 anni - il no abbia ottenuto più del 60% dei voti[i]. A far difetto non è stata la chiarezza sul passato d’Europa e sulle sue radici, ma la capacità di prefigurare un futuro accettabile. L’oscurantismo non era tra gli elettori ma in un progetto incapace di conquistare ad un domani condiviso.
Certo, nei Trattati cosiddetti costituzionali posti al vaglio di popoli e parlamenti c’è o c’era anche altro: anche diritti di valenza e conio nuovi nei territori aperti o invasi da scienza e comunicazione. Ma è altrettanto indubbio che l’imperativo volto all’edificazione del mercato unico, secondo il catalogo di regole titolate alla libera concorrenza e alla stabilità dei prezzi, è al centro di quella costruzione e ne ordina unilateralmente valori, gerarchie e mezzi. Per sincerarsene può bastare uno sguardo all’ordinamento che disciplina euro e Banca Centrale Europea, BCE. Sganciati da ogni obbligo o giuramento, si muovono in forme compiutamente autoreferenziali, fino all’assurdo – unico al mondo – di legare le mani di un futuro potere costituente, subordinato ai voleri e pareri della BCE. Come infatti si può utilmente leggere agli artt. IV-443 e ss. dei Tratttati, i costituenti che un domani volessero avventurarsi nella riscrittura della parte di Costituzione dedicata all’unione monetaria dovrebbero obbligatoriamente ascoltare il parere della Banca. A ulteriore conferma di questa centralità e autonomia conquistata dall’economico-monetario, sta lo stato minoritario in cui vengono confinati i «diritti sociali»: figli di un Dio minore, sono riconosciuti solo se non danno vita a ulteriori obblighi o poteri comunitari e in un ambito rigorosamente nazionale, ovvero evirati a variabili dipendenti di bilanci nazionali e spesa pubblica meccanicamente compressi da patti di stabilità e divieti.
La tempesta attivata sul Vecchio Continente dagli apprendisti stregoni di terzo millennio – una lega di instabile tenuta fatta da leader nazionali ed eurocrazia comunitaria - rischia ora di frangersi ben più lontano e più in alto dei lidi che ora flagella. Vale allora la pena di chiedersi – intanto qui in Italia, dove il dente più duole, dove la crisi del rapporto con l’Europa matura all’ombra di un unanimismo europeista di facciata - se da questa salutare bocciatura verrà ossigeno per difendersi dall’attacco più che decennale portato in tutta Europa alle carte costituzionali o allo stato sociale in esse incardinato, prova vivente dei nuovi confini su cui le democrazie nate dall’antifascismo si erano spinte per buona parte del secondo Novecento. La domanda rischia di avere una risposta negativa visto che le tempeste di Francia e d’Olanda hanno colpito duro soprattutto a sinistra, si sono abbattute con più forza sui reparti laschi e rissosi delle sinistre europee. Per gran parte, nella loro componente maggioritaria e moderata, esse sono finite azzittite nella bocciatura calata sul verbo di un’Europa contronatura, programmaticamente volta allo smantellamento di una civiltà e di una socialità entro cui era nato e si era sviluppato, all’indomani della «guerra civile europea», il messaggio comunitario originario. Né salute migliore vanta la sinistra da subito schierata – sia pure lungo una differenziata panoplia di motivazioni - su un netto antiliberismo, per un no risoluto ai Trattati: da questo versante, infatti, non si è saputo vivere il no come processo di costruzione di unità e identità più larghe, non tanto politiche ma financo culturali. Sono prevalse invece divisione e frammentazione ulteriori tra i laudatori della sovranità nazionale e coloro che vedono potenzialmente nella crescita di un’altra Europa la tappa di un nuovo internazionalismo.
Le recenti elezioni in Germania hanno confermato queste tendenze. La sinistra tedesca è tornata a dividersi, a beneficio dello schieramento moderato, e il cancelliere Schröder è riuscito infine a conquistare una rimonta finale per la SPD, ma con l’espediente miracoloso di farsi alla fine oppositore di se stesso, cucendo miracolosamente sulle spalle dell’antagonista, Angela Merkel, tutte le paure e le angosce che la propria piattaforma di riforme – l’Agenda 2010 – aveva suscitato. Il probabile sbocco in una riedizione della Grosse Koalition sospende un punto interrogativo epocale sulle direzioni di marcia che saranno impresse a parte grande del cuore d’Europa. Tanto meno fa luce o chiarezza la conclusione impressa alla questione dell’ulteriore allargamento dell’UE alla Turchia. Nella fase finale la quadratura dei conti è stata ottenuta grazie ad un intervento decisivo degli USA e del segretario di Stato, Condoleezza Rice. Ancora una volta sono essi, nei momenti decisivi, a supplire in Europa alla mancanza del necessario lievito o puntello costituente. Ne è uscita fuori un’agenda di lavoro che disegna un assai intricato percorso per il prossimo decennio. Si intravede un’Europa a maglie molto lasche, ben disposta a ulteriori allargamenti: più centrata insomma sulla predisposizione di una sintassi dei rapporti con l’altro che sulla delineazione di sé nel mondo, di una identità e di un progetto. Ora fuoco e difficoltà sembrano aver cambiato di campo. Gli sponsali sulle rive del Bosforo si sono trasformati in un esame esigentissimo e difficile non già per i Turchi, ma per ogni partner comunitario alle prese con elettorati riottosi e nuovi referendum. E’ a Istanbul che ora campeggia l’interrogativo epocale: ce la farà la Vecchia Europa, l’Old Europe?
Con questi chiari di luna è difficile che – sia pure con il concorso di movimenti e forum sociali, oggi più attenti di ieri alla dimensione europea e sovranazionale - s’accenda da subito la scintilla di un altro costituzionalismo, magari accentrato attorno al ruolo propulsivo del parlamento europeo. C’è da temere piuttosto una nuova stagione di quella immaginazione costituente di cui da Maastricht in poi hanno dato prova classi dirigenti ed eurocrazia europee e di cui, non a caso, è stato maestro ed interprete ineguagliato Guido Carli, reggitore per decenni di Bankitalia, presidente di Confindustria, ministro del Tesoro: protagonista e primo attore, per la delegazione italiana, della trattativa che nella cittadina olandese doveva sfociare nell’invenzione dell’Unione europea. Memorabile l’ invettiva contenuta nelle sue memorie contro una classe dirigente svagata, finita impiccata non all’albero di Mani pulite, ma nel cappio annodato a Maastricht, vera pietra tombale del caso italiano: tanto dei suoi vizi quanto della sua Costituzione, di quegli imperativi che la volevano fondata sul lavoro e sull’obbligo a rimuovere le condizioni che ostacolano l’avvento delle classi lavoratrici a classi dirigenti. Né è possibile dimenticare o passare sotto silenzio l’ elogio elevato da Carli a quel vero e proprio «colpo di stato» compiuto a danno del Parlamento italiano dalla delegazione italiana alle trattative comunitarie culminate nel trattato di Maastricht: «ancora una volta, si è dovuto aggirare il Parlamento sovrano della Repubblica, costruendo altrove ciò che non si riusciva a costruire in patria … ancora una volta dobbiamo ammettere che un cambiamento strutturale avviene attraverso l’imposizione di un “vincolo esterno”». E di che proporzioni fosse il mutamento imposto al paese l’ex governatore di Bankitalia precisava senza indugi: il trattato di Maastricht «comporta un cambiamento di natura costituzionale» ovvero «l’idea di uno “Stato minimo”, un conflitto sociale che si snoda nel rispetto della stabilità dei prezzi, esaltando la nuda creatività del lavoro, la capacità di innovare, la flessibilità del lavoro»[ii].
Per paradosso si può dire che da Maastricht in poi si è provveduto a cambiar di spalla al fucile. Gli imperativi eternati in quei trattati e in quelli che li hanno seguiti - fino alla Costituzione partorita da Giscard d’Estaing e dai suoi pari - ora obbligano Unione e Stati a rimuovere non più gli ostacoli alla libertà e all’eguaglianza di donne e di uomini: così come si prescrive all’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche in disposizioni similari delle altre Carte nazionali. Al centro dell’obbligazione, della nuova regolazione sovranazionale ora vi sono la fluidità e libertà del mercato: adesso si fa obbligo a rimuovere quelle ruggini, quell’eurosclerosi – un modello di civilta e socialità, invero – che frena la competizione, fa attrito rispetto alla libera espressione e al fluido movimento dei mercati. E’ stato questo ribaltamento che ha messo in mora, in parentesi, ibernato insomma le costituzioni nate dalla lotta e dalla temperie antifasciste: per noi la Costituzione repubblicana del ‘48. In questo modo si è costruito un universo normativo alternativo rispetto a quello consegnato nella prima parte della Carta, soffocata ormai e ostacolata ad esprimere il suo vecchio messaggio, azzittita nella nuova più larga casa comunitaria: avviata anch’essa in un percorso altro persino da quello che, come Comunità economica europea, CEE, ne aveva caratterizzato i primi passi nell’involucro atlantico.
L’immaginazione costituente
Con l’invenzione del vincolo esterno Carli e l’europeismo elitario di fine secolo seppero dal loro punto di vista far buon uso dell’immaginazione costituente: una pratica cui spesso avrebbero dato corso nei quasi quindici anni successivi. Guardando con occhi e riferimenti italiani a quella capacità creativa nelle sue applicazioni di lungo periodo – ma cambiando di osservatorio, prendendo ad esempio altri paesi, il risultato non muta se non per i riferimenti testuali – essi hanno saputo strappare alla sinistra uno dei suoi capisaldi, addirittura l’art. 11 della Costituzione, per piegarlo ad un uso partigiano, per farne lo strumento di una immensa e duratura rivoluzione passiva. Elementare ma ingegnoso il meccanismo messo in opera più volte e sui terreni più svariati: dai vari trattati comunitari di Maastricht, Amsterdam, Nizza, a quelli di adesione al WTO. Quasi trionfale poi l’opera di ristrutturazione compiuta sul vecchio corpo della Nato. Grazie agli interventi nei Balcani, si è potuto archiviare la vecchia Alleanza atlantica della guerra fredda, strategicamente e programmaticamente collocata in difensiva, e trasformarla, novella Araba Fenice, in una nuova organizzazione ormai concepita, nei suoi ultimi, incrementali sviluppi, come braccio armato dell’Occidente, strumento flessibile da impugnare nelle guerre preventive programmate per il XXI secolo. Ogni volta si è agito con un meccanismo elementare, ma di straordinaria efficacia: si è come spezzato l’art. 11. Della prima parte – «l’Italia ripudia la guerra» – si è provato a sbarazzarsi, quasi con vergogna per il pacifismo di un tempo, annegandola nel dimenticatoio e nel silenzio tutte le volte che da alleati più che volenterosi ci si è affiancati agli USA nelle nuove guerre globali. Della seconda – «l’Italia acconsente alle cessioni di sovranità …..» – si è fatto uno scalpello per smantellare la vecchia Costituzione, volta a volta annegata in patti sovranazionali tutti improntati al neoliberismo trionfante o alla predisposizione dei nuovi scenari geopolitici e strategici affermati dal ritorno della guerra. Il tutto lontano dagli occhi e dall’azione di Parlamenti, forze politiche e sociali e magari spesso nascondendo – come per il nuovo Concetto strategico della Nato, reinventato a Washington nell’aprile 1999 – la sottoscrizione di nuovi trattati contrabbandati come semplici aggiornamenti dei vecchi obblighi internazionali.
E pensare che quell’art. 11 rappresentava un tempo l’ambizione ad edificare non solo un’altra Italia, ma addirittura un nuovo mondo, grazie ad una estensione della sovranità ben oltre gli ambiti nazionali, ma esercitato in comunione con altri popoli e stati e soggetti in nuove configurazioni sovranazionali. L’immaginazione costituente del tempo sapeva pensare le Nazioni Unite o le nuove creature messe in campo a Bretton Woods: Fondo Monetario e Banca centrale. Dopo sarebbero venute la CEE e l’OCSE, e poi il G7 e la WTO, ma soprattutto la rivoluzione neoliberale che, alla fine degli anni Settanta e con ancor più vigore all’indomani dell’89, avrebbe mutato l’orizzonte di riferimento di questi nuovi attori, trasformati quasi tutti in leve del mercato mondiale e dei suoi imperativi di crescita e d’accumulazione.
Oggi, all’indomani dei pronunciamenti di Francia e d’Olanda e della decisione di Blair di rinviare sine die l’appuntamento referendario della Gran Bretagna con la nuova Costituzione europea, si chiude di fatto il ciclo aperto quasi un quindicennio fa dai trattati che a Maastricht davano vita all’Unione europea. Assieme rischia di celebrarsi – come il 7 giugno 2005 «Le Monde» ha titolato un suo editoriale - La morte di una idea. Sono stati 15 anni tumultuosi che, da un punto di vista europeo, si possono utilmente leggere lungo l’inesausto ed incompiuto tentativo delle élites eurocratiche di legittimare costituzionalmente l’UE, una creatura nata sbilenca – per il prepotere del comando monetario – e avvertita minacciosamente da gran parte dei popoli europei come attentato al modello europeo di civiltà consegnato nelle varie configurazioni nazionali di Stato sociale: una sorta di New Europe volta contronatura a contrastare l’Old Europe, ovvero a dissolvere proprio i tratti originali in forza dei quali forse è possibile parlare di “popolo europeo”, rintracciare cioè una peculiare qualità sociale storicamente divenuta timbro e voce unitari di popoli e comunità. Si potrebbe ricordare come ad Amsterdam nel 1997 si provò a includere i capitoli del lavoro e dell’inclusione sociale nei trattati. Ne nacque il «patto di stabilità e di crescita», divenuto tristemente noto e passato alla storia sfortunatamente solo con la prima specificazione. Della crescita ancor oggi si fatica a trovar traccia. A Nizza si provò a colmare la lacuna – per dir così - dei diritti: fu partorita una Carta contraddittoria e monca, soprattutto sul fronte di quei diritti sociali che costituiscono il lascito, il contributo più significativo e forte del Novecento al ripensamento di libertà e eguaglianza e all’allargamento delle loro storiche frontiere. Di lì al tentativo successivo di elaborare una Costituzione il passo è stato breve e il lavoro - al chiuso di una Convenzione classicamente octroyée, organizzata dall’alto e per questa forma legittimata – relativamente semplice. Tutto si è complicato, quanso si è passati all’esame dei popoli: lì hanno preso a regnare turbolenza ed inquietudine.
Nei marosi di questa storia, in questo quindicennio, sono già affondate tutte le classi dirigenti che a Maastricht avevano contraddittoriamente osato pensare i termini di una nuova autonomia europea, postbipolare. Nessuno dei leader protagonisti di quel passo, nessuno di quei firmatari è politicamente sopravvissuto. Né alcuno dei loro successori è rinsavito di fronte all’inequivoco tornado accumulato sui cieli d’Europa. Tutti, allievi e maestri, sono caduti come apprendisti stregoni incapaci di padroneggiare le potenze messe all’opera, i meccanismi posti al governo della nuova creatura comunitaria. Istruttiva in merito è la vicenda dei criteri di convergenza economica, posti a presidio dell’unificazione economica e monetaria, ovvero della nascita dell’euro, e del successivo «patto di stabilità», retto da parametri ben precisi di deficit nei bilanci pubblici e di debito pubblico: materie tutte assunte, nella concreta struttura e lettera dei trattati comunitari, come princìpi di rango costituzionale. Di fatto, le istituzioni europee - in controtendenza rispetto ai gradi di libertà, informalità e flessibilità tanto dell’impresa capitalistica, soprattutto nelle sue evoluzioni transnazionali, quanto delle istituzioni nuove affermatesi dopo gli anni 70 con l’avvento del nuovo ciclo di globalizzazione – rivelano tratti di assoluta rigidità. Il nuovo gigante ha voluto quasi nel nascere legarsi le mani, rinunciare alla potenza del politico: o meglio l’ha confinata negli automatismi che conformano e reggono l’euro e la Banca Centrale Europea, concepita fin dall’inizio come dominus e motore dell’unificazione continentale. Attorno a questi dominii e imperativi, l’intera impalcatura istituzionale europea ha finito con il soffrire di mancata elasticità, di una complessiva rigidità costituzionale. L’automatismo istituzionale è stato concepito come una sorta di cura dei tratti di incertezza e mancata legittimazione, via via ribaditi e sofferti man mano che ci si è inoltrati ad Amsterdam, Nizza e nell’ultima Convenzione a Bruxelles nel tentativo di conquistare ai nuovi edifici dell’UE il favore di vecchie e nuove comunità, progressivamente ammesse al desco della nuova famiglia europea. L’Europa tutta si è immersa così, per un intero quindicennio, in una sorta di Costituente ininterrotta, continuamente protesa, per cerchi concentrici sempre più larghi, a guadagnare il favore di parlamenti e popoli, ma senza quei poteri e strumenti che elasticamente consentono alle istituzioni di dialogare con comunità e soggetti sociali e politici. Da questo punto di vista, approfondendo il punto d’analisi offerto dall’euro in rapporto soprattutto alla flessibilità e capacità manovriera sfoderate in questo periodo negli USA dalla Federal Reserve e da Alan Greenspan nel governo del dollaro, si potrebbe paragonare l’Unione europea ad una sorta di eunuco della storia alle prese con l’ingresso nel Terzo Millennio, ovvero privo degli strumenti fondamentali – promozione e governo della spesa pubblica, leva monetaria – su cui si sono costruite e hanno prosperato nel Novecento le democrazie del secondo dopoguerra o con i quali provano a lasciare la loro orma sul XXI secolo vecchi e nuovi protagonisti della scena globale.
Del resto, su un altro versante, proprio l’Italia più recentemente ha costituito in vitro il laboratorio più limpido per rilevare – con le vicende relative a Bankitalia e al suo governatore, Antonio Fazio - come le rigidità costituite a salvaguardia della BCE e del Sistema europeo delle banche centrali si siano ormai mutate in uno straordinario accumulo di poteri sottratti a controllo e in una zona franca foriera di straordinari conflitti istituzionali, nazionali e sovranazionali.
Alle soglie di un’epoca nuova
All’alba del Terzo Millennio l’immaginazione costituente, sfoderata sul finire del 900 dalle classi dirigenti europee, non può che esibire un bilancio contraddittorio. All’indubbia efficacia sul piano interno, soprattutto nella destrutturazione neoconservatrice dei vecchi equilibri sociali e politici, non corrisponde un risultato analogo sul piano globale, sul fronte esterno. Il ritorno della guerra sulla scena mondiale non è stato contrastato dall’emergere di una Politica estera e di sicurezza europea, PESC. Anzi, come ben rivela la vicenda penosa della riforma dell’ONU, l’eventuale conquista da parte della Germania di un seggio di membro permanente ad un rinnovato e più largo Consiglio di sicurezza, affollato di europei, potrebbe segnare l’addio definitivo ad una presenza internazionale vera ed autonoma dell’UE. Del resto, sui vari campi di battaglia che hanno oscurato il tramonto del 900 hanno prevalso quasi sempre allineamento e acquiescenza all’amico americano: dal Medioriente ai Balcani. E poi divisione e incertezze quando il XXI secolo si è aperto all’insegna della guerra al nuovo terrorismo, al nuovo nemico globale indicato all’Occidente da Bush II e dai neoconservatori: divisione e incertezze puntualmente riflesse nell’incerto dettato partorito in materia dalla Convenzione e come tali stigmatizzate dai pronunciamenti popolari.
Quanto alla scena globale determinata dalla configurazione dei flussi di competizione e interscambio internazionali e dalle nuove frontiere su cui il mondo si va attestando, l’Europa non si rivela un attore-protagonista, un front-runner. La sua presenza nel mondo oggi non mostra capacità alcuna di determinare o influenzare la corsa con i suoi tassi di crescita, tanto meno di indicare una via altra da quella che, stressando rovinosamente il pianeta, lo dispone in un dumping planetario a detrimento dei diritti dell’umanità e della vivibilità generale. Come comprimario di un palcoscenico globale in cui le luci si focalizzano sempre più ad Oriente, sul Pacifico, l’Unione europea si ritrova in affanno ad arrancare dietro vecchi e nuovi primattori. Anche di quest’affanno, di questo timore per i nuovi, grandi spazi spalancati dal nuovo ciclo di globalizzazione, si è nutrito il no depositato nelle urne francesi ed olandesi. L’elettore europeo soffre di agorafobia, della dilatazione di orizzonti aperta da una Cina oggi veramente «vicina» e da una scienza che invade e slarga la vita aprendola a metamorfosi e su soglie inedite. Al contempo la cura predisposta dal consulto medico allestito con la Convenzione per una nuova Costituzione europea gli appare impari e sottodimensionata rispetto alla sfida maturata sul campo ma costosa e sovradimensionata in termini di rinunce e sacrifici.
Finisce con il prevalere così soprattutto la destrutturazione: tanto delle identità nazionali quanto delle soggettività politiche. L’incapacità ad immaginare e tratteggiare il futuro sembra oggi il tratto decisivo d’ogni famiglia europea: direttamente sul piano culturale, prima ancora che sulla scena politica. Emblematica la discussione vivacissima e a tratti divaricante registrata sul piano dei principi primi dalla richiesta soprattutto della Chiesa cattolica di inserire in Costituzione un richiamo all’identità e alle «radici cristiane» dell’Europa. A colpire non è tanto il terreno scivoloso, di chiusura all’altro, rivelato da assunti simili – continuamente esposti al rischio che la radice cristiana dell’Occidente finisca nascosta e fagocitata dall’apposizione di un marchio occidentale sul Cristianesimo – quanto il radicale spostamento di segno e significato impresso alla discussione sulla Costituzione. Questa, per lo meno nell’esperienza più moderna, è sempre stata nell’essenziale il patto per il futuro di una comunità che, in questo giuramento, si riconosce e costituisce, appunto, lungo un percorso di obbligazioni comuni. Discutere di radici rischia non solo di scartare ciò che istituisce una soggettività in rapporto al mondo che la circonda, ma di volgere lo sguardo al passato, dove – soprattutto per l’Europa – imperano e ingombrano macerie, divisioni e rotture, tra etnie, religioni e nazioni, ma dove soprattutto il Novecento si è mostrato con il volto orrifico della «guerra civile».
Sul piano più direttamente politico prevale soprattutto la destrutturazione, a vari gradi e livelli, d’ogni famiglia o raggruppamento politico. Persino il neopopulismo – assurto a destra a nuova fortuna sfruttando proprio l’ansia suscitata dall’emergere di nuovi spazi sovranazionali – non riesce a scampare la crisi di legittimità giunta, dopo i referendum, a proporzioni clamorose. Prima ancora che Berlusconi, finito a mal partito purtroppo assieme all’Italia, il caso più emblematico riguarda Jacques Chirac. Aveva teorizzato la necessità di «colmare la frattura» tra popolo ed élites, facendone il tratto distintivo della propria presidenza, del tentativo di rinnovare i fasti del gollismo. E’ finito egli stesso disarcionato dal fantasma evocato e cinicamente cavalcato. Una prima volta, alla fine del 1995, quando con il governo Juppé si era repentinamente convertito ad una politica di privatizzazioni dello Stato sociale e dei suoi istituti fondamentali, prima tra tutti la Sécu, il regime di «sicurezza sociale». Ora, chiedendo un voto per la Costituzione europea accompagnato da una sorta di richiesta di moratoria sulla cosiddetta «direttiva Bolkestein»: insomma la prova provata dei pericoli nascosti e veicolati dalla nuova armatura istituzionale europea.
Vero è che la destrutturazione morde soprattutto a sinistra. Qui un no sacrosanto all’assetto neoliberale prefigurato in Costituzione non sta tenendo a battesimo la nascita di nuovi soggetti, augurabilmente continentali. Piuttosto sta contribuendo potentemente a seppellire nelle varie fosse nazionali le vecchie soggettività e forme politiche e sociali. E’ così tanto per la sinistra che, assunto dall’89 l’obiettivo dell’Unione europea in sostituzione del vecchio «Sole dell’Avvenire», è finita silente tra i corifei dell’euro e della Banca centrale, quanto per quella cosiddetta «radicale» o «alternativa». Anche qui la ricerca di un’«altra Europa» non ha prodotto un’unificazione culturale e politica, non ha colmato la frattura tra coloro che nelle forme della politica nazionale vedono le colonne d’Ercole della politica possibile e quanti scorgono nell’Unione europea la palestra di un’altra globalizzazione
Per questa via si rischia di consegnare spazio ad una seconda stagione dell’«immaginazione costituente», ad un nuovo protagonismo su scala continentale di «lor signori». In questa direzione, del resto, ha nettamente puntato Tony Blair nell’assumere la presidenza dell’Unione europea, a dimostrazione del fatto che la crisi evidente del costituzionalismo europeistico non suona sciagura a tutte le orecchie. Non ha fatto finta di nulla, semmai con sapiente rilievo ha evidenziato l’impasse e soprattutto indicato una via d’uscita ben precisa: l’Europa ha bisogno di «adattare il modello sociale europeo al mondo del XXI secolo». Messa in naftalina la Costituzione formale - «comprensibilmente bocciata nei referendum in due Stati fondatori», come ha detto nel discorso di indirizzo al Parlamento europeo del 23 giugno 2005 – ha puntato direttamente la mira sulla Costituzione materiale, sulla necessità della cosiddette riforme strutturali. Sì ad un’Europa sociale, ma «un’Europa sociale adeguata al mondo di oggi». «Chiudendosi a riccio di fronte all’immensa sfida della globalizzazione, le nazioni europee si sottraggono alle trasformazioni che ci circondano, si rifugiano nelle politiche attualmente vigenti in Europa»: una via per Blair condannata al fallimento, assieme all’intero sistema del bilancio comunitario, ancorato alla difesa statica di interessi del passato, ad un antiquato e costoso sovradimensionamento della politica agricola. Nel mirino non sono tanto la Francia e Jacques Chirac, quanto ogni settore compiutamente integrato della politica comunitaria. Non a caso il discorso si impenna nell’elogio della flessibilità assunta come rimedio per ogni malanno o problema: dalla politica estera e di sicurezza comune all’allargamento, al ripensamento delle politiche di integrazione o dell’Agenda di Lisbona. In realtà, il leader della «terza via» sa bene che già nei vecchi trattati c’è largo spazio per le cooperazioni rafforzate, per chi sappia e voglia sfruttare fino in fondo le cooperazioni a geometria variabile. E in questa direzione già sono in atto grandi manovre, triangolazioni inconfessabili tra i Grandi e inestauste fantasie: tutti terreni sui quali l’italica «immaginazione costituente» si è come prosciugata, rinsecchita, fagocitata dallo sciovinismo di Bossi e Berlusconi, finiti al tavolo di Bruxelles con il cappello in mano di conti truccati.
Una vicenda illuminante
Proprio la questione del bilancio comunitario illustra al meglio quale sia la strada che l’Europa si appresta ad imboccare sotto la sferza di Blair e alla mercé dei Grandi Paesi, dei loro giochi e triangolazioni. Come è noto, la trattativa sul bilancio, sulla sua incidenza così come sulle sue voci, sui criteri di contribuzione e ripartizione, si è chiusa sul piano formale con un nulla di fatto. Dal punto di vista sostanziale l’Europa degli esecutivi e dell’eurocrazia si è come vendicata dello schiaffone ricevuto con i referendum, restituendolo con gli interessi. Le élites nazionali e comunitarie hanno provato tutte a recuperare il rapporto con il proprio retroterra. E così ogni protagonista è rimasto arma al piede in attesa del prossimo confronto, ben attento a difendere prerogative e interessi del proprio campo. L’egoismo fiscale dell’Europa nord-occidentale l’ha fatta da padrone, imponendo una trattativa attorno ad un bilancio comunitario – di un’Europa a 25 e passa membri - riparametrato all’1% del PIL comunitario. La Commissione europea – la più ardita di tutti – ha osato, tra mille accorgimenti, avanzare la proposta di spingersi fino all’1,21%. Prima ancora che dalle urne referendarie di qualsiasi paese, un’Europa vera, dotata di reali poteri di intervento, controllo e indirizzo, capace di rispondere in termini reali all’ansia da globalizzazione che ne scompiglia le fila e i reparti, è affossata da decisioni simili. E’ a questo livello che si decide la «costituzione reale» dell’Unione europea, che si determina la natura del rapporto tra Europa politica ed Europa sociale. Un bilancio ancorato attorno ad un 1% della produzione comunitaria, più o meno ricco di decimali, parla di un’UE ben precisa, costruita attorno ad un determinato rapporto tra finanze e politica, tra società e istituzioni: ovvero di una politica ben attenta a non dar vita in sede comunitaria a nessun potere orientato a liberare l’individuo dalla paura del futuro, tanto meno dai bisogni che lo angustiano.
Con questi parametri si vellicano gli egoismi fiscali dei paesi più ricchi e potenti, ma si costruisce un’Unione programmaticamente cieca nei confronti dei nuovi arrivati e di quei Mezzogiorni d’Europa che nel Mediterraneo incrociano altri mondi. La revisione dei fondi strutturali e di riequilibrio imposta da criteri di bilancio così egoistici e restrittivi stringe in un angolo i Mezzogiorni d’Europa. Li lascia nudi con la propria disperazione a fronteggiare i popoli dell’altra sponda con il viso delle armi. Rivela un’Europa con una faccia sola, avida di energia e di braccia altrui, di petrolio e nuovi schiavi: l’Europa della guerra, del pattugliamento dei mari, di nuovi muri. A Ceuta e Melilla si innalza il picco di uno «tsunami migratorio» – così lo ha battezzato strumentalmente Jean-Marie Le Pen[iii], chiamando alla difesa senza quartiere dall’invasione - che a ondate spazza il Mediterraneo intero e i suoi approdi rivaleggiando con l’uragano Katrina a New Orleand nel rivelare gli abissi di diseguaglianza e le barriere che abitano l’area mediterranea.
Interno ed esterno si tengono, come facce di uno stesso processo. Nel decidere delle proprie viscere, l’Unione europea decide del proprio rapporto con il mondo e del proprio futuro. All’inverso orientarsi in rapporto al Mediterraneo e ai tormenti che ne torturano le coste decide della natura dell’Europa, dei suoi fini generali, del suo rapporto con il mondo. Su questo terreno, però, è venuto il momento di fare i conti con la realtà: per incamminarsi realmente nella costruzione di un’altra Europa, prefigurare materialmente il futuro, c’è bisogno di incrociare il Mezzogiorno e il Mediterraneo concreti, mutati ormai profondamente dall’ingresso nel XXI secolo. Memoria e sogno sono dimensioni naturali e ineliminabili della politica. Assicurano ancoraggio al mondo circostante e quella dimensione utopica senza della quale si viene risucchiati dalle derive più cupe dell’esistente. Ma rischiano anche di portarci fuori strada, quando non in sincrono con le vicende e i soggetti lanciati sulla scena da una storia in precipitosa evoluzione.
Nuovi scenari
Da tempo le terre del Sud e i loro mari hanno dismesso i panni del passato o smentito le vulgate immaginifiche di un mondo avviato a fratellanza e pacificazione sicure da mercati e finanza sgombri da ostacoli. E’ vero anche che il nostro Mezzogiorno è molto mutato, smentendo però in gran parte la vuota retorica di chi ha creduto di vederlo ormai sanato come maleodorante ferita di una unificazione nazionale particolare e imperfetta. Il «paradiso abitato da diavoli» - trasmessoci come fantasmagorica immagine dai viaggiatori che per secoli si sono avventurati a Sud – è sparito da tempo, sicuramente smarrendo o deturpando gran parte delle vantate bellezze, ma rivelando nel contempo nuove demoniache presenze e attività.
Del vecchio Meridione magnificato o maledetto nella triade «spaghetti, chitarra e mandolino» non esiste più nulla. Anche a ‘Mezzogiorno’ a tavola ormai da tempo non domina più, ossessiva e puntuale, la pasta. Anche lì arriva irresistibile il melting pot mediterraneo. E così, alle soste di serate e movide meticce come mai o ai tavoli di famiglie allargate, complicate e colorate da colf e badanti, troneggia sempre più frequentemente il cous cous. Metamorfosi e trionfo di semole e grani, certo. Ma quasi sempre coltivati altrove, lontano dalle terre che contornano il «mare di mezzo». Il più delle volte marchiati a stelle e strisce o dal canguro australiano. Oggi, persino la pasta arriva spesso ad esser condita da conserva o sugo di pomodoro made in China.
La stessa famiglia - croce e delizia della storia italiana e soprattutto meridionale – è stata costretta a reinventarsi. Per resistere in una società sempre più asciugata di socialità e di welfare, ma assillata dai nuovi, crescenti bisogni dei più giovani come dei più anziani, ha ora essa bisogno di supporti, per potersi riprodurre, allargata e colorata. Colf e badanti la provvedono di quelle attenzioni e cure, di quelle «coccole» non assicurate altrimenti da uno Stato sociale sempre più rado e costoso o da individui ricollocati altrove per gran parte del proprio ciclo vitale o professionale[iv].
Produzione, vita e mercati si sconnettono sempre più nel Mediterraneo di Terzo Millennio. Con le loro nuove complicazioni denunciano l’arrivo dell’Era del Pacifico. Il mondo tutto si sta riposizionando su nuovi cardini e per nuovi canali di comunicazione, investimento e scambio. Il Mare nostrum tutto e dentro di esso il Mezzogiorno rischiano ancora una volta di rotolar giù per le gerarchie che innervano il mondo e la divisione internazionale del lavoro. Una storia millenaria, al centro del mondo conosciuto dagli occidentali, non assicura un futuro glorioso. Può capitare di sprofondare. Magari senza accorgersene. Accadde già una volta, quando la scoperta dell’America, inaugurando l’era atlantica, derubricò a capitoli di storia e gloria passata «Via della Seta» e «Repubbliche marinare».
Oggi più di allora il declassamento rischia di farsi arretramento e marginalità secchi, quando non caduta rovinosa. Soprattutto se dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo non verrà risposta, capacità di sanare la ferita che si è aperta nel mondo con la «guerra al terrorismo», ma anche di intervenire, per orientare la crisi dichiarata del processo di integrazione europea. Il nuovo «vaso di Pandora» scoperchiato da Francesi e Olandesi può rivelare le potenze di un’altra possibile Europa, ma anche il malmosto dell’egoismo fiscale, di sciovinismo e xenofobia. Una UE dell’1%, dai bilanci minimi e leggeri ma con un corpaccione a 25 e passa soci, è una Europa estranea al Mediterraneo, dimentica del suo Sud. Parigi e Palermo, così come Amsterdam e Algeri, sarebbero condannate a farsi tanto lontane da divenire ancor più straniere e incomunicanti. Del Mediterraneo rischia di rimaner padrona la Nato – con il suo azionista di riferimento, gli USA – quella Nato avviata da qualche anno a ripensarsi come scudo e spada dell’Occidente assediato dai tumulti della globalizzazione e trascinato nel mare incognito della «guerra al terrorismo».
Il rischio della marginalità
Uno sguardo d’assieme all’intera area mediterranea chiarisce immediatamente la posta in gioco all’ingresso nel XXI secolo. Sulle sue coste s’addensano ora oltre 450 milioni di persone, rispetto ai 300 circa che la popolavano poco più trent’anni fa, nel 1970. Con la differenza sostanziale di una sponda europea che allora pesava per circa la metà – il 49,3% ad esser precisi – e che ora non arriva al 38% dei popoli mediterranei. In compenso stabilissimi si sono rivelati il controllo e il maneggio settentrionali di circa l’80% delle produzioni mediterranee. Queste però sono in caduta libera come quota della ricchezza globale. Secondo la World Bank esse nel 1980 pesavano per il 15,3% sul PIL mondiale, nel 2000 erano al 12%.
Se si potessero asciugare questi dati e flussi di quanto rende il Mediterraneo una polveriera incandescente - ovvero del prelievo quotidiano che l’Occidente e la sponda Nord esercitano in petrolio e nuovi schiavi – sicuramente il bilancio sarebbe molto più critico e allarmato. A munirci, comunque, di alcuni significativi indicatori provvede fortunatamente l’ONU, attraverso la compilazione annuale, iniziata nel 2002, dell’Arab Human Development Report. Essi ci avvertono che nell’area araba, in bilico tra Africa ed Asia ma disposta a raggiera sul complesso del Mediterraneo meridionale, tra Atlantico e Golfo Persico, si è addensato a fine secolo il 5% della popolazione mondiale: un insieme raddoppiato rispetto al 2,5% vantato cinquant’anni prima e frenetico nei suoi movimenti, tanto verso le nuove magalopoli che chiazzano quelle mappe, quanto verso l’Occidente. Più del 50% dei giovani arabi dichiara di voler emigrare verso il Nord industriale.
In tutt’altra direzione è andata la capacità degli Arabi di tener dietro ai mutamenti intervenuti nel mondo d’essere e di produrre del mondo. Nel 1960 la loro produttività media pro-capite era più alta di quella allora vantata dalle Tigri Asiatiche. Oggi è la metà di quella coreana. Nonostante il petrolio, aumenta dappertutto il debito estero, mentre l’agricoltura in stato comatoso – sottoposta a crescenti processi di privatizzazione delle terre e aree comuni – fa sì che la bilancia commerciale di molti paesi registri deficit clamorosi proprio nell’importazione di beni alimentari. Il lavoro è ricompensato da salari di fame, ma all’interno di filiere produttive arretrate. Il risultato è che la delocalizzazione di un tempo – dall’Europa alle rive dell’Africa – è crescentemente rimpiazzata dall’outsourcing di reparti e prodotti dal Marocco o dal Pakistan alla Cina.
E’ questo il frutto di una governance improntata alla perpetuazione – sulle spalle di giovani e donne e con la complicità dell’Occidente – di un patriarcato capace di traghettarsi e quasi eternarsi dal feudalesimo alla post-modernità. Ne è indice significativo il numero di libri tradotti in Arabo. In media si aggirano annualmente attorno ai 300: quanti ne traduce cioè in un anno la sola Grecia. Negli ultimi 1000 anni – afferma il rapporto sul mondo arabo dell’UNDP per il 2002 - sono stati tradotti in arabo tanti libri quanti ne traduce annualmente la Spagna. Le condizioni di miseria e deprivazione in cui versa l’Arab Street sono la diretta conseguenza della chiusura esercitata sulla mente araba da gran parte delle élites politiche e religiose.
A risultati non dissimili conducono i bilanci tracciati direttamente nei fortilizi dell’eurocrazia comunitaria. Dieci anni fa nel 1995 l’Europa si lanciava a Barcellona in una prospezione ambiziosa, un partenariato con i 9 paesi cosiddetti mediterranei, dal Libano al Marocco. L’intento era quello di promuovere una zona di libero scambio, sostenuta dall’intervento di fondi strutturali, per facilitare riforme, aggiustamenti strutturali e sviluppo. I bilanci più recenti sono disastrosi: «la crescita dell’intera regione è stata della metà rispetto al livello necessario a garantire l’occupazione dei più giovani. I redditi pro-capite, a sud e a nord del Mediterraneo, hanno preso ancor più a divergere piuttosto che iniziare a ravvicinarsi. Disoccupazione e povertà sono in espansione. Le riforme in ritardo»[v]. Per il prossimo appuntamento di Barcellona, previsto per il prossimo 27 novembre nella formazione in gran spolvero dei cosiddetti «Capi di Stato e di Governo», le idee scarseggiano. Se si vorrà continuare ad insistere nella strategia a senso unico del libero scambio di merci e capitali, vorrà dire che si vorrà disastrosamente continaure a fermare uomini e idee a Ceuta e Melilla.
In situazioni diverse la sponda meridionale europea sta affrontando sfide simili. Le condizioni particolari che nell’ultimo ventennio del Novecento avevano privilegiato i Mezzogiorni d’Europa come area elettiva di delocalizzazione post-fordista stanno saltando tutte. Cinesi d’Europa fatichiamo a reggere l’urto ora della Cina reale. Non si tratta più solo di approfittare di bassi salari e di non saper fronteggiare la svendita organizzata, a condizioni per noi proibitive, di braccia e cervelli. L’ingresso sulla scena globale dell’Asia, di giganti come India e Cina, segnala l’avvio di una fase storica completamente nuova: un sapere antico – molto simile a quel «saper fare» che per decenni ha perpetuato il miracolo del «made in Italy» - ora viene messo in rete, e con numeri giganteschi, da aziende transnazionali, rafforzate nella loro presa globale dall’opera di promozione di governi che della competitività internazionale hanno fatto il loro credo fondamentale e il principale terreno di legittimazione, all’interno come verso l’esterno. Da parte sua l’Europa non sa pensar di meglio che negare ai suoi Sud le risorse persino di riequilibrio e sopravvivenza.
E’ quest’urto epocale che sconvolge ogni parametro e che costringe a cercare nuove misure per il mondo che incalza. Come Europei siamo entrati nel secondo Novecento, nell’era dello Stato sociale e della democrazia avanzata, con un patto di ferro con gli USA, avvinti da un sistema a cambi fissi e decisi a seguire la stella polare di un modello politico, sociale e di consumi ribattezzato Occidente, atlantismo ecc. Oggi dal Pacifico giunge un immenso sconvolgimento, sospinto anch’esso da nuovi cambi fissi, da una seconda Bretton Woods, questa volta tra dollaro e yuan, e da nuove regole e convenienze. Dalle coste del Pacifico giunge una rivoluzione che, con un dumping sociale planetario, sta cambiando il volto del mondo e soprattutto relegando nell’archeologia le forme di regolazione pensate a Maastricht dalle élites europee.
Ripensare quei principi fa tutt’uno con il ripensare il rapporto intrattenuto dall’Europa con i suoi Sud e con il Mediterraneo. Lo sappiamo bene noi italiani. Per noi il Mezzogiorno, la qualità della sua vita democratica, innanzitutto, sono sempre stati un metro utile a valutare lo Stato complessivo del paese, la sua capacità di ammodernarsi e mutare. Oggi sono mutati solo i termini dell’equazione: ad un capo sta il Mezzogiorno immerso nel Mediterraneo, ma dall’altro ormai c’è tutta l’Europa e la sua capacità a farsi compiutamente, assieme ai suoi Sud, nuovo soggetto sovranazionale. Mai come oggi però questa operazione si rivela difficile. Mai come oggi si è fatta ardua la conquista anche di un solo alleato.
Viviamo in tempi di secessione, non solo territoriale, ma persino dalla modernità. Il «ritorno di Dio» che così prepotentemente marchia l’ingresso nel XXI secolo ci parla della crisi della politica e della democrazia ereditata dal tramonto del Novecento. Smarrite le misure moderne del mondo si ritorna alla religione nella speranza di ritrovarvi un metro ed un regolo utili. Oggi più che mai abbiamo bisogno di imporre all’ immaginazione costituente che ha finora spradoneggiato in Europa un salto di campo e di parole d’ordine.
Il ritorno della guerra al passaggio di secolo e d’epoca ci ha costretto ad aguzzare l’ingegno. Ne è nata un’interrogazione feconda su pace e nonviolenza che – sia pure tra mille distinguo – rappresenta oggi lo scalpello più acuminato con cui provare oggi a sbozzare una risposta concreta alla crisi della politica e della democrazia. Per vie analoghe è nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo concreti che bisognerà affondare le mani e l’ingegno per trovare il bandolo utile a districare la matassa europea.
10 ottobre 2005
[i] N. Gnesotto, Attention, danger!, in «Bulletin Institut d’Ètudes de Sécurité Union européenne», july, 2005.
[ii] G. Carli, Cinquant’anni di vita italiana, in collaborazione con P. Peluffo, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 7-9.
[iii] M. Le Pen parle de "tsunami migratoire" pour évoquer les enclaves de Ceuta et de Melilla, in «Le Monde» del 9 ottobre 2005.
[iv] Cfr. in merito i contributi raccolti in B. Ehrenreich – A. Russell Hochschild, Global Woman. Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, tr. it., Donne globali. Tate, colf e badanti, Milano, Feltrinelli, 2004.
[v] E. Le Boucher, Dire oui à la Turquie, au Mahgreb et aux autres, in «Le Monde» dell’8 ottobre 2005.